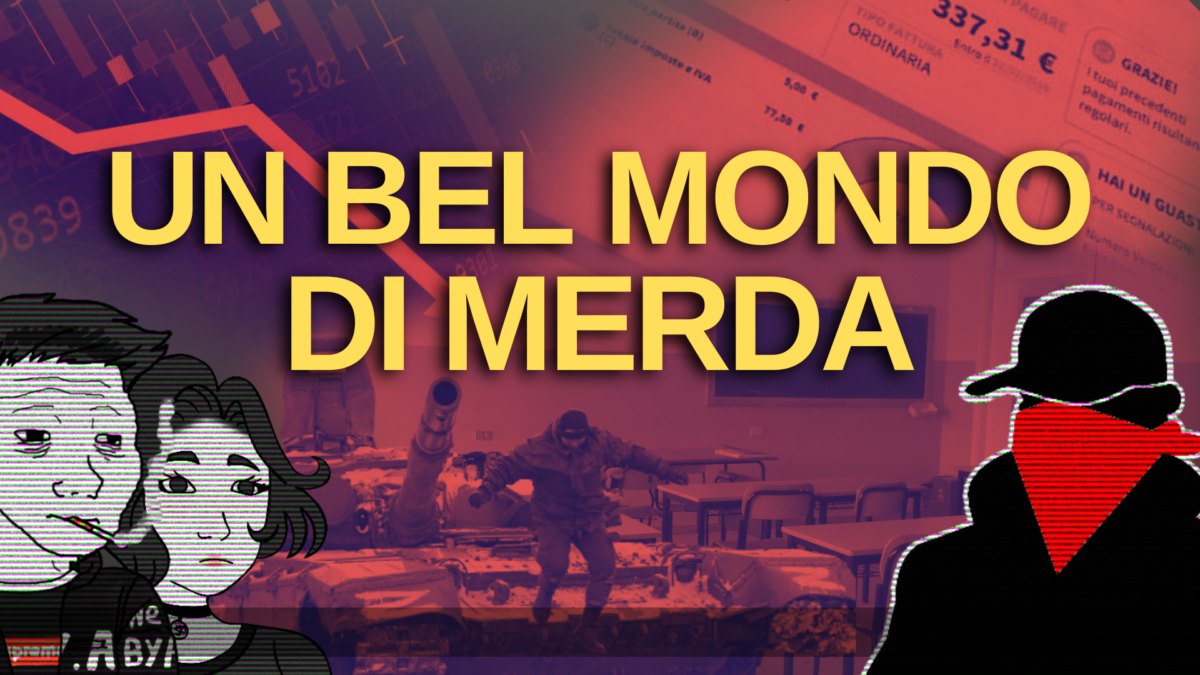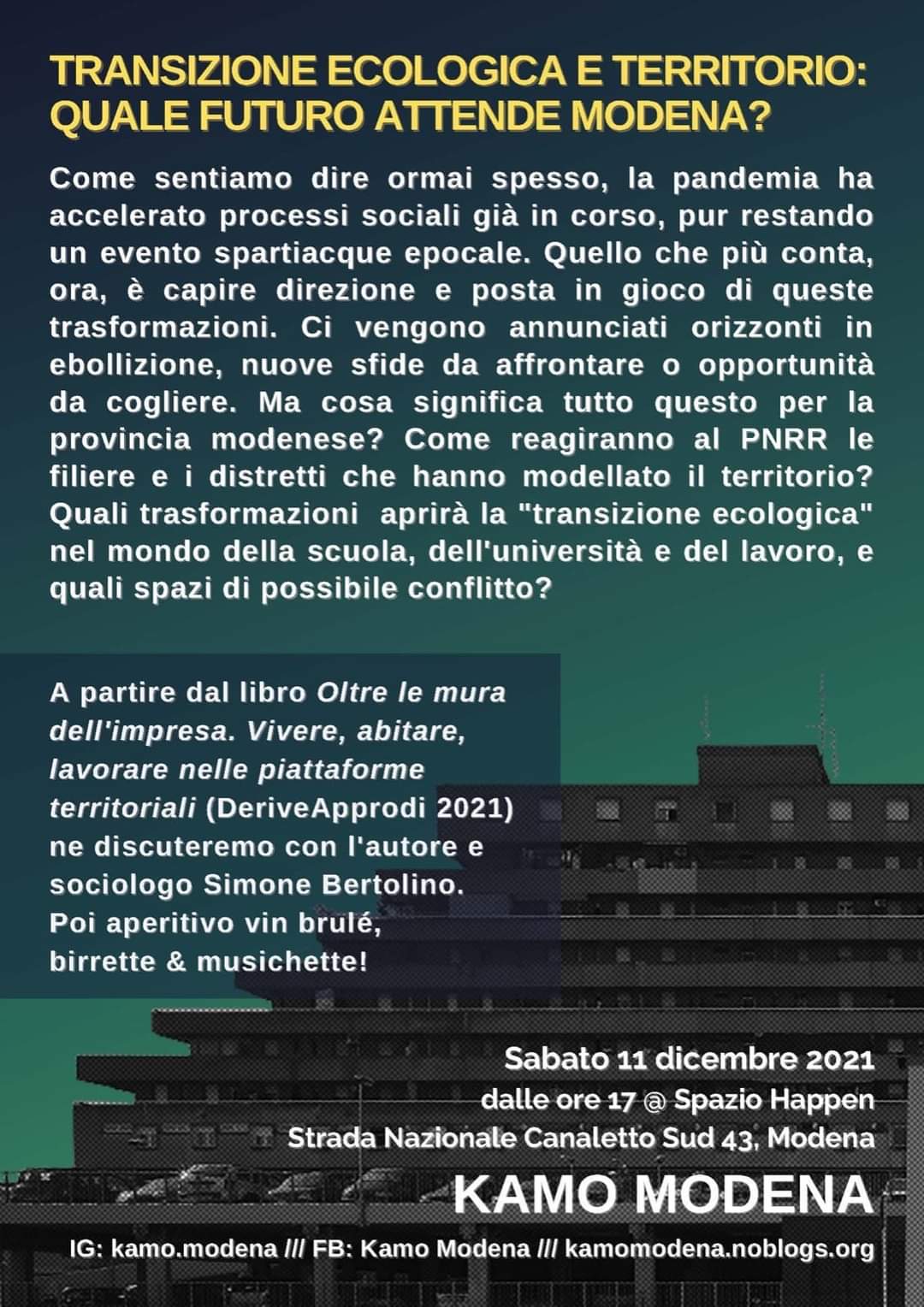«Stare in pace con sé, oggi, vuol dire entrare in guerra con il mondo».
Mario Tronti, Dello spirito libero.
Un bel mondo di merda, non c’è dubbio. Che la guerra sta portando sull’orlo della crisi di nervi. O viceversa.
Guerra. Crisi. Nervi. Dei primi due abbiamo già parlato. Il mondo di domani e il destino della globalizzazione; i figli della crisi e la scuola di oggi. Era giunta l’ora di parlare di nervi. Ansia, angoscia, sofferenza mentale. Un vissuto sempre più diffuso, quasi pandemico. Che sembra attanagliare soprattutto i giovani. O che essi – grazie alla loro età, unita a una maggiore consapevolezza e a una meno pressante assuefazione – riescono a far emergere in modo più radicale. Perché loro necessità, bisogno. Chi ci ha raggiunti, nonostante la stanchezza, le pressioni e l’ansia di un quotidiano senza tregua già a sedici anni, lo ha fatto non a caso, evidentemente.
Abbiamo voluto provare a costruire un punto di vista di parte. Il metodo che sempre ci muove: mettere in prospettiva, produrre discorso politico, stimolare formule organizzative. Ma prima di tutto, inchiestare. Individuare le domande, saper ascoltare. Tentare di trovare le risposte nel processo. Ci interessava una lettura politica dell’ansia, legata alle trasformazioni produttive, all’individualizzazione del disagio, alle nuove logiche del comando. Andare dallo psicologo va benissimo, ma non può essere una soluzione per problemi politici. Denunciare la catastrofe siamo capaci tutti, il difficile è capire con chi dobbiamo prendercela. Invece di diventare specialisti del malessere, rendere un’arma il punto di vista – lo sguardo parziale di chi, come militante politico, può rovesciare il proprio destino.
Il disagio giovanile c’è sempre stato. Perché oggi la forma organizzata, collettiva, sembra non essere più sentita come una risposta? Che tipo di aspettative stanno circolando nella composizione giovanile? Quanto sono diverse rispetto alle sue stratificazioni? E se le aspettative sono cambiate, cosa succede quando si apre uno scenario di guerra che ci riguarda da vicino, su differenti scale ma concreto? Sono alcune domande che ci hanno mosso. Con la consapevolezza che l’ansia, in qualche modo, ce la teniamo in questo mondo di merda, perché disfunzionali al sistema che ci produce. Ce l’abbiamo tutte e tutti in comune, chi più, chi meno, sicuramente in forme diverse.
E allora cosa ce ne facciamo? Come possiamo giocarcela insieme? Come cominciamo a farla venire ai padroni, a chi comanda, a chi ci vuole deboli, isolati e rassegnati? Lottare, lo sappiamo bene, ha sempre comportato ansia e inquietudine. Ma essere compagni, per noi, significa soprattutto questo: fronteggiarla insieme, rovesciandola in forza e militanza.
Pubblichiamo qui l’intervento di Antonio Alia, educatore e redattore della rivista «Commonware», che ha aperta la discussione del primo ottobre. Nonostante questo bel mondo di merda, buona lettura.
Antonio Alia
Ringrazio i compagni di Kamo per avermi invitato ad intervenire a questo dibattito. Dato che si parla di giovani e a farlo è un quarantenne, tenterò da un lato di non assumere un atteggiamento giovanilista, per cui tutto quello che fanno i giovani è buono di per sé, e dall’altro di evitare un certo paternalismo, per cui quello che fanno i giovani oggi è sempre sbagliato. Allo stesso tempo cercherò di barcamenarmi nel difficile ruolo di chi deve introdurre un dibattito sui giovani senza però parlare al posto loro, cercando di non spiegare a loro quello che probabilmente conoscono meglio di me. Vorrei quindi limitarmi a sollevare delle questioni, e a problematizzarne delle altre per aprire un confronto e verificare delle ipotesi.
Partirei dalla definizione di una parola che è stata usata nel testo di lancio di questo dibattito, non perché sia un esperto in materia ma perché mi sembra un modo utile per approssimare i problemi. La parola è ansia.
Parola che non è stata scelta a caso, perché da quello che mi raccontano amici e compagni che lavorano nelle scuole, ma anche da quello che viene raccontato sugli organi di stampa e rappresentato nelle serie tv, pare che l’ansia sia un tratto generazionale. Mi piacerebbe capire con voi, nel corso di questo incontro, se questo è un tratto effettivamente reale, quanto diffuso, quali le fasce giovanili maggiormente interessate, quali le cause ambientali, oppure se si tratta di una semplice rappresentazione mediatica. Certo va detto che deve essere sentito come un problema diffuso se la richiesta di servizi psicologici è stata presente anche nelle rivendicazioni di alcune delle più recenti mobilitazioni studentesche. Su questa rivendicazione ci torno più tardi.
Proprio perché non sono un esperto sono andato a cercarmi su internet le definizioni di ansia. Ne riporto due: una tratta dal sito dell’Istituto di Psicologia e Psicoterapia comportamentale e una da Wikipedia, che a sua volta cita il manuale diagnostico delle malattie mentali dell’associazione psichiatrica americana. Si tratta insomma di fonti relativamente attendibili.
La prima definizione è la seguente: «Ansia è un termine largamente usato per indicare un complesso di reazioni cognitive, comportamentali e fisiologiche che si manifestano in seguito alla percezione di uno stimolo ritenuto minaccioso e nei cui confronti non ci riteniamo sufficientemente capaci di reagire».
La seconda definizione è questa: «L’ansia è uno stato psichico di un individuo, prevalentemente cosciente, caratterizzato da una sensazione di intensa preoccupazione o paura, relativa a uno stimolo ambientale specifico, associato a una mancata risposta di adattamento da parte dell’organismo in una determinata situazione che si esprime sotto forma di stress per l’individuo stesso».
Il primo elemento da trattenere di queste definizioni è che l’ansia è generata da fattori ambientali. Il secondo elemento è che questo stato emotivo e cognitivo ci rende incapaci di agire. Il terzo elemento è che è associato a una mancata risposta di adattamento in una determinata situazione ambientale.
A me pare che sia un po’ difficile negare che questi tre elementi non abbiano una connotazione squisitamente politica, dove per politica intendo che hanno a che fare con il funzionamento della società in cui ognuno di noi è collocato. E già dire questo ci porta a delle conclusioni particolarmente radicali rispetto alla cura. Ma procediamo con ordine.
Quali sono allora questi funzionamenti sociali che generano ansia? Ce ne sono di diversi. Azzardo delle ipotesi che servono soprattutto a individuare una genealogia al problema dell’ansia giovanile. Naturalmente al netto di una ricostruzione storica, le mie sono solo delle ipotesi che partono dalla mia percezione, che non è uguale alla vostra perché abbiamo età diverse e siamo collocati in posizioni sociali diverse. Quindi mi piacerebbe capire cosa ne pensate.
A me sembra che una delle cause più importanti della produzione di ansia, che è la risposta emotiva che anticipa una minaccia futura, sia non tanto l’incertezza per il futuro, perché il futuro è incerto in quanto tale, ma l’imprevedibilità dei costi e dei benefici futuri che possono comportare alcune scelte di vita (il tipo di scuola, per esempio) o di condotta (l’impegno nello studio, altro esempio). Voglio dire che una quota consistente dell’ansia è dovuta all’incremento dei rischi scaricati sugli individui e all’esaurimento dell’efficacia dell’agire strumentale (come dicono i sociologi), ovvero che il rapporto tra mezzi e fini si fa sempre più incerto: per esempio, non è una certezza che il mio impegno nello studio mi porti in futuro risultati soddisfacenti. Questa situazione però non è un dato di natura. Non è sempre stato così, e quindi non è detto che debba essere così.
C’è stato un periodo storico in cui bene o male le biografie individuali erano pressoché già determinate o standardizzate, la rosa delle scelte di vita era limitata e con essa anche il livello dei rischi. Ciò avveniva in virtù di un’organizzazione sociale imperniata sul lavoro salariato “standard”. La fabbrica, con la sua rigidità, organizzava la società. Era il cosiddetto compromesso fordista-keynesiano, che si basava sullo scambio tra legittimità sistemica e prospettive di vita più o meno sicure.
Le lotte operaie degli anni Sessanta e Settanta se da un lato hanno imposto standard sempre più alti per questo compromesso, dall’altro lo hanno anche radicalmente messo in discussione. Queste lotte sono state importanti non tanto perché hanno conquistato dei diritti o dei salari più alti, ma perché hanno messo in discussione il fatto che per campare, in una società capitalista, si debba vendere la propria forza-lavoro. Gli operai si rifiutavano di essere operai, schifavano l’essere operai, schifavano la vita già segnata dalla fabbrica. Stessa cosa si poteva dire per le donne, che rifiutavano la collocazione nel lavoro domestico imposta dalla divisione del lavoro centrata attorno alla fabbrica. Vi suggerirei di leggere un bellissimo romanzo, che a me è servito più di mille saggi, che ha un titolo bellissimo: Vogliamo tutto di Nanni Balestrini.
Questo rifiuto del lavoro di fabbrica non si è trasformato in una rivoluzione. È stato sconfitto dai padroni, ma non con la semplice repressione, che pure c’è stata (anche perché se non c’è significa che non si è riusciti a far paura al nemico), ma per assimilazione. I padroni hanno detto: volete la libertà dalla catena di montaggio, dalla sua noia? Non c’è problema, potete arricchirvi tutti, potete diventare tutti imprenditori di voi stessi, aprirvi start-up, fare i youtubers, oppure usare i vostri saperi, le vostre competenze, la vostra intelligenza per farvi spazio in un mercato del lavoro competitivo. Sappiate però che tutti i rischi del caso sono a carico vostro. Se fallite, la responsabilità è solo vostra, anche se i rischi delle scelte non sono uguali per tutti.
È il mondo della meritocrazia. È chiaro che questa è una mistificazione: la libertà dalla catena di montaggio è diventata precarietà; la potenza del sapere è diventata “capitale umano” e più che possederlo ne siamo posseduti, tant’è che per valorizzarlo, per non restare indietro nella corsa, siamo costretti ad accumulare titoli di studio e credenziali formative che perdono sempre più valore proprio nella misura in cui continuiamo ad accumularli; infine, senza neanche starlo a sottolineare, dobbiamo continuare a vendere la nostra forza lavoro a qualcuno o sul mercato.
Qui aggiungerei un elemento di critica culturale: il trapper che canta al mondo quanto è figo per aver fatto i soldi con le sue canzoni o con le attività illegali non si sottrae a questa logica individualistica. Non ha proprio nulla di rivoluzionario, anzi direi che tra lui e un Carlo Calenda o un Elon Musk qualsiasi non c’è alcuna differenza, perché resta in una logica tutta individuale del successo.
Un altro elemento ambientale che possiamo rintracciare tra le cause di questa ansia generalizzata è la trasformazione dello stile di potere all’interno della scuola – ma più in generale nei vari ambiti della società – da paternalista a maternalista, come Gigi Roggero diceva in un altro incontro organizzato dai compagni di Kamo. Come sostiene Gigi, il maternalismo non è né peggio né meglio del paternalismo, è semplicemente diverso. Se il paternalismo agiva usando il bastone e la carota per governare le anime, il maternalismo per farlo usa la relazione interpersonale, le qualità emotive, e genera ansia perché funziona secondo la logica del debito morale, sul ricatto della delusione. Il paternalismo ti dice che non puoi fare una certa cosa o che ne puoi fare una cert’altra; il maternalismo ti dice invece «non mi deludere». In questo senso l’ansia mi sembra non tanto una conseguenza accessoria, ma un fine specifico delle relazioni di potere in questi ambiti della riproduzione, sia della forza lavoro che capitalistica.
In qualche modo, quindi, mi sembra che si possa dare una lettura politica dell’ansia intesa come il costo dell’incertezza sistemica scaricata verso gli individui. A questo elemento se ne accompagnano poi tutti degli altri che sono oggetto di cronaca: la guerra, la crisi economica, e così via. Con questo non voglio dire che prima era meglio, perché come abbiamo visto quel prima è stato invece oggetto duramente contestato da lotte; voglio invece che dire che oggi è diverso e che questo diverso va messo bene a fuoco.
Il secondo elemento da riprendere dalle definizioni è che l’ansia ci rende incapaci di agire. Da un lato c’è anche questo effetto, chi ha sperimentato un problema d’ansia anche piccolo sa che ha il potere di immobilizzare. Dall’altro, poiché il capitale ha bisogno del nostro agire produttivo, più che immobilizzare l’ansia accresce la nostra accettazione. Quando sentiamo la minaccia del futuro accettiamo più facilmente lo stato di cose semplicemente perché ci offrono un minimo di sicurezza. In questo senso l’ansia è proprio un dispositivo di governo. E tutto questo parlare di ansia, di patologie, sui giornali, sui social, nelle serie tv, alla fine anche se dà l’impressione di essere una forma di critica della società non fa che produrre accettazione.
Un soggetto ansioso ha bisogno di cure, di aiuto, è infantilizzato, è vittima e non ha autonomia. Quindi l’ansia invece di spingerci a rompere con il funzionamento di un sistema ci porta a chiedere la sua protezione. È soprattutto per questo che, per esempio, dovremmo stare attenti quando usiamo la categoria di catastrofe (ambientale o sociale poco importa). Che non significa negare l’esistenza di un grave problema, né l’urgenza della sua soluzione, ma significa criticare l’ordine del discorso catastrofista, la retorica della catastrofe che pure ha degli effetti materiali sulle nostre vite, perché immobilizza.
Infine il terzo elemento delle definizioni è che l’ansia è associata a un mancato adattamento ad una certa situazione ambientale. Questa parte della definizione mi sembra quella più ideologica, perché implicitamente ci suggerisce che nel caso di una frizione tra l’individuo e il contesto è l’individuo a doversi adattare e non il contesto a doversi trasformare. E la psicologia è lo strumento con cui produrre questo adattamento. Qui però bisogna fare attenzione: quando dico che la psicologia ha una funzione ideologica non intendo dire che non funziona. Al contrario, la psicologia ha una connotazione ideologica proprio nella misura in cui funziona. Infatti, funzionando efficacemente e quindi risolvendo il problema della frizione tra l’individuo e l’ambiente, produce contemporaneamente una mistificazione, cioè nasconde la natura sociale del problema, individualizza il problema e la sua soluzione, salvando il funzionamento del sistema.
Non è un caso per esempio che nelle industrie della riproduzione come quella dove lavoro io, le aziende paghino una psicologa per condurre delle supervisioni relazionali che servono per risolvere i conflitti interni al gruppo di lavoro, o per alleviare l’impatto del carico di lavoro sulla tenuta psichica dei lavoratori. È evidente che attraverso la psicologia problemi di ordine politico (la relazione di potere all’interno del posto di lavoro) e sindacale (i ritmi e il carico di lavoro) vengono trasformati in problemi individuali e psicologici. È un grande inganno a cui si aggiunge un altro elemento: l’apertura emotiva del lavoratore, il conforto “caldo” che in questo spazio maternalista si può trovare produce nel lavoratore fedeltà nei confronti della mission aziendale e senso di colpa per aver titubato, per non averci creduto, e quindi infine accettazione.
Da questo punto di vista la psicologia è la nuova scienza padronale, contro la quale dobbiamo ancora affinare la critica, mentre vedo che fioriscono discorsi su fantomatiche “società della cura” completamente decontestualizzati, e cioè che non tengono conto del fatto che viviamo in una società capitalistica che non solo mette a valore questa cura ma la rende una forma del potere.
Infine mi sembra che i disturbi psicologici siano stati investiti da una potentissima estetizzazione. Pensiamo, ad esempio, a una serie tv come Euphoria, che ha avuto un grandissimo successo, oppure a come il disturbo psicologico viene raccontato sui social non solo da personaggi conosciuti ma anche dalle persone, soprattutto giovani, più comuni. Sembra quasi che se non hai un disturbo sei uno sfigato. Ecco, al di là della concretezza dei disturbi, mi sembra che questa estetizzazione serva a fornire, dentro un campo sociale segnato dalla frantumazione e dalla moltiplicazione delle identità, un ulteriore elemento di distinzione che può anche diventare un vantaggio competitivo, una sorta di capitale simbolico spendibile sul mercato del lavoro e nei processi di valorizzazione capitalistica, come accade già per esempio per le differenze nel campo delle identità sessuali.
So bene che, come dicevo all’inizio, in alcune mobilitazioni studentesche è stata presente la richiesta di servizi di cura psicologica, a dimostrazione di quanto questo ordine di problemi è sentito, e non è mia intenzione dare un giudizio di valore sulla qualità delle istanze che si muovono nelle lotte e nelle mobilitazioni (io e la mia generazione – per dire – abbiamo lottato durante il movimento dell’Onda sostanzialmente per quella schifezza che chiamiamo meritocrazia, e abbiamo visto dove siamo arrivati) ma se ci prendiamo il tempo di riflettere, di andare al fondo delle cose, non possiamo accontentarci di quello che si muove: dobbiamo sempre fare lo sforzo di guardare oltre, di radicalizzare lo sguardo per spingere un po’ più in là critica e la lotta.
Per chiudere direi questo. Un compagno con cui mi sono confrontato per preparare questo incontro – dovete sapere che le cose che dico sono sempre il risultato di ragionamenti collettivi, di cui mi faccio semplicemente portavoce – mi metteva in guardia rispetto al rischio di fare come gli psicologi. Vale a dire di fornire ai diretti interessati, e cioè ai giovani, un’interpretazione, ancorché politica, del sintomo, nel nostro caso l’ansia, e una soluzione facile, che potremmo tradurre nello slogan «ribaltiamo l’ansia contro i padroni», che può generare l’angoscia di non fare abbastanza.
Penso che questo slogan non sia tanto la nostra soluzione già pronta ma rappresenti invece il problema che abbiamo davanti. Forse in parte, ci dobbiamo tenere l’ansia di non sapere qual è il nostro modo di organizzarci e di lottare, perché solo così possiamo avere la libertà di sperimentare e di sbagliare, sapendo però che non stiamo iniziando nulla di nuovo, perché veniamo da lontano.