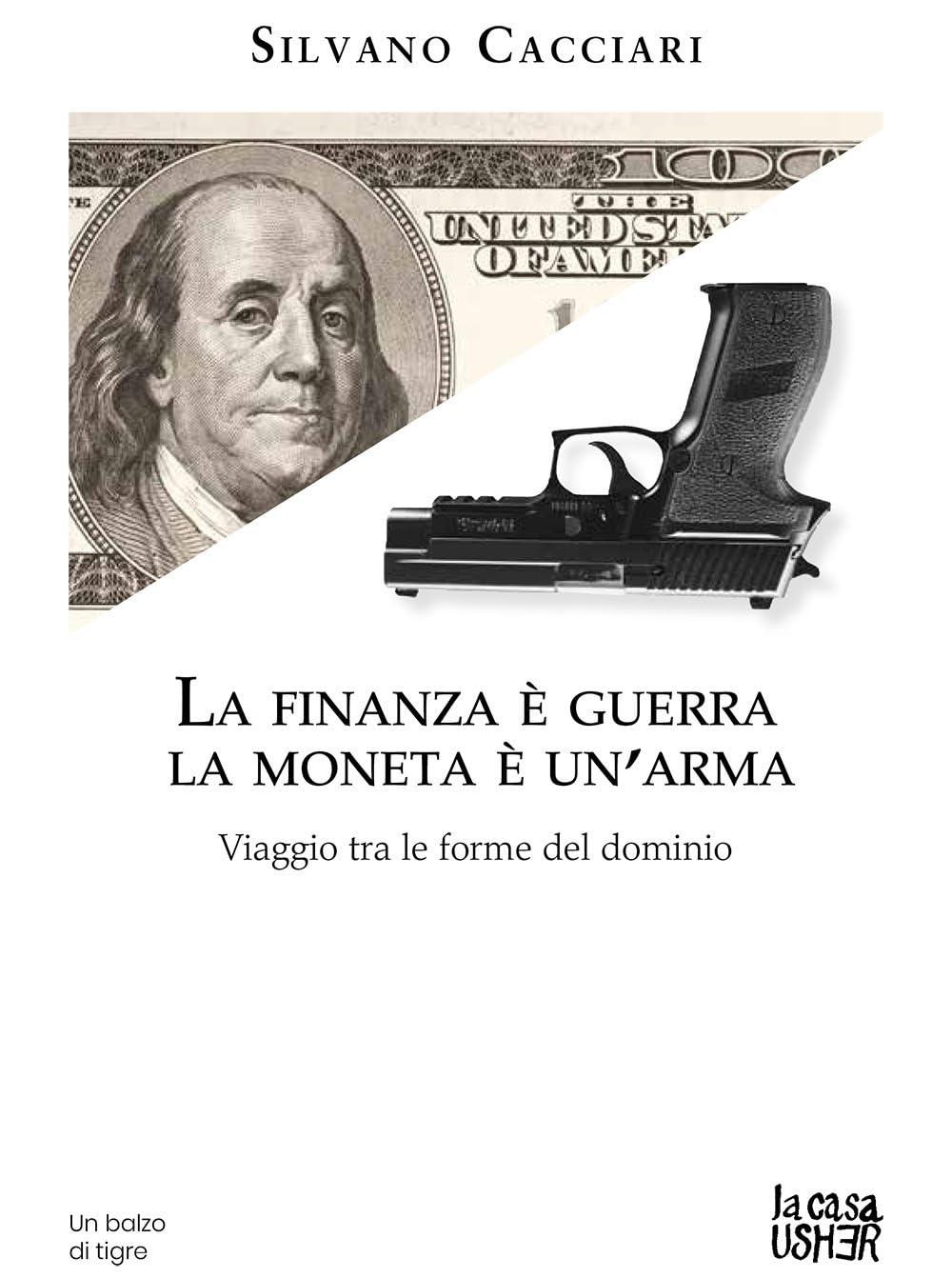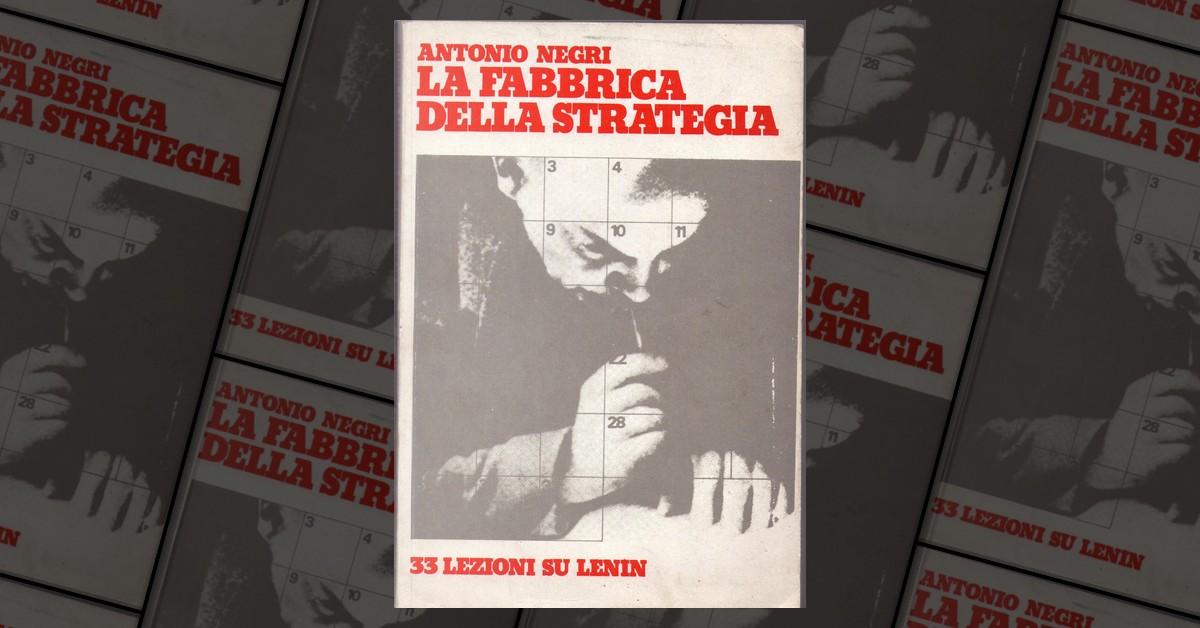Dal welfare al warfare, dall’automotive al carroarmato, dall’«Inno alla gioia» di Beethoven alla «Marcia imperiale» di Dart Fener. Nel cambio di tema che fa da sfondo all’Europa, l’imperialismo colpisce ancora.
Non «guerra stellare», in una galassia lontana lontana, ma ben più prosaicamente mondiale, è lo scenario per cui gli Stati europei preparano piani.
Guerra terrestre e marittima, sul continente e nei cieli, nelle reti e nei flussi. Guerra di trincee sotto il fuoco dei droni, sabotaggi di gasdotti e infrastrutture civili, di missili sulle metropoli e operazioni terroristiche di intelligence, di eserciti nazionali e legioni di paramilitari, di attacchi cibernetici e finanziari, di sanzioni commerciali e dazi globali. Guerra di materiali, di chip, di intelligenze artificiali, di produzione e ristrutturazione industriale, di innovazione tecnologica, di disarticolazione delle filiere, di estrazione e saccheggio dei territori, delle popolazioni, delle forme di vita.
Guerra preparata da massicci piani di riconversione bellica e da strette repressive del fronte interno. Dalla crisi politica nel cuore dell’Europa alla fine della «fine della storia», dalle debolezze delle borghesie nazionali, dalla subalternità al comando di Washington e ai folli progetti di genocidio di Israele.
Guerra che già ci coinvolge da vicino, senza però un’«alleanza ribelle», anzi, rivoluzionaria, di classe in grado di sovvertirla, ad ampio respiro, in processo di rottura e fuoriuscita da questo sistema che continuamente l’ha generata e la riproduce, su scala sempre più distruttiva, catastrofica, genocidiaria.
Prepararsi all’inaspettato. Si è già detto che perfino Lenin, nel 1914, a Cracovia, quando arrivò la notizia dello scoppio della guerra, rimase sbalordito: per il tradimento dell’Internazionale, certo, ma anche per il passo decisivo nello scontro militare tra potenze, ipotizzabile, probabile, ma non del tutto prevedibile. Se anche un genio tattico come Volodja fu colto, allora, di sorpresa, chi ne vorrebbe seguire la misteriosa curva, oggi, nella desertificazione di un pensiero strategico materialmente ancorato a una soggettività di classe di là da venire, può dormire sereno.
Eppure. Eppure il corso della storia può prendere pieghe inaspettate, indipendentemente da ogni attore, da ogni azione soggettiva. Fugaci destabilizzazioni, scosse, sospensioni, dell’apparente linearità. Eventi, movimenti, rotture che rimescolano le carte. Finestre temporali che aprono spazi di manovra, di possibilità. Questi momenti non sono né buoni né cattivi; anzi, possono essere cattivi – quasi sempre lo sono – e possono essere buoni: rapporti di forza che vengono messi in discussione, rapporti di forza che possono essere sovvertiti, riconfigurati, costruiti. Sicuramente, questi momenti saranno tragici. Della tragicità che è propria della libertà, autentica e terribile.
È come arriveremo, e ci staremo dentro, a questi momenti, che farà la differenza. Se saremo riusciti ad arrivarci preparati, all’inaspettato. Se riusciremo a guardarla negli occhi, questa terribile possibilità.
Per questo, dal punto di vista militante, in tutti i suoi aspetti, pensiamo che il compito minimo che la fase pone oggi sia quello di aguzzare la vista, affinare il fiuto, stimolare la mente e allenare il cuore ad essere pronti. Costruire le condizioni per cui – nella partita che si gioca, nel minuto dell’inaspettato – essere caldi in panchina, per poter entrare in campo. E non farci trovare fuori rosa, sugli spalti, come spettatori. Come, tirando una generosa mediana, siamo oggi.
***
Pubblichiamo allora la trascrizione dell’intervento di Robert Ferro, autore del podcast «Il perno originario» e del volume «Le ménage à trois de la lutte des classes», tenuto all’ultimo incontro del ciclo «La fabbrica della guerra», organizzato al Dopolavoro Kanalino78 da ottobre 2024 a maggio 2025 (ciclo suddiviso in due parti: Vol. I – «Modena nel conflitto globale» e Vol. II – «Geopolitica e lotta di classe nella crisi di sistema»). Rimandiamo quindi alle introduzioni dei precedenti contributi di Mimmo Porcaro e Raffaele Sciortino, e ancora prima all’approfondimento del primo incontro sull’«industria della formazione», i motivi, gli obiettivi e le prime considerazioni “a caldo” che ci hanno accompagnato lungo questo percorso di inchiesta, analisi e discussione politica, per andare subito alle domande che ci hanno mosso in questo ultimo appuntamento.
Dove va l’Europa, e quali scenari si aprono, quando i sussulti della crisi, dalle periferie esterne, cominciano a disarticolare il cuore dell’impero, la Germania, e la «fabbrica della guerra» si fa continentale? Dove va l’Europa, quindi, nella ripolarizzazione conflittuale del mondo tra Stati Uniti e Cina? È possibile un’Europa in conflitto con gli Stati Uniti? Cosa significa per il continente, e soprattutto per l’Italia inserita nelle sue catene del valore, la destabilizzazione politica e sociale del modello tedesco? Unione Europea e moneta unica possono essere messe in discussione da Berlino o conquistare una loro “autonomia strategica” imperialistica, in concorrenza con quella americana? Che posizione occupano la Germania e l’Unione Europea nella catena imperialistica globale? Si staglia davanti a noi un processo di radicalizzazione politica del contesto europeo, insieme alla sua rinazionalizzazione?
Buona lettura.
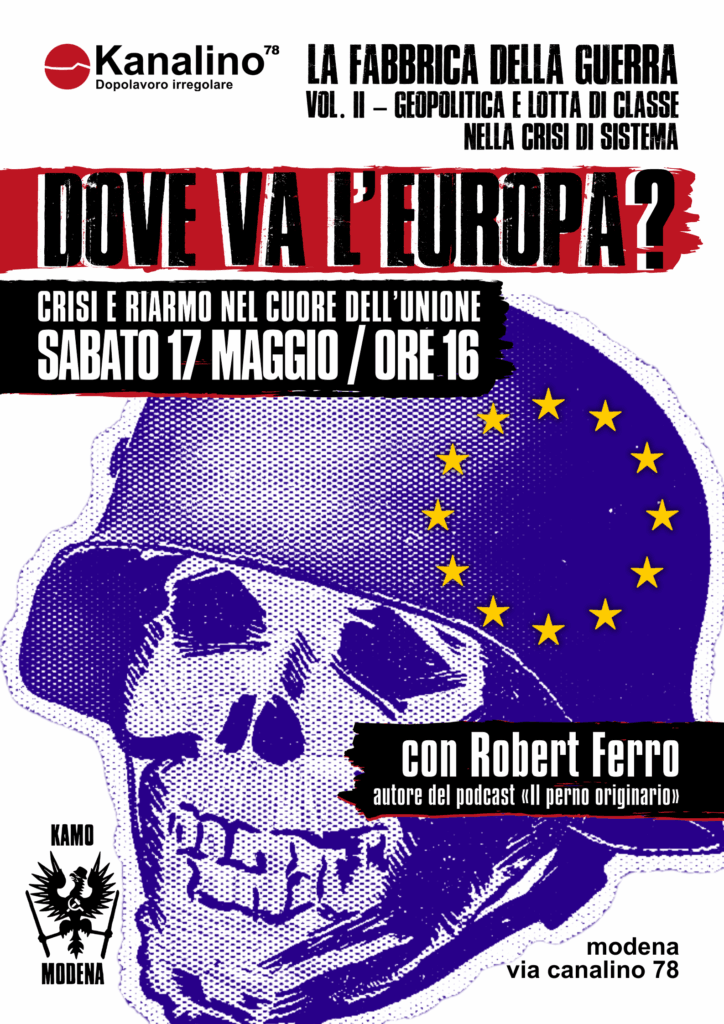
Robert Ferro
Introduzione. Germania e Versailles, ritorno al futuro
In molti oggi avvertono che il periodo storico più recente – sommariamente, quello della globalizzazione e della sua crisi – è entrato in un frangente delicato, in cui si stanno sciogliendo incognite notevoli, con ricadute altrettanto notevoli sull’evoluzione dei rapporti di classe a qualsiasi latitudine. Il sottoscritto condivide questa impressione. In ciò che segue, si tratterà però di andare oltre le impressioni, cercando di collegarle a dinamiche di lunga durata che riguardano il nostro quadrante di riferimento, quello europeo. La domanda «dove va l’Europa?» è legata a doppio filo alla domanda «dove va la Germania?».
Per cominciare ad abbozzare una risposta, procederemo in tre tappe: in un primo momento, evidenzieremo alcune invarianti storiche del capitalismo tedesco; in un secondo momento, ci soffermeremo su alcuni passaggi della storia tedesca dall’inizio del secolo scorso ad oggi; in un terzo momento, alla luce degli sviluppi precedenti, arriveremo alle prospettive future.
Ci si potrebbe chiedere quale sia l’utilità di un simile discorso. A mio modo di vedere, è importante per coloro che si definiscono comunisti essere in grado di proiettarsi in un orizzonte temporale di medio-lungo termine con delle ipotesi forti e fondate sui macroprocessi in corso e sul loro punto di caduta.
Ovviamente, nella storia c’è una componente insopprimibile di incertezza e di contingenza, a cui non sfuggono gli attori più lucidi. Ciò non toglie, per noi, l’esigenza di cercare di anticipare gli eventi, invece che essere costantemente in loro balia o al loro rimorchio. Vista la piega che questi stanno prendendo, non si potrà sfuggire eternamente alla questione del che fare. Affrontarla in maniera quanto più ragionata possibile, significa individuare i due o tre scenari più verosimili e pianificare un intervento in vista di essi. Vi ritorneremo in sede di conclusione.
Invarianti
Per invarianti, devono qui intendersi invarianti relative, giacché nella storia nulla si ripete mai in maniera identica. Questo detto, chi ha ascoltato il podcast Il perno originario (che va preso per quello che è: un divertissement), avrà forse intuito che accordo una certa importanza alla lunga durata, e più specificamente ai fenomeni di persistenza storica, di inerzia, di tradizione. Questo, per controbilanciare una tendenza molto diffusa nel nostro ambiente, che consiste a concentrarsi unicamente sul divenire, sulle trasformazioni. Non che questa tendenza non abbia la sua legittimità; spinta fino alle sue estreme conseguenze, essa porta però a farsi una rappresentazione errata del processo storico, come fosse un perpetuo stato nascente (in altre parole: come se tutto stesse sempre ricominciando daccapo). Con buona pace dei costruttivismi filosofici divenuti di moda negli ultimi decenni, un materialismo conseguente non può abbandonare il postulato secondo cui nulla si costruisce dal nulla, e il ventaglio di ciò che può essere socialmente «costruito» (o trasformato) è limitato in varie maniere dal materiale a partire da cui si «costruisce».
Per il caso che ci occupa, questo vuol dire che ogni formazione sociale specifica – cioè ogni declinazione particolare del modo di produzione capitalistico nel tempo e nello spazio – non cade dal cielo bell’e pronta, ma si forma a partire da elementi preesistenti, tra cui (fra gli altri) un territorio e una popolazione. Ovviamente territori e popolazioni non sono immutabili, sono essi stessi plasmati da rapporti sociali pregressi e continuano a trasformarsi nel corso del tempo. Ciononostante, come già anticipato, la portata di queste trasformazioni, in particolare su temporalità ridotte, non è assoluta, e alla scala della nostra storia di specie (300 mila anni circa, allo stato attuale delle conoscenze), uno o due secoli non sono molti.
Nella storia delle nazioni europee, si distinguono sovente – a mo’ di idealtipi – il caso francese, in cui lo Stato produce la nazione, e il caso germanico, in cui la nazione produce lo Stato. Questo è il primo punto su cui vorrei attirare l’attenzione: l’esistenza di un insieme germanofono e il sentimento di appartenenza nazionale tedesca precedono di gran lunga la sua effettiva territorializzazione sotto forma statale. Nel cuore della penisola europea, nella grande pianura che si estende fino alla Russia senza incontrare ostacoli naturali significativi, lo spazio germanico costituisce un blocco etnico-linguistico denso e piuttosto compatto. Esso è situato al crocevia fra le nazioni occidentali territorializzate dall’Atlantico e dal Mediterraneo, da fiumi e da catene montuose, e l’Est del continente, un vasto spazio geograficamente aperto ed etnicamente frammentato, dove il districarsi delle nazioni non ha potuto imporsi con l’evidenza del fatto naturale.
La nazione tedesca ha dunque assunto fin dall’inizio una dimensione semicontinentale: in primo luogo ostacolando, in virtù della sua posizione, la proiezione continentale delle nazioni occidentali (Francia, Olanda, Inghilterra, eccetera); in secondo luogo, proiettandosi essa stessa su scala continentale in forma di diaspora, senza con ciò darsi confini territoriali chiaramente definiti. Mi riferisco qui alla storia della Ostsiedlung, cioè alla formazione di colonie di popolamento tedesche al di là del fiume Elba – un processo assai dilatato sia dal punto di vista temporale che spaziale, con prolungamenti che arrivano fin dentro al mondo russo nel XVIII secolo (tedeschi del Volga) e nel XIX secolo (a Bolnissi, in Georgia). Peraltro, questa spinta verso Est comporta anche dei fenomeni di retroazione, che permettono di moderare l’idea abituale secondo cui la concezione tedesca della nazione e della cittadinanza sarebbe strettamente etnicista: in realtà, nello spazio tedesco, il rinnovamento del materiale umano generazione dopo generazione è avvenuto (e continua ad avvenire) in misura non trascurabile attraverso l’assimilazione di popolazioni slave e magiare.
Questi due elementi – la preesistenza della nazione tedesca rispetto alla sua formalizzazione statale, e la sua proiezione verso Est – non sono una scoperta recente, ma si trovano già nella riflessione dei padri fondatori del socialismo scientifico su questo tema. Ad esempio, si possono trovare indicazioni in tal senso in una lettera del vecchio Engels a Franz Mehring del 14 luglio 1893[1]. Assai più giovane di Engels, Mehring ha fatto in tempo a partecipare all’esperienza della Lega di Spartaco e alla fondazione del Partito comunista tedesco. Come autore, è conosciuto principalmente per la sua biografia di Marx e per una storia in più volumi della socialdemocrazia tedesca. Meno noti sono invece i suoi lavori sulla storia sociale e culturale della Germania, tra cui La leggenda di Lessing (1892), che anticipa molti elementi del dibattito storico sul cosiddetto Sonderweg, la «via originale» tedesca. Nella lettera citata, Engels reagisce in maniera entusiastica all’opera di Mehring, offrendogli in conclusione alcuni spunti supplementari:
«Nello studiare la storia tedesca […] ho sempre trovato che il solo confronto con le corrispondenti epoche della Francia dà il giusto metro di giudizio, perché là accade l’esatto opposto che da noi. […] Là, il conquistatore inglese nel Medioevo rappresenta, nella sua intromissione a favore della nazionalità provenzale contro quella francese-settentrionale, l’ingerenza estera; le guerre con l’Inghilterra prefigurano, per così dire, la guerra dei Trent’anni, che però finisce con la cacciata dello straniero e la sottomissione del Sud al Nord [della Francia, nda]. Viene poi la lotta del potere centrale con il vassallo di Borgogna, che si appoggia a possedimenti esteri recitando la parte del Brandeburgo-Prussia; lotta che però termina definitivamente con la vittoria del potere centrale e la creazione dello Stato nazionale. Esattamente nello stesso periodo, da noi lo Stato nazionale (nei limiti in cui il “regno tedesco” entro i confini del Sacro romano impero può essere chiamato uno Stato nazionale) crolla totalmente e comincia il saccheggio su vasta scala del territorio germanico […]».
E nel paragrafo successivo:
«Particolarmente significativo per lo sviluppo tedesco è inoltre che i due frammenti di Stato che, alla fine, si sono divisi la Germania non siano, né l’uno né l’altro, Stati puramente tedeschi, ma colonie su territorio slavo conquistato: l’Austria una colonia bavarese, il Brandeburgo una colonia sassone; e che si siano creati una potenza in Germania alla sola condizione di appoggiarsi su possedimenti stranieri, non tedeschi: l’Austria sull’Ungheria (per tacere della Boemia), il Brandeburgo sulla Prussia […]».
In quale maniera questi due elementi si coniugano nella storia socio-economica della Germania moderna? Per cominciare, si può dire che in assenza di un quadro politico-territoriale stabilizzato, l’integrazione economica della nazione tedesca ha preceduto la sua integrazione politica, in particolare attraverso lo Zollverein (1834), una vasta unione doganale promossa non dagli staterelli dell’area renano-vestfaliana, ma dalla Prussia, una regione orientale che dal 1945 non fa più parte dello spazio tedesco. Tale integrazione economica era strettamente legata allo sviluppo del settore ferroviario che, per essere ammortato, doveva necessariamente proiettarsi su un mercato esteso la cui costruzione ha fatto leva su elementi oggettivi di coerenza etnico-linguistica e su un sentimento di appartenenza nazionale comune.
Questo aspetto rimanda a una questione più teorica e generale che mi limiterò solo ad accennare: in un contesto, quello capitalistico, in cui i processi produttivi più efficienti sono generalmente quelli più intensivi in capitale e meno versatili, la redditività del capitale investito è legata alla produzione in serie. Qual è la sua dimensione ottimale? Essa dipende senz’altro dalla natura concreta delle attrezzature in questione, dalla loro indivisibilità tecnica e dal loro grado di specializzazione; ma in generale, si può dire che la dimensione ottimale della produzione in serie nell’ottica di rendere redditizio il capitale investito si ingrandisce nella stessa misura in cui aumentano il progresso tecnico e la divisione del lavoro.
Il rovescio della medaglia sta nel fatto che è la dimensione del mercato potenziale a determinare, dal punto di vista capitalistico, la scelta tra diverse tecniche produttive, le più efficienti delle quali presuppongono generalmente l’accesso a un mercato più vasto rispetto a quelle meno efficienti. In questo senso, l’esistenza o meno di un vasto insieme nazionale o protonazionale su cui appoggiarsi, predetermina in una certa misura la possibilità per i vari poli capitalistici di emergere come agenti di primo piano dell’accumulazione del capitale. L’estensione crescente dei poli capitalistici egemoni, così come teorizzata da Giovanni Arrighi o da altri autori riconducibili alla World System Theory, non è estranea a questa problematica.
Novecento
In Germania, lo status di leader legittimo dell’Europa è stato rivendicato esplicitamente solo di recente dai governi in carica (si veda la Zeitenwende proclamata da Olaf Scholz). Le ragioni di questo stato di cose risalgono, a mio modo di vedere, alla prima metà del XX secolo e alla maniera terribilmente violenta e sanguinosa in cui quel periodo si è concluso.
All’inizio del XX secolo, il relativo declino dell’Impero britannico come «potenza che domina il mercato mondiale» (Marx) apre una competizione tra due poli capitalistici ritardatari, quello americano e quello tedesco, la cui rimonta è stata possibile, in entrambi i casi, solo su basi protezionistiche. In questa competizione, il grande capitale tedesco soffre di una serie di debolezze, la principale delle quali è che il suo Stato – al quale Bismarck, per evitare eccessive ritorsioni, ha dato una forma piccolo-tedesca – non domina il proprio spazio di riferimento.
Nell’ultimo decennio del XIX secolo, avviene il passaggio dal protezionismo bismarckiano al libero scambio e alla Weltpolitik (politica mondiale) della Germania guglielmina, che reclama il suo «posto al sole» fra le grandi potenze coloniali dell’epoca. Questo passaggio spinge l’Impero tedesco, preso a tenaglia dall’alleanza franco-russa, in un tentativo di presa di controllo delle vie commerciali marittime che lo pone in conflitto diretto con l’Impero inglese (donde, fra l’altro, la dimensione navale del conflitto militare, la guerra sottomarina degli U-Boot tedeschi).
Al termine del conflitto, i debiti di guerra contratti dagli anglo-francesi e ripudiati dalla Russia rivoluzionaria vengono ripercossi sulla Germania, da cui le condizioni draconiane del Trattato di Versailles, che cancella le acquisizioni territoriali degli Imperi centrali ratificate a Brest-Litovsk (1918), amputa il grande capitale tedesco di buona parte dei suoi investimenti esteri, priva la Germania delle sue colonie (principalmente africane: Camerun, Togo, Namibia, e così via) e le impone il pagamento delle riparazioni. L’ordine di Versailles orchestrato dai capitali anglosassoni e francesi ratifica inoltre l’esistenza di tre paesi, la Cecoslovacchia, la Polonia e la Jugoslavia, con lo scopo di ostacolare la proiezione tedesca verso Est.
Come noto, la sconfitta militare provoca la caduta dell’Impero e una serie di lotte di classe con punte insurrezionali dal 1918 al 1923, la cui sconfitta, combinata con gli effetti devastanti della crisi del 1929, conducono all’ascesa del movimento nazionalsocialista. L’arrivo al potere di Adolf Hitler pone definitivamente fine alla politica di conciliazione con le potenze vincitrici incarnata dalla figura del ministro degli esteri socialdemocratico Gustav Stresemann, e lancia la Germania in una contestazione frontale degli assetti territoriali e geoeconomici usciti dalla Prima guerra mondiale. Fra le altre cose, questa contestazione conduce la Germania a far esplodere i tre paesi riconosciuti a Versailles (nell’ordine: Jugoslavia, Cecoslovacchia, Polonia). Come noto, essa si concluderà in maniera catastrofica, alla fine della Seconda guerra mondiale, con una capitolazione senza condizioni implicante smilitarizzazione, smantellamento dello Stato maggiore e smembramento del Reich stesso.
Sia durante la Prima guerra mondiale che durante la Seconda, lo Stato tedesco elabora progetti a lungo termine volti all’integrazione economica, doganale e monetaria del continente europeo. In estrema sintesi, il progetto tedesco di unificazione europea è quello di un grande spazio (si veda il concetto di Großraum nell’opera di Carl Schmitt) retto dall’egemonia regionale della Germania. Nella sua variante nazionalsocialista, esso avrebbe dovuto e potuto contare, se non su un’alleanza con l’Inghilterra, quantomeno sul suo non-intervento sul teatro continentale, in linea con la politica inglese di appeasement degli anni 1930 (che, come noto, viene invece abbandonata dopo la frammentazione della Cecoslovacchia, orchestra dal Reich nel 1938). Per due volte, quindi, il tentativo della Germania di accedere allo statuto di egemone continentale viene sventato.
All’indomani della fine della guerra, gli alleati sono determinati a porre fine alla Germania sia come polo capitalistico avanzato che come Stato unitario e indipendente. Separato dall’Austria, che riacquista rapidamente la sua indipendenza, il territorio tedesco viene balcanizzato tra una Germania occidentale, a sua volta divisa in tre zone (britannica, americana e francese), e una Germania orientale, di cui una parte è sotto il controllo diretto di Mosca (la futura Repubblica democratica tedesca, RDT) e altre due – la Prussia orientale da un lato, la Pomerania unita all’Alta Slesia dall’altro – vengono annesse alla futura Polonia «popolare».
Il progetto iniziale americano, secondo le raccomandazioni del piano Morgenthau elaborato prima della fine del conflitto, è quello di ridurre la Germania sotto il controllo alleato a un paese di agricoltura e pastorizia. Una politica di riduzione delle capacità industriali tedesche viene effettivamente perseguita fino al 1947, attraverso le riparazioni di guerra. Gli impianti industriali vengono smantellati e trasferiti nei paesi occupanti. Nelle tre zone occidentali della futura Repubblica federale tedesca (RFT), non c’è libera circolazione di beni e servizi e nessuna delle tre è autosufficiente dal punto di vista alimentare. La produzione industriale è scesa al 38% rispetto ai livelli del 1936, mentre il settore agroindustriale risente fortemente della mancanza di macchinari e fertilizzanti.
Il livello di razionamento alimentare della popolazione è più draconiano di quello in vigore nella futura RDT: 1000 calorie al giorno contro 1500. Le autorità americane sul posto comprendono rapidamente quale sia il rovescio della medaglia. Il generale Clay, responsabile delle forze di occupazione americane, lo esprime in questi termini: «Tra diventare comunisti con 1500 calorie al giorno e credere nella democrazia con 1000, la scelta è presto fatta. La mia sincera opinione è che il razionamento imposto in Germania non solo porterà alla sconfitta dei nostri obiettivi nell’Europa centrale, ma aprirà la strada ad un’Europa comunista». Il passaggio della Cecoslovacchia nel frattempo ricostituita nell’orbita di Mosca nel 1947 e gli scioperi che si moltiplicano nello stesso periodo nei bacini minerari, siderurgici e automobilistici dell’Europa occidentale sembrano confermare questa diagnosi. Inoltre, un mercato così depresso nel cuore dell’Europa non è privo di conseguenze per il capitale americano, che già prima della guerra soffre di un eccesso di capacità produttive domestiche destinato a riproporsi a conflitto terminato, quando i settori economici requisiti e messi al servizio dell’economia di guerra (automobilistico, chimico, eccetera) devono adattarsi alle condizioni postbelliche.
La combinazione di questi due fattori convince le autorità americane a modificare il loro approccio. Inizia così l’epopea dell’Europa europeista, ovvero la resurrezione del grande capitale tedesco in seno all’impero europeo dell’America. La specificità di questo processo può essere riassunta nel seguente paradosso: il riemergere del capitale tedesco non era voluto, ma si è rivelato passo dopo passo il prezzo necessario e inevitabile del dominio imperiale americano sulla metà «libera» del continente.
Nella vulgata riguardante la ricostruzione postbellica, si insiste spesso sull’importanza del piano Marshall. Ma questo non sarebbe stato sufficiente per rilanciare l’economia dei paesi interessati senza l’Unione europea dei pagamenti introdotta, anch’essa sotto pressione statunitense, nel 1951. Nell’ambito del nuovo sistema monetario internazionale varato a Bretton Woods nel 1944, gli scambi internazionali tra i paesi europei devono essere effettuati in dollari. Tuttavia, alla fine degli anni Quuaranta i dollari sono scarsi in Europa, poiché la bilancia commerciale di tutti i paesi europei nei confronti degli Stati Uniti è in deficit. Questo li costringe, in sostanza, a scegliere se commerciare fra loro o con gli Stati Uniti. Il meccanismo di clearing istituito con l’Unione europea dei pagamenti risponde a questo problema.
Allo stesso modo, la ripresa economica non può avvenire senza risolvere i problemi di approvvigionamento di materie prime di base come il carbone, la cui produzione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno delle industrie, e l’acciaio, settore che invece registra un eccesso di capacità produttiva. La Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) istituisce un’autorità sovranazionale responsabile della gestione delle capacità produttive in questi due settori. Il piano Monnet-Schuman (rispettivamente commissario al Piano e ministro degli Affari esteri francesi) per la CECA viene elaborato per risolvere in via prioritaria i problemi dell’industria francese, ma «venduto» agli americani come una soluzione che consentirebbe di evitare la ricostituzione del grande cartello europeo dell’acciaio, dominato a partire dal 1926 dal gigantesco conglomerato tedesco Stahlverein.
La CECA agisce tuttavia nel senso della costituzione di grandi gruppi nei settori di sua competenza e, soprattutto, consente di eliminare le ultime misure che impongono un limite massimo alle dimensioni delle imprese tedesche. Il cuore produttivo europeo ricomincia a battere.
Durante tutta la prima metà degli anni Cinquanta, la priorità degli imprenditori tedeschi è il ripristino di un’unione doganale che consenta loro di puntare sulle economie di scala. Essa viene ottenuta puntualmente nel 1957 con la creazione della Comunità economica europea (CEE, ovvero l’Europa dei sei: RFT, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo). Questa, però, si rivela ben presto troppo ristretta per contenere la rapida crescita del grande capitale tedesco, donde gli allargamenti che avranno luogo in seguito[2]. Allo stesso tempo, lo spazio economico integrato così costituito si rivela una formidabile valvola di sfogo per i capitali americani, che trovano in quest’area non solo un mercato di sbocco, ma sempre più (e in particolare dall’inizio degli anni Sessanta in poi) una zona privilegiata di investimento, attraverso l’apertura di filiali europee di multinazionali americane, volta non di rado ad aggirare i dazi doganali della CEE. Queste filiali dispongono di fonti di finanziamento proprie rispetto a quelle dei capitali tedeschi, francesi, olandesi, italiani, eccetera (si veda il mercato dell’eurodollaro).
L’Europa europeista è dunque il risultato di due imperativi opposti: quello dei grandi capitali americani, che mirano ad assicurarsi una vasta zona riservata all’esportazione di merci e capitali, e quello dei capitali tedeschi, che mirano a ritrovare la dimensione critica che consenta loro di inserirsi efficacemente in un contesto di competizione oligopolistica vieppiù internazionalizzata.
Questi due imperativi si sono combinati in modo più o meno virtuoso, con alti e bassi, per diversi decenni. Tutto questo è avvenuto nel quadro dell’impero europeo dell’America che, pur ammettendo la crescita e lo sviluppo del capitale tedesco, imponeva forti vincoli alla sovranità della Germania (anche riunificata), secondo il motto della NATO: «Tenere gli americani dentro, i russi fuori e i tedeschi sotto». Il medesimo dualismo si è poi tradotto anche all’interno delle alte istanze dell’UE – Corte di giustizia, Commissione, Consiglio, Banca centrale, Parlamento – che, lungi dall’avere un orientamento univoco, fanno prevalere, a seconda delle loro prerogative e del loro funzionamento, il punto di vista tedesco o quello americano (anche travestendolo da espressione dei paesi europei periferici, se necessario), cosicché l’istituzione nel suo insieme si configura come un organo di mediazione fra l’uno e l’altro, in un quadro generale che escluda il ristabilirsi di una piena sovranità tedesca («i tedeschi sotto»)[3].
Riassumendo: dopo la guerra e la capitolazione senza condizioni del Reich, dopo la sua balcanizzazione tra il 1945 e il 1949, dopo la ricostituzione di due Germanie su una base più limitata all’interno di un’Europa divisa dalla cortina di ferro, la ricostruzione economica della sua parte occidentale finisce per riportare, nel giro di qualche decennio, la Germania federale nel girone dei grandi paesi industrializzati. Restano però numerosi fattori caratteristici del mondo bipolare che rendono ancora prematura la questione dell’egemonia continentale, potenziale o effettiva.
Verso la fine degli anni Sessanta, il polo capitalistico tedesco nuovamente in rimonta (come quello giapponese, del resto) ha ricominciato a farsi esportatore di capitali, ma questa tendenza risulta ancora assai frenata dai meccanismi di controllo sui movimenti di capitale allora vigenti. Inoltre, la divisione dell’Europa dettata dalla cortina di ferro sottrae tutta la parte orientale del continente europeo alla penetrazione tedesco-occidentale di merci e capitali (per quanto evidentemente degli scambi esistano: inaugurazione dell’oleodotto Druzba nel 1963, Ostpolitik 1969-1974, scambi commerciali RFT-RDT, eccetera).
Questo fatto costringe il grande capitale tedesco a limitare per lo più la sua espansione commerciale in direzione dell’Europa atlantica e mediterranea, allargando la CEE prima alla Gran Bretagna, all’Irlanda e alla Danimarca (1973), poi alle ex dittature militari periferiche: Grecia (che aderisce alla CEE nel 1981), Spagna e Portogallo (che vi aderiscono nel 1986). Nei decenni Settanta e Ottanta, la dimensione mercantilistica, cioè legata all’esportazione di merci, prevale ancora fortemente sulla dimensione imperialistica, legata all’esportazione di capitali – fatto confermato in controluce dai tentativi di integrazione monetaria «morbida» del Serpente monetario (1972-1978), e del Sistema monetario europeo (SME, 1979-1993), elaborati in risposta alla fluttuazione monetaria del dopo-Bretton Woods, principalmente nell’ottica di evitare le svalutazioni competitive degli altri paesi membri del Mercato comune.
È alla metà degli anni Ottanta – e in particolare con gli accordi del Plaza (1985) che impongono alla Germania una rivalutazione del marco sul dollaro – che lo scenario inizia a cambiare abbastanza rapidamente, sciogliendo via via i nodi prima elencati. Nel 1986, l’Atto unico europeo, con l’introduzione della libera circolazione dei capitali nella CEE (fortemente voluta dalla Germania) può essere considerato come lo spartiacque che segna l’effettivo ritorno sulla scena storica di un imperialismo tedesco in senso stretto, ovvero come fonte di massicce esportazioni di capitale.
Questo non significa che la Germania sia in assoluto l’unico imperialismo europeo rimasto sulla scena: semplicemente, la sua portata e il suo potenziale sul piano economico sono incomparabilmente più grandi rispetto a quelli di paesi come la Francia, la Gran Bretagna o l’Italia – come il seguito degli eventi tende a mostrare.
Nel 1990 la Germania occidentale effettua l’Anschluss della RDT, avviando con ciò la brusca ristrutturazione dell’economia tedesco-orientale, anche a prezzo di mandare in frantumi il SME (tre anni più tardi). Nel 1991 l’URSS si dissolve, aprendo la strada alla rapida frammentazione del blocco dell’Est. Allo stesso tempo, ha inizio il lungo decennio delle guerre jugoslave, innescate dal riconoscimento unilaterale dell’indipendenza slovena e croata da parte della Germania. A questi eventi epocali segue, nel 1992, il «divorzio di velluto», cioè la separazione amichevole della Repubblica Ceca e della Slovacchia, divenuti così degli staterelli da 10 e 6 milioni di abitanti rispettivamente, che in seguito saranno interessati da un intenso movimento di investimenti tedeschi. Da allora, un vasto spazio politicamente frammentato, composto da piccoli Stati con poca autonomia sia economica che politica, viene coinvolto dalla dinamica del capitale tedesco, che ne fa un territorio economicamente integrato.
Infine, questa fase segna anche il ritorno a una politica estera interventista, caratterizzata dall’invio della Bundeswehr per la prima volta dal 1945 fuori dai confini nazionali, nell’ambito dell’intervento della NATO in Kosovo (1999). Gli anni Novanta segnano dunque una svolta diplomatica, in quanto la Germania mette in discussione in modo volontaristico l’architettura europea ereditata da Versailles. Ma segna anche una svolta economica, in quanto l’Europa orientale è uno spazio già industrializzato, con una forza lavoro qualificata, e una vocazione industriale che viene messa al servizio degli investimenti tedeschi. In tutti i paesi della zona, i conglomerati tedeschi realizzano tra il 25 e il 40% dei loro investimenti, dando vita a un vasto blocco economico organizzato, sinergico, funzionale e compatto.
La «nuova Europa» si organizza ormai attorno al cuore industriale tedesco e al suo hinterland continentale, uno spazio economicamente vivace che contrasta in maniera crescente con la stagnazione dell’Europa atlantica e mediterranea.
Tuttavia, per ragioni legate sia alle ipoteche che continuano a pesare sulla sovranità politica dello Stato tedesco, sia ai meccanismi interni di legittimazione politica, sia alla volontà di preservare rapporti di buon vicinato con i paesi occupati durante la guerra, nei successivi anni Duemila nessun leader politico tedesco osa ancora alludere all’egemonia continentale tedesca come un obiettivo auspicabile. In questo frangente, l’esistenza di un interesse nazionale tedesco (che come qualsiasi «interesse nazionale» non è un dato, ma un prodotto di mediazioni e arbitraggi) è politicamente inammissibile, e «l’Europa» diviene il nome ufficiale di questi interessi man mano che la CEE, ora divenuta UE, prende forma e slancio[4].
Pur sfruttando a proprio vantaggio le faglie aperte dalla fine del mondo bipolare, la Germania mantiene dunque un profilo basso, preoccupandosi piuttosto di dotare l’UE di un complesso di regole (Maastricht 1992, Amsterdam 1997, e così via) che consentano una sorta di «governo tecnico» sui paesi membri, surrogato di un’autentica egemonia politica. Alla fine degli anni 1990, l’introduzione della moneta unica completa l’edificio, con l’illusione (soprattutto francese) che essa equivalga alla messa in comune del marco tedesco e, di conseguenza, all’impossibilità definitiva di qualsiasi egemonia o autonomia tedesca. La Germania, dal canto suo, lascia fare e trova persino una certa utilità alle velleità di grandezza del galletto francese, che si sogna capofila politico dell’UE.
Sonderweg del terzo millennio
La prima metà degli anni Duemila è una fase di rallentamento economico, in cui la Germania, come sovente nel corso della sua storia, viene considerata come un paese destinato al declino. Sulla stampa economica internazionale vi si fa riferimento come «il malato d’Europa». È questo il periodo delle dolorose riforme del mercato del lavoro del governo Schröder, che rivedono al ribasso il compromesso sociale (mantenimento dell’occupazione in cambio di maggiori margini di compressione salariale), nell’ottica di rilanciare la competitività industriale in loco. Cosicché, sotto la guida di Angela Merkel (2005-2021), la Germania consolida ampiamente il suo statuto di potenza economica. Diversamente da quanto accade altrove, lo spartiacque della grande crisi del 2008 gioca piuttosto a suo favore.
Non ripercorrerò qui nel dettaglio la storia della crisi dei debiti sovrani in Europa e degli anni successivi. A questo proposito, si può dire che in una prima fase (2008-2015) la Germania si è vista costretta a più riprese a uscire allo scoperto per far valere gli interessi specifici dei suoi settori capitalistici dominanti, in condizioni in cui non era più possibile presentarli come interessi generalmente europei (difesa dell’euro forte tra il 2008 e il 2012, disciplinamento della Grecia, accoglienza dei rifugiati siriani nel 2015 e crisi migratoria associata, eccetera).
Il binomio franco-tedesco, che fino ad allora aveva contribuito a contenere la dinamica tedesca, si spacca sulla gestione della crisi greca: malgrado l’appoggio degli Stati Uniti, la Francia, sostenitrice di una politica più flessibile atta a preservare gli interessi del proprio capitale bancario, ne esce provvisoriamente sconfitta. La Germania, dal canto suo, afferma il suo controllo sugli affari interni dei membri dell’eurozona (in Italia, ad esempio, spinge alla caduta dell’ultimo governo Berlusconi), mantiene una politica della moneta forte e avvia un nuova fase di accumulazione che inizia a basarsi maggiormente sulle esportazioni, prima di merci e poi di capitali, verso i paesi BRICS – Cina in primis.
In una seconda fase, grossomodo dal 2015 in avanti, essa si trova però a fare i conti con lo scontento che questa politica suscita sia nel contesto europeo che internazionalmente (soprattutto negli Stati Uniti), e deve nuovamente fare un passo indietro. La Germania accetta così di essere messa in minoranza in seno alla direzione della BCE sulla questione della politica monetaria dell’eurozona (il bazooka di Mario Draghi, annunciato nel 2012 e attivato nel 2015) e ancora nel 2020, durante la crisi del Covid, con la ripresa del quantitative easing da parte della BCE, associato a un massiccio piano di aiuti (Next Generation EU) concesso dall’UE sotto la minaccia più o meno esplicita di un Italexit.
Questo approccio riluttante rispetto al ruolo di egemone politico in Europa raggiunge a mio avviso i suoi limiti con la guerra in Ucraina. Presa nel fuoco incrociato del ricatto morale a sostegno dell’Ucraina, della messa sotto accusa delle sue interdipendenze economiche con la Russia, dell’attacco alle sue infrastrutture energetiche (Nord Stream I e II), delle spinte recessive che da allora gravano sul suo tessuto economico interno e su quello del suo hinterland, la Germania deve finalmente decidere a quale gioco vuole giocare. Il momento delle scelte difficili si avvicina.
In parallelo, assistiamo nell’ultimo decennio a un tentativo di autonomizzazione da parte delle alte istanze dell’UE, e in particolare della Commissione europea. A partire dalla Brexit, che giunge a compimento nel 2020, questo tentativo diviene una vera e propria fuga in avanti. Esso si è tradotto in un impiego sempre più incostante e discrezionale del famoso principio di sussidiarietà, applicato in modo ascendente o discendente a seconda delle circostanze, dei compromessi o degli intrighi politici: ascendente quando l’UE, i suoi rappresentanti e i suoi portavoce si attribuiscono funzioni che in linea di principio non sono le loro (come nel caso del dossier ucraino, con l’improvvisa apparizione di una «diplomazia europea» condotta dal duo Von der Leyen-Breton); discendente quando l’UE lascia che i paesi membri se la cavino come possono con questioni che sarebbero di sua competenza, ma che vengono nascoste sotto il tappeto finché che non divengono altamente esplosive.
In sintesi, tutto ciò genera un quadro di difficile lettura, delegittimato e inefficiente (anche quando sono in gioco somme ingenti: si veda il Next Generation EU e i suoi esiti), tanto più che numerosi paesi, nonostante la profusione di annunci roboanti da parte della Commissione, conoscono una stagnazione economica di cui per ora non si vede la via d’uscita. Inoltre, i nazionalismi prosperano ormai anche all’interno delle istituzioni rappresentative dell’UE (in particolare nel Parlamento europeo), per quanto il loro ruolo sia notoriamente ridotto. Quest’ultimo punto, a mio avviso, è indice di una tendenza a lungo termine che sta modificando l’arena europea in base ad accordi e iniziative intergovernative, nonostante gli sforzi in senso contrario della casta politica «europea» situata in cima alla piramide.
Abbiamo dunque a che fare con due tendenze contraddittorie: da un lato, le spinte della Commissione che, attraverso una politica del fatto compiuto, cerca di mantenere per sé l’iniziativa e di serrare i ranghi; dall’altro, la tendenza ad un’Europa delle nazioni, un’Europa a geometria variabile o un’Europa à la carte, destinata a sfuggire in maniera crescente al controllo della Commissione (si veda ad esempio i vertici di «volenterosi» sulla questione ucraina, prima a 15 e più recentemente a quattro, che hanno coinvolto anche la Gran Bretagna post-Brexit).
La guerra in Ucraina ha reso possibile un ultimo tentativo di centralizzazione sovranazionale da parte dell’UE, soluzione alternativa a quella di un grande spazio esplicitamente dominato dalla Germania. Tuttavia, questo tentativo, incarnato dal protagonismo politico e mediatico di Von der Leyen, è fallito. Tutto l’attivismo di Ursula e dei suoi soldatini per fare della Russia il nemico assoluto, silenziare le voci discordanti e promuovere regime change nei paesi membri recalcitranti, spingere a una rapida adesione dell’Ucraina all’UE nonostante la lista già corposa di paesi candidati, e così via, tutto ciò non è bastato a cambiare l’esito dello scontro militare sul territorio ucraino. La nuova amministrazione americana rincara la dose rompendo ufficialmente con la «diplomazia dei valori» che si supponeva condivisa dall’UE e dagli Stati Uniti, e avviando colloqui per la cessazione del conflitto in Ucraina senza includere rappresentanze dell’UE al tavolo dei negoziati.
Il centralismo di Von der Leyen appare sostenibile solo nel quadro di una prosecuzione dello scontro transatlantico con la Russia, riacceso e pilotato a distanza dagli Stati Uniti. Solo nel quadro di un’alleanza transatlantica stretta, l’Unione europea può tenere assieme i suoi diversi membri[5]. A meno che l’attuale orientamento americano non subisca ulteriori inversioni, questo scenario non è il più probabile, anche malgrado le attuali iniziative europee volte a rilanciare la spesa militare in Europa in maniera coordinata dall’UE (vi ritornerò in sede di conclusione).
A trent’anni dalla svolta del 1989-1991, dell’ordine mitteleuropeo di Versailles rimane in piedi solo la Polonia. Naturalmente, dal punto di vista economico essa è strettamente annodata al complesso produttivo tedesco: nel 2021, l’interscambio tra Germania e Polonia ha superato quello tra Germania e Italia, la quale resta un importante polo industriale in Europa, forte di una popolazione 60 milioni di abitanti (per quanto in rapido invecchiamento). Tuttavia, la fissazione del confine tedesco sulla linea Oder-Neisse, stabilita a Potsdam nel 1945 e che ha amputato le due Germanie post-belliche della Prussia – confine il cui riconoscimento tardivo è stato imposto dagli Alleati in cambio della riunificazione – lascia in realtà aperta la possibilità di una disputa territoriale tra i due paesi.
La Polonia è un paese di quasi 40 milioni di abitanti, uniti da una forte coscienza nazionale. Essa possiede quindi i due elementi necessari per mettere i bastoni fra le ruote ad un’egemonia politica tedesca esplicitamente affermata: la dimensione critica del suo mercato interno, che le consente di rivendicare una certa autonomia economica sostenendo lo sviluppo di un’industria propriamente nazionale, quantomeno in determinati settori, e quel sentimento nazionale che sostiene la sua capacità di affermare la propria indipendenza nei confronti dell’ingombrante vicino. Dalla disgregazione del blocco dell’Est in poi, la Polonia è riuscita a cavalcare lo sviluppo economico tedesco. In Europa, essa appare come l’unico paese in grado di far fallire un nuovo eventuale tentativo tedesco di instaurare il suo Großraum – fatto che non sfugge agli anglo-americani, i quali vedono in essa il principale vettore dell’atlantismo, e ne hanno fatto il loro avamposto geopolitico sul continente.
Tutto ciò ha implicazioni importanti allorché si consideri l’imperialismo non solo come il dominio di un determinato paese o gruppo di paesi, ma come un processo dinamico di esportazione di una dinamica di sviluppo economico. Giacché, diversamente dal mercantilismo, basato sull’esportazione di merci, l’imperialismo, esportando capitali, esporta necessariamente una dinamica di sviluppo.
Laddove una simile dinamica giunge a coinvolgere un paese abbastanza grande e coeso, sia dal punto di vista quantitativo (dimensioni del mercato interno) che qualitativo (senso di appartenenza nazionale, necessario a disciplinare la sua classe capitalista), l’imperialismo crea esso stesso gli elementi della propria sovversione. Il rapporto fra Stati Uniti e Cina è un caso esemplare, ma quello tra Germania e Polonia potrebbe costituire un esempio analogo di questo tipo di evoluzione su una scala più ridotta. La contestazione della posizione egemonica, che mette in discussione la supremazia del paese dominante, può quindi portare quest’ultimo a sostituire i mezzi economici con metodi e strumenti politico-militari.
È evidente come per la Germania vi sia ancora un grande divario tra la prestanza economica del suo grande capitale, e la capacità di tradurre quest’ultima in potere politico e militare nell’arena internazionale. Come già accennato, un simile divario non risulta esclusivamente da un’imposizione esterna (americana), nella misura in cui questa è stata interiorizzata per decenni dalle burocrazie di Stato, dal sistema dei partiti e dalla mentalità di ampi strati della popolazione.
Gli esiti della Seconda guerra mondiale hanno prodotto una cultura politica molto consensuale, che la caduta del Muro ha reso ancor più conformista. Il grande padronato tedesco ha imparato a farsi discreto, e i partiti di governo si sono abituati a un linguaggio privo di contenuto. «La fine della storia è stata fino a poco tempo fa una realtà per la Germania»[6]. Per lo stesso motivo, però, gli annunci di cambiamenti radicali da parte del ceto politico moderato non devono essere sottovalutati. I segni di accelerazione storica si stanno moltiplicando ovunque e – dalla Zeitenwende alle prospettive di riarmo, passando per la soppressione del freno all’indebitamento – la Germania non fa eccezione.
In definitiva, la visione qui proposta si distanzia dalle analisi del capitalismo tedesco in termini di neomercantilismo – tra le quali la più convincente è senz’altro quella di Joseph Halevi[7]. Ciò non significa che la dimensione mercantilistica (export oriented, direbbero gli economisti) sia necessariamente marginale. Ma bisogna distinguere, da un lato, la natura dei rapporti economici che il grande capitale tedesco ha intrattenuto con i paesi della CEE prima, dell’UE/eurozona poi e, dall’altro, la natura dei rapporti con le aree economiche situate all’esterno di questo perimetro.
La distinzione fra i due piani suggerisce il succedersi di tre diverse fasi: una prima fase, propriamente mercantilista (1949-1985), nel corso della quale la preoccupazione centrale del grande capitale della RFT è stata quella di ricostruire attorno a sé un’area di mercato sufficientemente estesa da poter assorbire le economie di scala che esso intendeva applicare internamente; una seconda fase (1986-2008) nel corso della quale il grande capitale tedesco si è dispiegato al di fuori della RFT, poi della Germania riunificata, allargando ulteriormente la sua area di mercato privilegiata, ma soprattutto trasformando una parte di essa in una zona di investimento in cui approfondire la divisione del lavoro, strutturando catene del valore complesse; una terza fase (2008-2022), nel corso della quale gli incrementi di produttività preparati dalla fase precedente hanno permesso una più forte penetrazione dei mercati extraeuropei, trasformando inoltre alcuni di questi – in particolare quello americano e quello cinese – in zone di investimento diretto all’estero.
È ancora troppo presto per definire in maniera soddisfacente la nuova fase, ma quel che si può dire fin da ora è che la sua evoluzione sarà fortemente segnata dalla grande scommessa americana volta a riequilibrare in maniera ricattatoria ed extraeconomica i grandi squilibri globali (global imbalances) intercorrenti tra gli Stati Uniti e i paesi che detengono i maggiori surplus commerciali nei loro confronti. Nel caso della Germania, questa scommessa implica di attirare più investimenti diretti tedeschi verso gli Stati Uniti, sia provocando un’ondata di delocalizzazioni nel contesto domestico, sia dirottando gli investimenti esteri tedeschi già in essere altrove (Cina).
Dalla fine degli anni Novanta fino in tempi recenti, l’euro ha formalizzato in maniera relativamente adeguata la combinazione di mercantilismo e imperialismo del capitale tedesco sui due piani summenzionati, ovvero in seno alla propria zona monetaria e al di fuori: un’isola di cambi fissi in un oceano di cambi fluttuanti; una valuta allo stesso tempo forte e svalutata quanto basta per accrescere la competitività delle esportazioni tedesche al di fuori dell’eurozona. Quali che siano i lidi verso i quali il capitale tedesco si dirigerà nei prossimi anni, il necessario prevalere dell’esportazione di capitali sull’esportazione di merci renderà probabilmente superflua la svalutazione del Deutsche Mark data dall’euro. Ciò vale anche nell’ipotesi di un ricentramento degli investimenti diretti tedeschi sul continente, corrispettivo economico del grande spazio di schmittiana memoria.
Conclusione: guerre di oggi… e di domani
Il piano di riarmo europeo ReArm Europe (già ribattezzato Readiness 2030) va visto e analizzato alla luce delle tendenze e dei processi messi in luce fin qui. Verosimilmente, esso avrà effetti differenziati a seconda dei paesi, dei loro tessuti produttivi e delle loro capacità di riconversione dal civile al militare (ad esempio il settore automotive tedesco e il suo indotto). Inoltre, esso verrà attuato in un contesto di perdita di controllo delle alte istanze dell’UE sulle spinte centrifughe, e reciprocamente conflittuali, agite dagli Stati membri o da gruppi di Stati membri.
Il ruolo della Germania in questo quadro non è ancora definito, e dipende dal suo posizionamento su una scacchiera più grande. Sulla carta, essa ha tre opzioni: a) rafforzare la sua posizione di junior partner di Washington, puntando tutto sull’accesso agli Stati Uniti sia come mercato di sbocco, sia come zona privilegiata di investimento; b) cercare di traghettare l’UE o una parte di essa verso un’intesa «eurasiatista» con la Cina (in attesa di poter riallacciare i rapporti con la Russia); c) decidere di contare sulle proprie forze, tentando ancora una volta la carta dal grande spazio, nell’ottica di svuotare gli altri paesi europei dei loro capitali nazionali.
L’occasione fa l’uomo ladro: a più di una decina d’anni di distanza dalla crisi dei debiti sovrani in Europa, i paesi della facciata atlantica e mediterranea sono ormai sufficientemente indeboliti da non potersi opporre ad una scalata aggressiva del capitale tedesco nei confronti delle loro economie. Resta una sola vera spina nel fianco: la Polonia. Significativo in questo senso che fra i sedici paesi che hanno finora attivato il principale dispositivo del piano di riarmo europeo (la clausola di esclusione delle loro spese militari dalle regole del Patto di stabilità e crescita), manchino all’appello la Francia, l’Italia e la Spagna, mentre i due principali paesi aderenti siano, guarda caso, Germania e Polonia: per farsi la guerra domani?
Per la Germania, il piano di riarmo si inscrive in una svolta più generale che la porterà ad aumentare considerevolmente la sua spesa pubblica. Si tratta di un keynesismo tutto sommato tradizionale, i cui eventuali benefici si faranno apprezzare sul lungo periodo. In quale misura questa politica economica sia una risposta al tentativo americano, già da tempo avviato e in fase di escalation, di suscitare un’ondata di delocalizzazioni e di investimenti diretti tedeschi negli Stati Uniti, è un interrogativo destinato a rimanere per il momento senza risposta. Comunque sia, ne va della sostenibilità del compromesso sociale domestico, nel solo paese europeo «occidentale»[8] che abbia conservato in tali proporzioni distretti industriali e grandi concentrazioni operaie sul suo territorio.
Nel frattempo, l’afflusso sul mercato obbligazionario europeo di un volume massiccio di Bund tedeschi, offrendo agli investitori finanziari un titolo di Stato di alta qualità e in quantità ben più grandi che in passato, potrebbe innescare tensioni questa volta focalizzate sulla Francia – tensioni che potrebbero sancire lo scioglimento dell’eurozona. E se fosse questo lo scopo ricercato? Dalla crisi del 2008 in poi, si sono molto rimproverate alla Germania le sue «ossessioni» austeritarie e le ricadute deflazionistiche della sua politica economica sugli altri paesi europei; meno si sono prese in conto le reali conseguenze di una Germania che le abbandona.
Ma a monte di simili passaggi, incombono in maniera più ravvicinata le conseguenze politiche della vittoria russa in Ucraina. Quando bisognerà infine mettere questa vittoria per iscritto, l’onda di discredito sulle istituzioni europee e sui gruppi dirigenti dei paesi che più hanno spinto l’Ucraina allo sbaraglio contro la Russia sarà prevedibilmente considerevole.
I movimenti sociali che potranno emergere da un simile scenario non saranno puramente proletari: saranno interclassisti, sovente nazionalisti, diretti contro il declassamento dei loro paesi dettato dalla leggerezza (vera o presunta, poco importa) di ceti politici sciagurati, e traditori del sacrosanto «interesse nazionale».
Ma è in simili movimenti, e non in altri più conformi ai nostri schemi e ai nostri desiderata, che bisognerà intervenire nell’ottica di far apparire un’opposizione di classe con una visione antisistemica (anticapitalista). È a questo livello che si pone a mio avviso la prospettiva di una ripresa del movimento di classe nei paesi dell’Europa occidentale e centrale, ed è in primo luogo a questo tipo di scenario che dobbiamo prepararci.
[1] Una traduzione italiana della lettera si può trovare in appendice all’antologia di Karl Marx e Friedrich Engels, La concezione materialistica della storia, Edizioni Lotta Comunista, Sesto San Giovanni, 2008. Reperibile anche qui: https://sinistracomunistainternazionale.com/wp-content/uploads/2015/06/lettera-di-engels-a-franz-mehring-14-luglio-1893.pdf.
[2] Per il resoconto storico di tutta questa parte, ho attinto a piene mani dal prezioso libro di Jean-Christophe Defraigne, De l’intégration nationale à l’intégration continentale. Analyse de la dynamique d’intégration supranationale européenne des origines à nos jours, L’Harmattan, Parigi, 2004.
[3] Per una storia delle alte istanze dell’UE, vedi Perry Anderson, «Ever Closer Union?», London Review of Books, vol. 43, n.1, gennaio 2021.
[4] Wolfgang Streeck, «Overextended: The Europeans DIsunion at a Crossroads», American Affairs, vol. IX, n.1, primavera 2025, pp. 100-125.
[5] Ibid.
[6] Ulrike Franke, «La questione tedesca secondo una millennial», Limes, n.1, 2022, p. 109.
[7] Vedi ad es. Joseph Halevi, «Il neomercantilismo tedesco alla prova della guerra», Moneta e credito, vol. 75, n. 298, 2022, pp. 203-211.
[8] Le virgolette sono d’obbligo. È solo al prezzo di grandi forzature e amnesie che la Germania può essere considerata come un paese «occidentale».