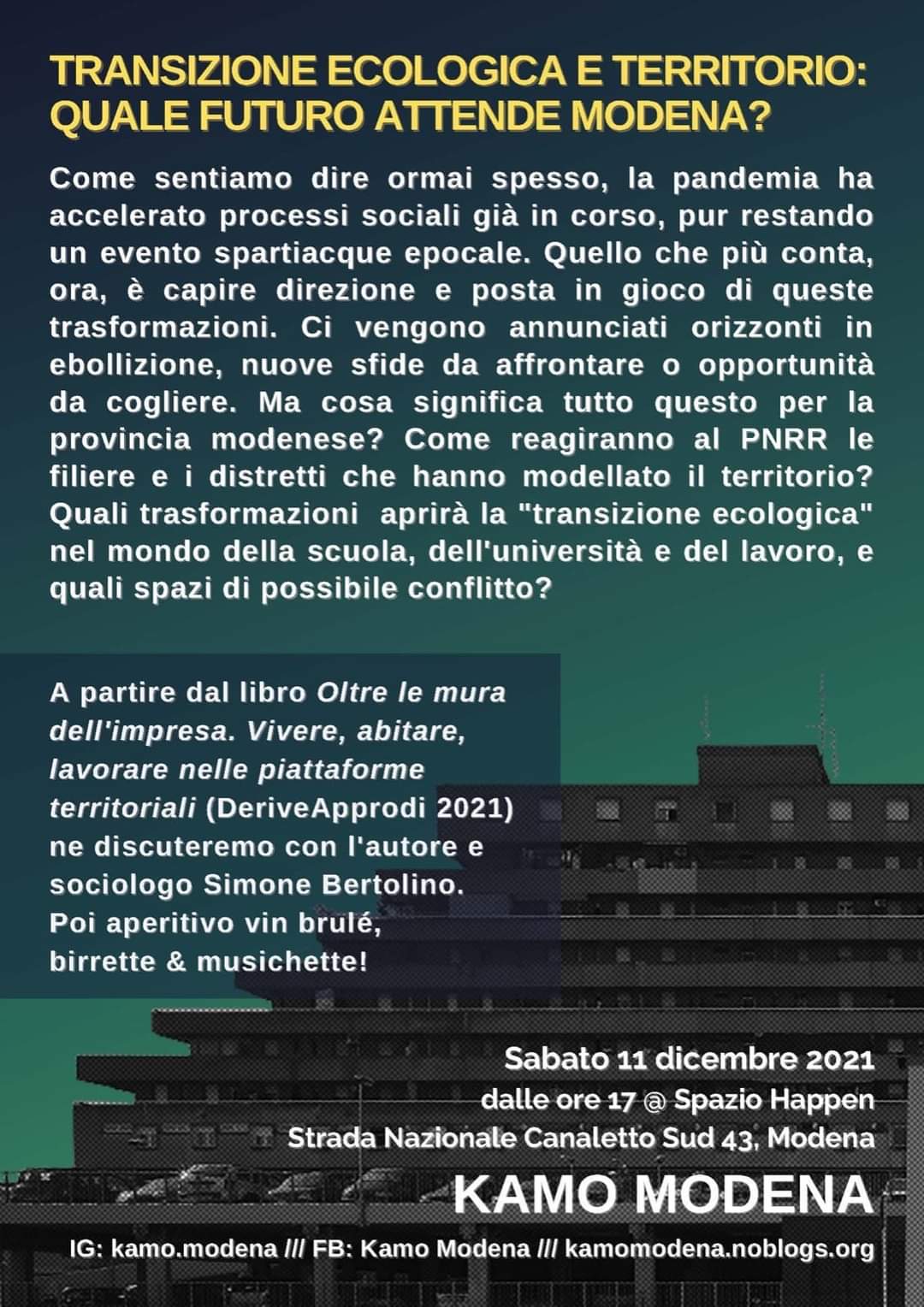Partiamo da una premessa. Resta per noi ancora valido un vecchio assunto, che indicava nel medio raggio la collocazione del militante. Quel «livello intermedio tra l’alto e il basso, tra la teoria e la pratica, tra l’astrazione determinata del comando e la determinazione astratta della vita quotidiana». È sul medio raggio che il militante va a verificare le proprie ipotesi politiche verso il basso e a correggerle verso l’alto, determinando in questo modo linea politica e linea di condotta. Il medio raggio, quindi, è il livello fondamentale dell’agire politico, perché è l’unico nel quale la ricerca militante può anticipare, scommettendo, su ambivalenze dei soggetti e tendenze dei conflitti a venire, restando ancorata ai processi reali.
Con questo crediamo che il terreno per ogni sperimentazione politica lo si debba ricercare intorno alla nostra collocazione. Si tratta quindi di scandagliare il quotidiano finché questo non disegna una ragnatela di contraddizioni, abbastanza qualitative da prefigurare possibili conflitti, quanto più prossimi a noi per restare direttamente percorribili. Un’analisi storica, per esempio, ci offre strumenti pratici se e soltanto se ci vieta di vagabondare tra nostalgie del passato e fantasie dell’apocalisse. Allo stesso modo, una mappatura geografica dei rapporti di forza contemporanei che non ipotizzi punti specifici di intervento rischia di condurre a una sterile contemplazione della complessità universale, a un litigio con le stelle. E noi sappiamo che la complessità va posseduta, non ammirata.
Una prima fonte di informazioni e strumenti interpretativi più che compatibili con questa prospettiva l’abbiamo trovata in Oltre le mura dell’impresa. Vivere, abitare, lavorare nelle piattaforme territoriali (Deriveapprodi 2021), una raccolta di saggi rivolti alla descrizione dei cambiamenti nel tessuto produttivo dell’Italia settentrionale intercorsi negli ultimi vent’anni. Certo, nel libro non si avanza un progetto politico vero e proprio, se non con vaghi cenni a una volontà di riequilibrare il rapporto tra flussi di capitale e i luoghi di vita, una prospettiva riformistica che – è inutile dirlo – non ci compete, lasciandola volentieri ad altri. Ciononostante, il repertorio analitico ci pare decisamente chiaro, approfondito ed efficace nel riassumere processi multiformi, e quindi a facilitare quell’indispensabile lavoro di inchiesta che i militanti conducono (o dovrebbero condurre) nei propri spazi d’azione.
Il libro si compone, oltre che di un’introduzione di carattere generale, di studi focalizzati su singole aree transregionali – la superficie lombarda, il Nordest, i circuiti economici emiliano-romagnoli e il Piemonte postfordista – che si ritrovano accomunate tra loro per il fatto di reagire a trasformazioni capitalistiche in corso attraverso una medesima macro-traiettoria. Per quanto i contorni della fase a venire siano necessariamente indefiniti e in questi processi abbondino le specificità locali, possiamo riassumere l’attuale congiuntura nella centralità che assume il triangolo produttivo tra la Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna (convenientemente soprannominato LO.VE.R), che in parte sostituisce il precedente trinomio Genova-Milano-Torino. A differenza dal precedente, infatti, il nuovo triangolo non fa affidamento ai suoi vertici, situati sulle grandi imprese dei capoluoghi, bensì ai suoi lati, tracciati da grappoli di imprese in evoluzione e poli metropolitani che attraggono risorse qualificate e servizi avanzati. Una diffusione territoriale, dunque, di logiche di valorizzazione industriali.
In questo contesto, sono le città di medie dimensioni a svolgere il ruolo di testa di ponte di tali dinamiche. Intorno ad esse si è infatti stabilita un’ossatura di attività terziare in continua espansione, che garantisce sia un collante tra provincia e grandi flussi di capitale, sia il rinnovamento selettivo delle vecchie città-distretto (a sua volta una momentanea risposta alla crisi del fordismo, ma costretta in ambiti manifatturieri non più all’altezza degli attuali livelli tecnologici o catene del valore), sia un parziale assorbimento di una popolazione in età lavorativa altrimenti eccedentaria. Le città medie si ritrovano quindi ad affrontare il compito di organizzare reti di connessioni per attrezzare i territori di canali di impiego e valorizzazione all’altezza di questo periodo confuso di transizione. A tal fine diventa indispensabile moltiplicare le traiettorie che conducano a stabilire delle clientele robuste internamente ed esternamente, facendo leva su una reale o presunta specificità territoriale. Per questo motivo grosse moli di investimenti monetari e umani sono state indirizzate non solo alla ristrutturazione delle attività manifatturiere locali, ma anche e soprattutto all’assorbimento e all’(iper)industrializzazione (concetto di Romano Alquati) di forme della riproduzione sociale, dell’abitare, della partecipazione cittadina e della vita pubblica che apparentemente sembrerebbero agli antipodi rispetto all’industria.
La fabbrica diffusa, il territorio-fabbrica, si disegna quindi come un reticolato interconnesso ed eterogeneo di poli produttivi, università, ospedali, utility, fiere, piattaforme digitali, grandi progetti di riqualificazione: insomma, come insieme di cluster economici attivi nelle sfere della riproduzione, dall’organizzazione del consumo e giù fino alle infrastrutture che garantiscono le condizioni della vita personale. Una volta ristabilita quale cuore nevralgico della struttura cittadina, questa circolazione di valore reindirizza a monte la produzione tradizionale di beni. È opportuno quindi sottolineare come non si stia parlando di un mero utilizzo opportunistico di retoriche progressiste o ecologiste da parte capitalistica (pinkwashing, greenwashing e simili), ma dell’integrazione reale di elementi chiave della socialità e della qualità della vita (dalla condizione abitativa e la salute alla salvaguardia naturale) come fulcro del rilancio del sistema capitalistico nelle sue forme più internazionalizzate e finanziarizzate. Ma questa ripresa ha il suo prezzo.

Accanto a questi agglomerati produttivo-residenziali in ascesa, si notano infatti un folto numero di coni d’ombra produttivi e di aree di fragilità demografica, che solo a fatica riescono a mantenere un ruolo attivo in una congiuntura di tal fatta, ritrovandosi comunque sempre sull’orlo del declino. Nonostante la fanfara mediatica dei mesi di lockdown, che starnazzava le virtù del ritorno ai borghi e la fuga dalle città, permane il rischio di marginalizzazione e spopolamento per mancanza di sbocchi impiegatizi e di servizi nei comuni appenninici o nella nebulosa di aree a mancata transizione industriale come la Bassa, favorendo l’insorgere di sensazioni e paure di proletarizzazione in pezzi di ceto medio che progressivamente paiono procedere verso un “secondo tempo” del momento populista (apparentemente) lasciatoci alle spalle. Il pendolarismo risulta sempre meno una risposta adeguata a fronteggiare questi deserti lavorativi e abitativi, e il ventaglio delle soluzioni alternative si assottiglia. Tuttavia, anche internamente a questi settori di progressivo svantaggio si osservano disomogeneità e tendenze ambigue.
In alcuni contesti, l’arretramento verso la marginalità e la retrocessione verso forme di lavoro arcaiche risultano compatibili o persino funzionali all’innesto dei canali di verticalizzazione transnazionali – come dimostrato dall’esempio ormai abituale dell’apertura dei magazzini Amazon (a Piacenza, Scandiano, Spilamberto, ecc.) nei comuni con tassi di disoccupazione a crescita più rapida – , mentre altrove si rilevano scenari di netta crisi, collocata nel punto di intersezione tra due diversi campi di forze capitalistiche. Da una parte, un reticolo di imprese locali moribonde, segnate da difficoltà decennali e ormai croniche; dall’altro le dinamiche delle economie globali. Ne derivano continue tensioni tra tendenze alla razionalizzazione o all’automazione e la presunta natura “sociale” e “umana” del capitalismo di territorio. Dove sfuma la possibilità di inserirsi in circuiti più ampi (i quali, inevitabilmente, imporranno le loro traiettorie), intere sezioni di lavoro e imprese sono semplicemente lasciate morire di stenti. Le frizioni si complicano poi ulteriormente osservando che se nel Nord metropolitano – grazie al quale si alimentano i grandi processi delle economie immateriali – la pandemia ha pesato nella maniera più tragica, nelle aree interne e interstiziali questa ha gravato proporzionalmente di meno, ma ha probabilmente accelerato processi di declino antropico e di isolamento.
Come si è visto, una volta adottata una lente temporale e spaziale di medio-raggio diviene possibile seguire più agilmente i contorni dei presenti squilibri nella conformazione urbana e nella composizione sociale, in un contesto nel quale il capitale tenta di sopravvivere alle proprie crisi mostrandosi pronto, dove necessario, a “mangiare se stesso”. Ma cosa vediamo nei nostri luoghi di vita e d’azione, vale a dire l’Emilia centrale e la provincia modenese?
Qui sono due i pilastri su cui si regge la ristrutturazione della produzione: l’innovazione pianificata dall’alto, sostenuta da specifiche policies regionali, e il continuo intreccio di coalizioni tra imprese e corpi intermedi locali in basso. Il meccanismo risulta qui particolarmente rodato, considerando la storia della regione “rossa” e ricordando i tre vettori che hanno costituito il cosiddetto “modello emiliano”, almeno nelle sue ultime fasi: a) forti politiche regionali tese alla costruzione di un ecosistema dell’innovazione tecnologica, collegata soprattutto all’export; b) la progressiva estensione e depoliticizzazione del terzo settore e del volontariato come erogatore di welfare; c) l’enfasi sulla dimensione “civica” e “partecipativa” della vita urbana quale strumento per una governance della crescita. Tuttavia, nel corso degli ultimi venti anni questo blocco amministrativo ha incontrato difficoltà e rallentamenti, che hanno favorito l’affermazione di sfidanti all’egemonia amministrativa tradizionale, M5S e Lega su tutti. Allo stesso tempo però, come hanno indicato le passate elezioni, si ipotizza una ripresa delle élite cittadine classiche, la cui agenda pro-crescita e pro-green potrebbe trovarsi consolidata nei prossimi anni, tenendo presente le parole d’ordine e la via tracciata dal Pnrr.
Molti indicatori fanno infatti ipotizzare un tentativo di ri-creazione di un nuovo ceto medio di “competenti”, tardo-giovanile, a cultura tecnica e civile, messo a valore politico come spina dorsale della ristrutturazione degli assetti economico-gestionali dei territori (post)pandemici. Il frutto di tale progressiva sinergia e organicità tra università e imprese leader, ricerca e servizi avanzati attivi nella digitalizzazione o nella sostenibilità ambientale sarà quindi una fabbrica sistemica, diretta alla qualificazione selettiva delle filiere e all’istituzionalizzazione delle reti collaborative collettive, che presume anche la ristrutturazione stessa della forza-lavoro: la formazione di una classe operaia 4.0 per un’industria 4.0 per la quale il ruolo di Istituti tecnici ed enti formativi regionali diventerà baricentrale. Si prelude quindi a un salto di scala, non soltanto per l’intensità della capitalizzazione, ma anche e soprattutto per l’espansione della fabbrica diffusa come organismo di gestione urbana, e la conseguente produzione capitalistica di nuove soggettività. Citando il volume, si tratta di
un modello di policy che punta ad accompagnare la creazione di esternalità e a incorporare nelle filiere sapere tecnoscientifico nelle culture e modelli produttivi attraverso la formazione condivisa tra imprese e istituzioni di nuove leve di operai, tecnici, quadri, manager, una sorta di “cervello sociale” costituito non solo da saperi astratti e R&S, ma da etica del lavoro, passione collettiva, qualità della vita urbana, servizi, infrastrutture collettive pubbliche e private, start-up e nuova composizione sociale. Un ecosistema/piattaforma che sostiene processi trasversali e che funziona come meccanismo di traduzione di tutte queste risorse sociali in forza competitiva. Una industria che si alimenta non solo di macchine, ma di fattori immateriali, di qualità culturali. Il nucleo motore del “modello emiliano” oggi risiede in primo luogo in una visione progressista e di nuovo umanesimo industriale nel senso della produzione di capitale umano di nuovo tipo, a sostegno di una industria che incorpori la questione del limite ambientale, in cui la crescita industriale equilibrata consiste nel promuovere sistemi industriali diffusi più che singoli settori, e le capacità collettive di produrre “teste ben fatte” e capitale territoriale. (p. 158).
Il capitolo sull’Emilia, scritto da Simone Bertolino e Albino Gusmeroli, a nostro modo di vedere espone in maniera eccellente le sfaccettature di questi processi, descrivendo dettagliatamente le trasformazioni nella cooperazione pubblica e nelle mediazioni istituzionali, nel mecenatismo delle imprese e nella progettualità sociale; ma il merito maggiore resta quello di aver ben evidenziato l’altra faccia dello sviluppo. Come già negli anni Settanta i ricercatori raccolti intorno ai «Quaderni del Territorio» avevano dimostrato, lo sviluppo industriale e tecnologico di alcune aree si determina in funzione di retrocessione e sottosviluppo di altre aree. Per dirla in altri termini, non si comprende fino in fondo cosa comporti il modello delle “valley” (Motor Valley, Food Valley, Data Valley ecc.) strettamente collegato alle catene del valore globali (e tedesche) né la loro trasversalità rispetto alle classiche partizioni tra manifatturiero, terziario, agroalimentare, ICT e reti urbane se non si tiene sullo sfondo il costante decadimento delle aree marginali, interne e appenniniche, segnate da spopolamento crescente, alti tassi di disoccupazione e rarefazione delle risorse comunitarie di base. Le ripercussioni sociali di questi andamenti sono difficili da anticipare, ma già ora sollevano grosse domande.
Potremmo ipotizzare, ma non ci spingiamo più oltre, che la recente ondata di femminicidi, omicidi-suicidi familiari e violenza cruenta nelle retrovie delle “province ricche” sia almeno in parte leggibile in questo contesto. Come spesso accade, chi non vede un domani davanti a sé, e non cerca la trasformazione dell’esistente, può cercare il tramonto, il tramonto tout court. Se poi teniamo presente che, in questi luoghi, insieme allo sfaldamento comunitario si dirada sempre più una militanza complessiva che tenga insieme anticapitalismo e questione di genere, o anche solo che le risorse per case delle donne diventano sempre più inadeguate e che la cura della salute mentale retrocede nelle agende cittadine, appare evidente la dimensione strutturale del fenomeno, che eccede di lungo gli steccati quietistici della cronaca locale.
Sospendiamo per un momento le ipotesi, e ritorniamo su dati ormai sicuri. Infatti, non dobbiamo dimenticare che anche le aspettative coltivate nel processo di costruzione di questo possibile nuovo ceto medio, legato alle possibilità di rilancio dell’accumulazione capitalistica e dello sviluppo (post)pandemico, saranno con ogni probabilità infrante. Non solo su episodi di forte frustrazione e di nero disincanto una volta addentato il frutto dell’ipocrisia progressista e civica su temi come la partecipazione, l’inclusione o l’ambiente. Anche allargando lo sguardo, in un contesto geopolitico e geoeconomico in forte tensione e segnato per i prossimi anni dal Pnrr – vale a dire uno sfondo interamente segnato dalla ristrutturazione della globalizzazione per come l’abbiamo conosciuta fino a oggi, dal peso immane di un debito ormai difficilmente quantificabile e senza alcun margine per far ripartire cicli stabili di accumulazione, per non parlare del collasso ecologico – non si vedono garanzie per la tesaurizzazione dei risparmi o per un moto complessivo di ascesa sociale. Non a caso vari indicatori sottolineano fin da adesso un graduale divario tra le aspettative crescenti di fasce lavorative giovanili (si veda la “Great Resignation”, l’epidemia di dimissioni e di interruzioni volontarie da contratti di lavoro a tempo indeterminato, specialmente impiegatizi o del terziario) e le serie conseguenze a breve termine della ristrutturazione su questi settori (per esempio, l’aumento costante e generalizzato dei prezzi delle soluzioni immobiliari rivolte a ceti riflessivi “cool” e al lavoro autonomo giovanile, come i trilocali in area urbana).
Per concludere. Se queste ipotesi saranno verificate, ci domandiamo se la scommessa da lanciare non sia allora quella di inchiestare, oggi, le ambivalenze di soggettività baricentrali per il tentativo di rilancio sistemico dell’accumulazione capitalistica postpandemica, e anticipare lo scoppio di queste contraddizioni, per iniziare sin da ora un lavoro di medio periodo che consenta di inseguire una possibile, futura, nuova qualità del conflitto ed essere collocati nel vivo dei processi per non accodarcisi una volta manifestati, piuttosto che rincorrere soggetti della marginalità entro cui difficilmente si potrà perseguire una prospettiva qualitativa della rottura. Conviene investire sugli “obsoleti”, i “non rappresentati” di oggi – in cerca di nuova integrazione piuttosto che di inimicizia e sovversione – o i “delusi”, i “traditi” di domani, cioè i soggetti che recano su di sé l’esperienza della trasformazione del medio-raggio? È una pista che soltanto la prassi potrà saggiare, mettere a verifica e valutare. Nulla dunque da dare per scontato.