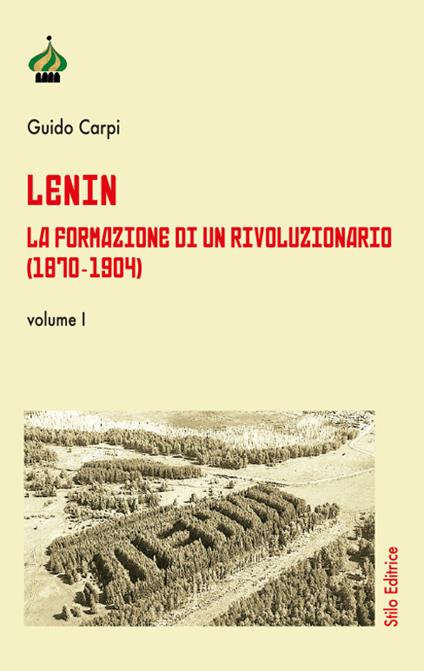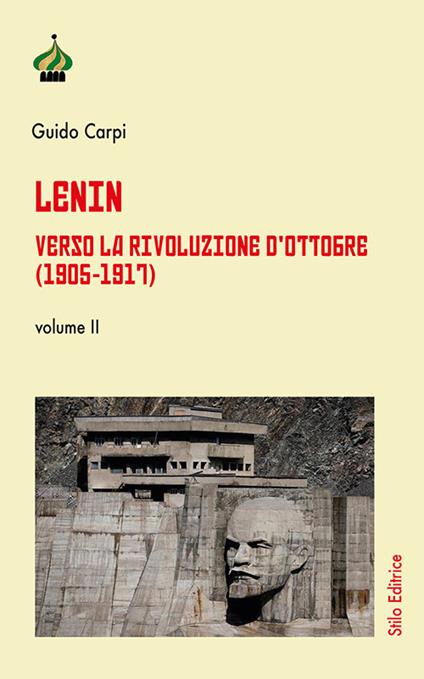Nella memoria collettiva, la militanza politica sembra scomparire dopo l’assalto al cielo degli anni Settanta. La fase iniziata con gli anni Ottanta, ancora in corso, appare come un “buco nero”. È il periodo della reazione ai grandi cicli di lotte, quello della controrivoluzione capitalistica, del riflusso nel privato, dell’epidemia di eroina, dell’edonismo dilagante, della precarietà generalizzata, dell’avvento di internet e del mondo unipolare, che ha portato al mondo come lo conosciamo oggi.
Tuttavia, gli ultimi quattro decenni non sono stati affatto privi di conflitti, sperimentazioni, movimenti e forme di organizzazione politica anche originali, tra ambivalenze e contraddizioni, che si sono dovuti confrontare con la crisi della militanza: dal movimento antinucleare a quelli studenteschi della Pantera e dell’Onda, dalla stagione dei centri sociali alle mobilitazioni noglobal, dalle tute bianche al blocco nero, fino agli “ultimi fuochi” del 15 ottobre 2011 e alle “piazze populiste” degli anni recenti.
Quali sono stati i soggetti sociali protagonisti degli ultimi movimenti? Quali sono stati pregi e limiti delle loro forme di organizzazione? Come si è trasformata la militanza e il conflitto di fronte all’attivismo e alla testimonianza? Se siamo di fronte all’esaurimento di un ciclo, come immaginare (e praticare) di andare oltre? Ripercorrere questi “decenni smarriti” vuol dire confrontarsi con i nodi irrisolti del presente, per riarmare il pensiero di fronte all’attualità, e costruire una prospettiva solida dentro e contro la storia di oggi. È quello che vuol dire essere militanti.
Ne abbiamo discusso, il 17 giugno a Modena, con Gigi Roggero – ricercatore militante, collaboratore della rivista «Machina», autore di Elogio della militanza (2016), Il treno contro la Storia (2017), L’operaismo politico italiano(2019), Per la critica della libertà (2023), tutti pubblicati con Deriveapprodi – nell’incontro che ha chiuso il ciclo MILITANTI.
Ci sembrava necessario, nel ritessere e riappropriarci di una genealogia e di una storia di parte, ripercorrere criticamente gli ultimi decenni, in particolare quelli da cui la nostra generazione politica proviene e si è formata. Non solo per dare qualche spunto di chiarificazione di dinamiche e processi per lo più sconosciuti alle nuove generazioni che si affacciano a percorsi di militanza politica, ma per osservarli e trattenerli con lucido distacco, quello necessario a mettere in discussione comode certezze, abitudini sedimentate, consueti modi di intendere e di fare che crediamo oggi girino a vuoto, o che semplicemente non ci bastano più – o meglio, non bastano più nella fase in cui ci troviamo. Guardare la strada da cui veniamo, di cui siamo debitori sia di errori e cadute che di saperi ed esperienze, per metterla in prospettiva, in una mappa più ampia: dove la destinazione rimane la stessa, ma vecchi sentieri vanno riaperti, e nuovi battuti. Sentieri impervi, non lineari, poco frequentati, tutti in salita. Sono quei sentieri che, visti dall’alto, sembrano rette, ma che per tracciarli occorre percorrerne la curva.
Certezza di perdersi, scarse probabilità di successo: gli unici sentieri che valgono di essere affrontati insieme.
Gigi Roggero
Non vi dico che “sarò breve”, perché non sarebbe credibile; quindi, saltiamo le premesse irrealistiche. Partirei piuttosto dicendo che auspico soprattutto di aprire un momento di confronto, e che condivido l’interpretazione che i compagni di Modena danno a questa congiuntura. Anzi, la tesi che presentano è quasi pacata. Direi che siamo in una fase in cui, per usare dei termini gramsciani (indipendentemente da Gramsci, che francamente non mi suscita un gran entusiasmo), «il vecchio fatica a morire e il nuovo fatica a nascere». Mi pare che, in estrema sintesi, l’attuale situazione sia questa. Poi si potrebbe anche dire che, oltre a non avere una particolare simpatia per Gramsci, non ho alcuna simpatia per i termini “vecchio” e “nuovo”… ma la metafora è comunque utile per definire lo scenario presente.
Entrando nel dettaglio, che cosa contraddistingue il nostro presente, specialmente per chi, come noi, si è sempre riconosciuto come “militante di movimento”?
A questo proposito facciamo un passo indietro, e partiamo da questa nostra identificazione abituale, in modo tale da meglio comprendere dove stia il succo politico della questione.
Ora, il termine “militante di movimento” è una cosa che potete sentire solo in Italia. Il termine “movimento”, fuori dall’Italia, non significa nulla di quello che noi intendiamo. Quando qui si diceva “militante di movimento”, si intendeva una cosa precisa, ovvero il militante esterno ai partiti che si impegnava, in modo organizzato, per trasformare l’esistente; mentre all’estero e specialmente nel mondo anglosassone – il terrificante mondo anglosassone, da cui proviene tutto il male possibile – il “movimento” sono i social movements, le mobilitazioni sociali. Infatti, a partire dagli anni Ottanta, ci fu chi iniziò a teorizzare che la forma dominante delle mobilitazioni sarebbe stata quella dei movimenti single issue, ovvero imperniati su un singolo tema: banalmente, si minaccia l’apertura di una discarica vicino a casa mia o una centrale nucleare e si raccoglie intorno a questo tema una cerchia di attivisti. Insomma, movimenti legati a una causa specifica e il cui ciclo di vita è legato ad essa. Si vince o si perde, e poi tutti ritornano a fare quello che facevano prima.
Invece qui il “movimento” indica un’anomalia italiana. Nel dibattito ufficiale della sinistra degli anni Novanta si insisteva nel dire che l’anomalia italiana era incarnata da Silvio Berlusconi. Soltanto dopo ci si è resi pienamente conto che la vera anomalia è quanto successo negli anni Sessanta e Settanta (di cui voi avete parlato nello scorso incontro). L’eccezionalità stava tutta dentro un processo di lotta di classe assolutamente unico sul piano internazionale. Capiamoci, in quei decenni non sono sorti processi di lotta solamente in Italia; ma l’Italia è stata caratterizzata dalla lunghezza straordinaria di questi cicli di conflitto, iniziati nei primi anni Sessanta con le lotte operaie, proseguiti nel ’68-’69 dall’alleanza tra operai e studenti, e continuati negli anni Settanta con l’emergere di nuove figure del conflitto, tra cui l’“operaio sociale” (indipendentemente che questa categoria abbia tenuto alla prova dei fatti o meno).
Ecco, questi due decenni di conflitti incredibilmente intensi nel sociale, capaci di mettere realmente in discussione i rapporti di potere sul piano sia politico che produttivo, sono stati condotti non solo al di fuori delle strutture dei partiti esistenti e segnatamente del Partito Comunista, ma contro il Partito Comunista. E questo, badate bene, non in una forma anarchica o anarchicheggiante, bensì organizzata e contrapposta all’incancrenimento degli organi ufficiali del mondo operaio. Anche all’estero questa anomalia italiana è difficile da far comprendere, tant’è vero che la declinazione dell’Autonomia in giro per il mondo è soprattutto in chiave libertaria (sono in parecchi a definirsi anarchici ma guardano con interesse o persino come modello all’Autonomia). E così, proprio la forza e la durata del movimento in Italia ha fatto sì che per decenni dire “sono un militante di movimento” significasse qualcosa di specifico.
Ebbene, oggi il vecchio che fatica a morire è esattamente questo. Cioè assistiamo prima al disfarsi di un qualcosa che non è più produttivo, che non crea più senso comune né immaginario collettivo, ovvero “il movimento”; e poi l’esaurirsi di quello che sono stati i centri sociali. Infatti, se da un lato la forma partito, per come è stata intesa tradizionalmente nel corso del Novecento, sotto molti aspetti era già declinata e morta – anzi, l’operaismo prende le mosse proprio da una critica della forma partito – a questa critica non è seguita una pars construens all’altezza della situazione. Ci sono stati vari tentativi, ma rimane il buco nero delle nuove forme di organizzazione appropriate alla composizione di classe e alle sue trasformazioni.
Che cosa succede negli anni Ottanta? Come ricordavano i compagni in apertura, sono anni a dire il vero poco entusiasmanti, segnati dallo stigma della controrivoluzione capitalistica, su cui ritornerò più oltre; sono gli anni dello yuppismo e della “Milano da bere”; ma anche gli anni seguenti, concedetemi il termine, alla repressione. (Per inciso, “repressione” è un termine che non mi piace usare. Non perché non esista: la repressione è connaturata e non possiamo aspettarci che il nemico sia buono; ma perché non credo mai che dei movimenti possano essere sconfitti solo sul terreno della repressione. Se un movimento perde quando arriva la repressione è perché c’erano dei limiti precedenti non risolti, e non è un problema di razionalità di gestione, ma di rapporti di forza: se uno ha la forza vince, se non ce l’ha perde. E la repressione ha successo quando i rapporti di forza sono in mano al nemico).
Ma torniamo a noi. Parlare degli anni Ottanta significa anche parlare della sconfitta dei decenni precedenti e della sua costellazione di cause (che non analizzerò perché ne avete già parlato). Certo, se mi permettete una provocazione, devo dire che non è sempre facile farlo con chi è uscito dall’esperienza dei Settanta. Si tende sempre ad esaltare quei momenti altissimi, come è ovvio; ma viene comunque da chiedersi: “Ma scusate, se gli altri hanno vinto, ci sarà un motivo?” Come uno che va allo stadio e dice: “Abbiamo giocato benissimo, partita pazzesca…”, “Sì ma a quanto è finita?” “Tre a zero per gli altri”.
Certo, le sconfitte non sono tutte uguali. La sconfitta degli anni Settanta ha lasciato tante cose e noi tutti abbiamo vissuto con una straordinaria eredità consegnataci da quella fase. Però, indubbiamente, gli anni Ottanta sono anni di scomposizione di quanto era stato costruito prima; anni di dispersione, di ritorno al privato, di eroina, di individualismo sfrenato, di paninari… tutte cose che già sappiamo. Ma sono stati anni anche più complessi di così, sebbene finora ci si sia interrogati poco. Proprio per questo, qualche settimana fa abbiamo organizzato un festival insieme alla rivista «Machina» per costruire una “cartografia dei decenni smarriti”, su questi periodi sui quali sappiamo ancora poco all’infuori dei soliti discorsi sul tatcherismo e il reaganismo. Ci sono state anche diverse lotte e numerosi sviluppi nei nostri strumenti, ma ancora dobbiamo esplorarli a dovere per capire dove siamo oggi.
Ritorno ora a un argomento che avevo solo accennato, perché a mio modo di vedere è cruciale per inquadrare bene il tema. “Controrivoluzione capitalistica” non significa “reazione”. Per fare un esempio, reazionario è il Congresso di Vienna, cioè l’utopia passatista (peraltro, fallita) di riportare le lancette dell’orologio a prima del 14 luglio 1789. Allo stesso modo, gli anni Ottanta non sono stati il tentativo di ritornare alla fase precedente al ciclo degli anni Sessanta, restaurando, che so, l’autoritarismo nell’università humboldtiana o il dispotismo di Vittorio Valletta nella produzione.
La questione è molto diversa: con “controrivoluzione” intendiamo una “rivoluzione al contrario”. Significa, cioè, che il capitale ha messo a valore i processi rivoluzionari. Del resto, il capitale funziona precisamente in questi termini. Già Marx, nella Miseria della filosofia, sosteneva che la più grande risorsa produttiva per il capitale è la classe operaia rivoluzionaria. Il capitale si innova, si ristruttura e fa balzi in avanti se riesce a mettere a valore i processi di lotta e conflitto. E precisamente così negli anni Ottanta vediamo il capitale assorbire, inglobare, quella ricchezza soggettiva scatenata nelle lotte degli anni Settanta, rovesciandola di segno.
Pensate, per esempio, alla questione della precarietà e della flessibilità. C’è un libro di due francesi, Boltanski e Chiappello, che analizzano la letteratura manageriale. Be’, fanno vedere che nella manualistica imprenditoriale degli anni Settanta e in quella degli anni Novanta la parola “flessibilità” ritorna in pari misura. Però nel primo caso è associata al terrore dei padroni per l’autonomia del lavoro vivo: è una flessibilità di parte, la flessibilità del rifiuto del lavoro, del sabotaggio, della fuga dalla fabbrica, del lavorare meno. Negli anni Novanta, invece, la stessa parola ritorna a segno invertito: una flessibilità imposta dallo sviluppo capitalistico che diventerà, come abbiamo poi visto, la ricetta salvifica per tutte le politiche del lavoro. Cos’è successo? Semplicemente, si sono rovesciati i rapporti di forza.
Oppure pensate anche al berlusconismo. Berlusconi rappresenta, volenti o nolenti, lo spirito libertario del ’77. Ovviamente in una chiave tutta rovesciata: non in chiave collettiva ma individuale, non di rottura dal capitalismo ma di suo rilancio, eccetera. Pensate anche al recupero della rivoluzione sessuale (da Ambra alle olgettine) o del ruolo della comunicazione: Canale 5 non è altro che la valorizzazione capitalistica di quella rottura del monopolio Rai sulla comunicazione avanzata dalle radio libere, non più giocata in una dinamica di movimento, ma semplicemente per arricchire. Controrivoluzione significa questo.
Cosa succede quindi in quegli anni alle nostre latitudini? Ci sono tentativi di “resistenza”, dove le realtà organizzate hanno tenuto (per esempio in Veneto), e hanno tentato di creare nuove forme di coordinamento: per esempio il Coordinamento antinucleare antiimperialista, che fu protagonista di battaglie accesissime che hanno ottenuto grossi risultati – anche se è un po’ enfatico sostenere che la vittoria sul nucleare venisse dall’ala più radicale e tutto sommato minoritaria.
Tuttavia, sono stati rilanci sempre inseriti in un’ottica di resistenza e in un piano di continuità e rispetto agli anni Settanta. In parole povere, trovavamo un ceto militante e gli immediati eredi dei gruppi in disfacimento che cercavano di rimanere in piedi in un terreno ostile. Era una resistenza che difficilmente si accompagnava alla comprensione delle nuove soggettività che stavano emergendo. Cosa voglio dire? Che per varie ragioni (la mia non è una polemica, un “bisognava fare” o un’accusa di incapacità: è solo un’analisi di un macroprocesso) questi gruppi militanti non erano in connessione con le trasformazioni delle soggettività sociali. Anche gli anni Settanta, attenzione, non erano stati portati avanti solo dai gruppi militanti, essendo questi, come è noto, in strettissima relazione a soggetti sociali concreti, come l’operaio massa e l’operaio sociale. Al contrario, negli anni Ottanta assistiamo a un tentativo di tenuta di gruppi militanti piuttosto sconnesso dalle trasformazioni sociali in corso, che furono intercettate molto meglio da altri soggetti politici.
Quali? La Lega, innanzitutto: nei territori del Nord-Est, è la Lega a capire la direzione della trasformazione e a capire come aggregare il piccolo o piccolissimo imprenditore o il lavoratore autonomo (che, tra l’altro, parte anch’esso dal rifiuto della fabbrica ma, non trovando più una dimensione collettiva di riferimento, piega in senso individualista). Anche il tema dell’indipendentismo non è soltanto un argomento retorico sventolato opportunisticamente, ma qualcosa di sentito davvero, che si incarna dentro un pezzo di composizione sociale importante: se aveste girato in quelle zone in quel periodo, avreste trovato cose che ricordavano i Paesi Baschi, con un radicamento reale ed effettivo, testimoniato dai muri tappezzati di slogan. Insomma, a Lega rimane l’ultimo partito del Novecento con una propria struttura militante. E questo, lo ripeto, grazie alla capacità indubbia di cogliere le trasformazioni della composizione sociale, declinate e giocate in un senso chiaramente interclassista e dunque non in una prospettiva rivoluzionaria.
Il primo scarto, finalmente, viene dato dal movimento della Pantera. Tra la fine del 1989 e l’inizio del 1990, iniziano a essere occupate le facoltà. La prima occupazione è a Palermo, ma subito la mobilitazione dilaga in tutta Italia, arrivando a costituire il primo grosso movimento studentesco dopo il Settantasette e a segnare una generazione intera. Il motivo scatenante è una riforma, firmata dall’allora ministro Ruberti, con cui si introducevano processi di privatizzazione, di costituzione di scuole di serie A e serie B e via di questo passo; ma non è questo il nocciolo della questione. O meglio, sarebbe interessante rianalizzare oggi la riforma Ruberti ed entrare più nel merito della Pantera; ci basti dire, per adesso, che in prima istanza la Pantera ha rappresentato l’emergere di un soggetto sociale (nella fattispecie, studentesco e universitario) che rivitalizza degli spazi fino ad allora confinati alla semplice e strenua resistenza, alla sopravvivenza.
Non è che prima della Pantera non esistessero i centri sociali o strutture simili; non ci sono dubbi però che il loro grande balzo in avanti avviene in quella congiuntura, a Roma e non soltanto. Dopo la Pantera, per quattro-cinque anni nascono centri sociali occupati ovunque, e di pari passo inizia a crearsi un discorso sugli spazi autogestiti estremamente diffuso in una minoranza giovanile. Una minoranza, certo, ma una minoranza comunque piuttosto consistente, e soprattutto carica di ambivalenze. Infatti, non bisogna pensare che i centri sociali abbiano in sé una connotazione politica esplicita. I centri sociali, per alcuni anni, sono effettivamente “sociali”: sono degli spazi di aggregazione giovanile, punto. Per esempio, io vengo da un paesino in provincia di Torino di 16 mila abitanti e all’inizio degli anni Novanta c’era un collettivo per l’occupazione degli spazi composto di 40-50 ragazzi; però non erano 40-50 “compagni” o “militanti”: erano più semplicemente dei ragazzi che volevano degli spazi di aggregazione laddove mancavano.
È un periodo, l’ultimo direi, di produzione controculturale orbitante intorno al vecchio movimento: è il momento tanto delle Posse, quanto di alcuni gruppi che di lì a poco andranno a suonare a Sanremo. È un punto su cui vale la pena soffermarsi, a patto di non intenderlo in senso moralistico, come dei “traditori che hanno tradito”, ma sforzandoci piuttosto di notare il cambiamento di certi processi. Voglio dire, con il senno di poi è diventato chiaro che i centri sociali sbocciano in una fase di non ancora dispiegata sussunzione capitalistica di quegli stessi spazi che, nel giro di pochi anni, verranno completamente sussunti. Faccio qualche esempio concreto per fare capire di cosa sto parlando.
Il momento apicale dei centri sociali è la manifestazione del 10 settembre 1994, e il simbolo di quel periodo è il Leoncavallo di Milano. Forse solo un simbolo, perché dal punto di vista della produzione di discorso il Leoncavallo non è mai stato grande cosa. Semmai è più interessante evidenziare che parliamo di Milano: il più grande centro sociale di allora è collocato appunto in una città con una storia politica lunga, che lo ricollega direttamente a Fausto e Iaio (ricordati anche da Ignazio La Russa quando si è insediato al Senato, in un bel discorso in cui si è rivendicato tutto; chi dice che è stato strumentale non capirà mai cosa significa riconoscere il nemico e con esso un intero ambiente militante da cui proviene). Ma Milano è anche la città dei nuovi processi capitalistici, di quella controrivoluzione legata alla comunicazione e ai linguaggi su cui si regge la nuova industrializzazione. Milano, in sintesi, era la città di Berlusconi, e il Leoncavallo non poteva nascere altrove.
Dicevo, il Leoncavallo diventa il simbolo di questa fase in due grandi episodi. Il primo è l’agosto del 1989, in cui c’è un tentativo di sgombero e i compagni decidono di resistere sul tetto tirando mattonate in testa ai poliziotti. Le immagini vanno su tutti i giornali e improvvisamente esplodono i centri sociali. Da quel momento in poi, dire “sono un militante del centro sociale X” ha significato qualcosa di preciso e chiunque ti capiva. Era un linguaggio certo di una minoranza, ma una minoranza che comunicava con il contesto sociale.
L’altra grande vicenda è il 10 settembre 1994. Nei mesi precedenti viene sgomberato il Leoncavallo dalla seconda sede in Via Salomone, e così prima dell’estate si convoca una manifestazione per quella data, facendo capire a chi di dovere che quel giorno sarebbe successo il casino. Tutte le principali realtà si attivano, portando 15 mila persone da tutta Italia. Nel frattempo il centro sociale viene rioccupato in Via Watteau (dove è tuttora), ma il grosso avviene dopo. Durante la giornata del 10, infatti, una volta che si è arrivati in piazza Cavour di fronte al blocco della polizia dove il corteo sarebbe dovuto finire, il servizio d’ordine (per la prima volta dopo gli anni Settanta) carica il cordone dei poliziotti. Va detto, il cordone della polizia era francamente disorganizzato, gestito da un prefetto appena nominato e capace di errori imbecilli. Per dare un’idea, questi avevano lasciato aperto un pezzo di piazza Cavour in cui c’era una montagna di sanpietrini per dei lavori in corso. E quei sanpietrini furono prontamente recuperati a nuovo uso. Parte un macello, con i poliziotti che scappano, i compagni che tornano con gli scudi e i distintivi rubati, scene proprio imbarazzanti… Per quanto riguarda l’occupazione, ci fu una sorta di trattativa con i Cabassi (i proprietari degli spazi) che concluderà con un accordo e una concessione, tant’è vero che a distanza di trent’anni è ancora lì.
Però mi ricordo che un paio di anni dopo, credo nel 1996, apre a Milano un locale, il Tunnel, in cui si inizia a fare la stessa musica che veniva fatta al Leoncavallo. E poco alla volta gli stessi gruppi e le Posse che suonavano nei centri sociali iniziano a suonare nei locali commerciali, fino ad arrivare a Sanremo. E così il Leoncavallo si svuota: dopotutto, se la tessera del locale mi costa diecimila lire e un singolo concerto al Leoncavallo me ne costa settemila, vado al Tunnel e ci risparmio perché posso vederne quanti me ne pare.
Con questo cosa intendo dire? Che ho l’impressione che i centri sociali si siano alimentati agendo soprattutto, in quel momento lì, di non ancora completa sussunzione di alcuni fenomeni culturali. Per quanto stretto, questo margine di spazio ha permesso l’attivazione di una fetta di popolazione che altrimenti il mondo militante, forse, non sarebbe riuscito a cogliere.
In estrema sintesi, a una minoranza giovanile (ma una minoranza, ripeto, corposa) che esprimeva dei bisogni di socialità e di espressione che non trovavano riscontri, si è combinata per alcuni anni una soggettività militante che o veniva direttamente dagli anni Settanta (pochi) o si era formata nella controrivoluzione capitalistica degli anni Ottanta (ma, come vedremo, facendo sempre riferimento a quello che era successo prima). Ecco, è stata questa combinazione tra soggettività politica e soggettività sociale a condurre a quella nuova forma organizzativa, il cui ciclo di vita effettivo, secondo me, si colloca tra il 1989-1990 e la metà degli anni Novanta. Cerchiamo quindi di approfondire un poco.
Questa soggettività formata alla fine degli anni Ottanta, cioè la mia generazione, che tipo di soggettività politica descrive? Io credo che sia una soggettività politica che cresce e si forma con un complesso: il complesso di chi è arrivato troppo tardi.
Immaginatevi di essere invitati a una festa. Sbagliate orario, arrivate quando è finita. Da una parte, ritrovate davanti chi è arrivato in punto e vi racconta che è stata una festa della madonna, ci si è divertiti un sacco e voi state lì a rosicare; e dall’altra chi vi dice: “Visto che ormai sei qua, pulisci”. Non ti sei divertito e ti tocca a te tirare su la monnezza. Ecco, la soggettività che si è formata in quel frangente viveva una condizione molto simile.
Ovviamente estremizzo. Tenete poi conto che in questa panoramica generica che sto facendo si potrebbe entrare nel merito specifico delle divisioni tra gruppi, chi ha fatto una cosa e chi un’altra; ma resta vero che le differenze nella geografia politica degli anni Ottanta e Novanta (e successiva) è perlopiù ricalcata sugli anni Settanta. Persino gli scazzi e le tensioni sono ereditati da (e riferiti a) quello che era avvenuto nei dieci anni precedenti. Ecco, di tutto questo non mi interessa parlare qui, perché penso piuttosto che sia più utile analizzare il quadro generale. A partire dal fatto che questa soggettività di cui parlo è una soggettività con il torcicollo, che guarda più alle sue spalle che non davanti a sé.
Proprio per questo complesso del ritardatario, ci si sforzava di imitare e di riprodurre negli immaginari e nelle identità quello che era già successo. Con dei risultati, ammettiamolo, non esaltanti: perché il vero fenomeno che si produceva era l’altra metà della composizione. Voglio dire, in riferimento ai centri sociali la vera novità non stava nella sopravvivenza e nella tenuta del quadro militante (in cui mi ci metto), ma l’altro ingrediente, la composizione giovanile. Una composizione appunto molto ambigua, perché non appena ha la possibilità di andare al Tunnel e a Sanremo, va al Tunnel e a Sanremo; ma le composizioni sono ambigue per natura. Non sono già indirizzate, possono andare in tutte le direzioni.
Il principale errore, quindi, del corpo militante mi pare sia quello di aver perlopiù (e ci sarà chi l’ha fatto di più e chi l’ha fatto di meno, ma non mi interessa) cercato di appiccicare a questa composizione delle parole d’ordine, delle pratiche e degli immaginari che non le appartenevano. Alla fin dei conti, gli anni Novanta sono questo. È una storia in cui le simbologie non appartengono più ai vissuti, con degli effetti talvolta grotteschi. Si ereditavano degli scazzi di cui non sapevi spiegare concretamente il perché: per capirci, tutta la vicenda della dissociazione ha segnato questa generazione in profondità, ma appunto ha segnato chi personalmente non c’era. Il ragionamento era tutto fideistico. Poco alla volta, questo processo ha portato a un’afasia verso il presente e alle trasformazioni della composizione di allora.
Non a caso, quando tra la fine del ’99 e Genova viene fuori il movimento No Global, i centri sociali (ormai intesi come mera rappresentanza militante) non sono in grado di accorgersi che la fase è già cambiata. Il movimento No Global segna già una situazione differente sul piano delle soggettività che emergono; e ancor più sarà così durante l’Onda, tra il 2008 e il 2010. Durante l’Onda infatti si attivano delle realtà organizzate (come la rete Uniriot) che riescono a dare un indirizzo di pratica nelle varie città in cui sono presenti; al contempo però rimangono, rispetto a quella composizione, ampie dosi di incomprensione.
Per esempio, in quel frangente emerge una composizione che inizia a parlare i lessici della meritocrazia. Parole per noi orribili e che avremmo saputo spiegare perché sono tali; il problema è che non abbiamo saputo dimostrare la capacità di cogliere l’ambivalenza di quei lessici. Detta brutalmente, perché quella gente che parla in termini di meritocrazia poi è disponibile a scontrarsi nelle piazze con la polizia? Perché comunque quelle persone cercano un riconoscimento, ma non sono per l’ordine costituito, e così si aprono delle contraddizioni potenzialmente fertili. Dico appunto, “potenzialmente”: per esempio, credo che la composizione dell’Onda sia, concretamente o quantomeno in termini di discorso, la composizione da cui negli anni successivi nascerà il Movimento 5 Stelle, con tutte le sue ambivalenze insite in quello strato di lavoro cognitivo che non vedeva un rispecchiamento tra il titolo di studio e la posizione occupata nel mercato del lavoro. Durante il movimento dell’Onda quella contraddizione lì ha avuto una piega conflittuale; negli anni successivi, in assenza di quella piega conflittuale, si è fatta largo la richiesta alla magistratura di risolvere la contraddizione (magari ridotta a una faccenda di corruzione da eliminare), e da lì alla delega.
Ora, per non farla lunga e per aprire alla discussione, in che fase siamo? Siamo nella fase detta prima dai compagni di Modena, cioè in una fase in cui dire “il centrosocialismo è finito” è ancora poco. Il centrosocialismo, ripeto, finisce alla fine degli anni Novanta come fenomeno di un certo tipo e prosegue come autoriproduzione di un ceto militante. Ci mancherebbe, non sto dicendo che chi ha un centro sociale sia una carogna, o che so: i soldi per fare politica servono, e li si può trovare anche così. Non è quello il problema.
Il nocciolo è la fine del centro sociale come possibile spazio di aggregazione e di socialità tesa a produrre una soggettività politica nuova, funzione che permane in quella manciata di anni di cui abbiamo parlato prima, e poi termina. Dopodiché rimangono dei locali (marginali, ghettizzati, eccetera) o degli spazi in cui si fanno un po’ di soldi vendendo birre, ma da cui non passa più un’aggregazione di socialità potenzialmente antagonista (o anche solo alternativa). Questo è quello che avviene, secondo me, negli anni successivi.
Inoltre, ho l’impressione che questo non valga solo dal punto di vista politico, ma anche per l’aggregazione sociale tout court, come le scene musicali e le forme di espressione artistiche. Dopo le Posse, c’è qualche altro fenomeno che sia stato effettivamente espressione di una soggettività sociale e non già immediatamente mercificato, che non nasca già da subito in una logica commerciale? Temo di no, e credo che quello sia stato l’ultimo fenomeno controculturale, se vogliamo metterla in questi termini. Ma lo chiedo a voi, che le controculture le frequentate da vicino.
Penso, per esempio, alle curve. Mi pare che sia è avvenuta una trasformazione profonda, ma anche in questo caso non credo che possa essere addebitato soltanto alla repressione. È cambiato il ruolo che quelle forme di produzione simbolica e identitaria ricoprono. Quando l’anno scorso si vedevano gli ultras del Milan fare da servizio d’ordine della società, vediamo che ormai quel fenomeno (pur sempre ambiguo e contradditorio) aveva già cambiato funzione. Oppure pensiamo alla vicenda dello Juventus Stadium, di cui invece sono io il frequentatore: è mutato qualcosa a livello profondo, che non dipende solo dalle diffide (che restano cose durissime e preoccupanti, sia chiaro). Nel momento in cui la Juve decide di fare uno stadio all’avanguardia, sul modello americanizzante (che è una tendenza reale, che non riguarda solo alcune società e non altre, e che anzi detterà una linea che verrà seguita), eh be’, allora gli ultras non sono più utili. Anzi, diventano una rottura di palle. Per cui invece del Milan che fa un accordo per assoldarli come buttafuori, nel 2018 la Juve decide di disfarsene e li fa processare per associazione a delinquere, sciogliendo dall’alto la tifoseria organizzata. Questo perché, agli occhi degli industriali dello sport, non sono più utili dentro il modello imprenditoriale ed economico della società. E come hanno reagito gli ultras? Dicendo “ora facciamo lo sciopero del tifo”, appiattendola a una battaglia privata tra un gruppo e la società, cioè tra un’impresa e un gruppo che non è più in relazione con quella composizione sociale che va oggi in curva e che piuttosto preferisce la “macchinizzazion”e dei cori dettati su un cartellone luminoso.
Ora, a proposito di tutti questi contesti che ho nominato, ci tengo a sottolineare una cosa: non possiamo comportarci come dei 5 Stelle qualsiasi, che leggono questi fenomeni solo come una faccenda di corruzione individuale. Non perché di corrotti e venduti non ce ne siano (eccome), ma perché sarebbe riduttivo pensare che derivino da colpe individuali i processi che abbiamo analizzato. Ci allontaneremmo da una comprensione dei nostri limiti, ma anche delle nostre ricchezze: perché ripercorrendo queste nostre esperienze non troviamo solo delle tremende sconfitte e motivi per fustigarci – quanto piuttosto tante intuizioni di cui far tesoro e ripensare nel presente da un lato, e dall’altro cose semplicemente da superare. E per coglierlo, dobbiamo capire che ciò di cui dobbiamo parlare è tutta la nostra storia.
La capacità di costruire una tradizione antagonista viene solo dall’intelligenza di assumere l’intero bagaglio di esperienze. È troppo comodo fare come quelli che fanno gli snob, che dicono, che ne so, “mi piace la Comune di Parigi”, “mi piace l’Ottobre del ’17 ma solo nella notte della presa del Palazzo d’Inverno” e gli piacciono altre robe sparse che selezionano secondo un indice di purezza. No, la capacità di costruire e raccontare una propria storia, una storia concreta, di parte e ricca di insegnamenti, viene soltanto dal coraggio di assumerla tutta in blocco. Per fare tesoro del passato bisogna rivendicare la grandezza e analizzare la tragedia come la nostra tragedia. Separare i buoni dai cattivi non solo è troppo comodo, ma è inutile: un’intensa storia di classe diventa una barzelletta alla Walt Disney.
Per questo, nonostante di venduti ce ne furono, ce ne sono e ce ne saranno, non mi interessa stare lì a indicarli, perché non sono certo loro ad aver creato la situazione in cui ci troviamo. Lo ripeto perché alcune analisi mi sembrano andare a volte in quella direzione. C’è chi condivide le vostre e le nostre premesse, riconoscendo che i centri sociali sono finiti, ma poi aggiunge che il problema sono solo alcune personalità specifiche e che, se nascesse “l’autentico centro sociale” allora le cose cambierebbero. Ma quando mai! Sono come quelli che parlano del “socialismo reale”. Io non ho mai capito il termine “reale” di fianco a “socialismo”. Boh, è forse esistito un socialismo “irreale”? Il socialismo è quella cosa lì, ha una storia precisa e se uno continua a definirsi in una certa maniera, continua a restare dentro a quella storia, non ce n’è un’altra. O rompi (come Lenin nel 1917, che riconosce di non potersi più definire socialista e allora basta, inaugura una storia nuova), o fai i conti con tutto quello che è stato.
Lo stesso vale per le esperienze più vicine a noi: se continuiamo sulla linea del centrosocialismo non credo che riusciremmo mai, da una presunta nostra immacolatezza, a raggiungere un’autenticità che sfugge alla possibilità della corruzione altrui. Quindi assumiamo e facciamo nostri gli errori passati per comprenderli a fondo, ma mai avere paura delle discontinuità.
E infatti, se guardo retrospettivamente alla mia formazione e a quella della mia generazione, devo dire che il nostro principale limite è stato quello di temere la discontinuità come il peccato. È comodo dirlo adesso, ma il punto non è, lo ripeto, distribuire le colpe: il punto è comprendere cosa possiamo imparare. Agire la discontinuità, assumendo tutta una storia collettiva, diventa un meccanismo attivo e non passivo; se, invece, è la discontinuità che agisce te, ti ritrovi spiazzato, immobile. Ciò vale anche per la fine dei cicli: va sempre anticipata, non bisogna mai arrivare al punto in cui è la fase a sopravanzarti. Bisogna sapere cambiare quando non si è già iniziato a scendere, perché altrimenti è troppo tardi. Figuriamoci cambiare quando si è perso in modo conclamato.
Agire la discontinuità significa questo, comprendere la tendenza e deviarla cambiando le proprie tattiche, senza temere che questo significhi perdere un’identità. Perché (o almeno spero) la nostra identità non dipende da dei simboli eterni.
I simboli, gli immaginari, le parole, le canzoni, le pratiche, lo stile degli abiti vengono inventati e reinventati da ogni generazione. Sarebbe ridicolo riprodurre della roba vecchia e stravecchia. Voglio dire, se oggi scendessimo in piazza vestiti da Guardie rosse saremmo indecenti, saremmo… [qualcuno nel pubblico: “saremmo trotskisti”] Esatto! [risate] E questo però, lo capite bene, non significa “rinnego le Guardie rosse”, ma semplicemente riconoscere che sono cambiate le condizioni per cui quelle cose trovavano una loro comunicabilità rispetto alla potenziale composizione di riferimento. Certo, anche io mi diverto a sparare sul vecchio che fatica a morire, ma dopo un po’ tendo ad annoiarmi. Perché sì, ha sempre ragione il presidente Mao quando diceva di bastonare il cane che affoga, però a questo punto possiamo anche passare oltre. Dunque, una volta che quel vecchio lo diamo per morto, stiamo attenti a non infierire e a non continuare a pizzicarlo. Evitiamo, per rimanere nella metafora, di diventare necrofili. Dopotutto, che senso politico avrebbe? In una serata davanti a una bottiglia di vino uno ride e scherza, va sempre bene, ci mancherebbe; ma non deve distrarci dal capire quale possa essere il nuovo che può nascere.
A ben vedere infatti, questa fase è importante e delicata. Tra l’essere militanti negli anni Settanta e esserlo oggi, ma non c’è paragone: è molto più importante esserlo oggi. Per certi versi, essere militanti negli anni Settanta era l’equivalente, che so, di cantare la trap oggi. Nel senso che quando tutti fanno una cosa, se ti vuoi sentire cool la fai anche tu, e allora scendi a manifestare (estremizzo, ovviamente). Il punto è capire cosa significhi fare politica quando si è assoluta minoranza, perché è allora che diventa tanto difficile quanto importante. Altrimenti si rischia o il torcicollo, come dicevo prima, o di proiettare le proprie voglie di liberazione e di rivoluzione, di lotta e di conflitto su posti lontani e sperduti: che so, il Rojava.
Ve lo devo dire proprio in tutta onestà. Tifare per il Rojava è come andare su YouPorn: uno sublima una dimensione di impotenza guardando quello che non riesce a fare. Ripeto, massimo rispetto per chi va a combattere per il Rojava… ma non sarebbe meglio combattere dove sei? Lungi da me voler mancare di rispetto a chi si arruola, anche perché c’è gente che muore; parlo piuttosto delle fascinazioni di chi sta a casa e sta fermo. Mi sembra un modo per non vedere quanto sia difficile far casino qui, sul posto di lavoro, per venire licenziati il giorno dopo. Era molto più semplice tirare una sassata a Milano nel 1977, che provare di costruire dei processi di organizzazione qui e ora.
Ma non disperiamoci nemmeno. Sapete no, all’inizio degli anni Novanta un neocon americano, Francis Fukuyama, pubblicò un libro, La fine della Storia, che ebbe un grosso successo editoriale fino a rimare come l’emblema di quegli anni. Cosa diceva Fukuyama? Che una volta crollati il muro di Berlino e l’Unione Sovietica, vince il capitalismo; soprattutto diceva che questa non è una vittoria reversibile, ma definitiva, con cui finisce la Storia. Con la vittoria del capitale, nessuno poteva più pensare che la Storia fosse mutabile. Ci può essere innovazione, ma non più rivoluzione.
Ecco, se noi continuassimo ad andare alla ricerca di movimenti in giro per la galassia, convinti che da noi tutto è diventato impossibile, non diremmo cose poi troppo diverse in sostanza. Perché mettiamoci il cuore in pace, i momenti di lotta sono sempre l’eccezione, sono sempre uno stato d’eccezione. La normalità è fatta di momenti come questo. Se guardiamo alla storia, partendo dagli albori del movimento operaio nell’Ottocento a oggi, vediamo subito che fasi come la Comune, l’Ottobre, i consigli, il Settantasette, sono delle eccezioni, e per giunta di breve durata, in un panorama simile al nostro. In cui il vecchio fatica a morire e il nuovo fatica a nascere.
A proposito, non so se avete visto il film Il giovane Karl Marx. È un po’ didascalico, ma non è pessimo. Ebbene, c’è una scena in cui Marx attacca ferocemente Weitling, un utopista che si appellava a un vecchio tipo di operaio ormai tramontato, vicino ancora all’artigiano ottocentesco, con discorsi mistici e appassionati che chiamavano centinaia e centinaia di persone ad applaudirlo. Insomma, una figura di importanza di primissimo piano. Ecco, a un certo punto Marx lo attacca come una furia. E allora la moglie, Engels e lo stesso Weitling rimangono a bocca aperta. Cosa gli saltava in mente a un signor nessuno di andare ad assalire uno che si trovava attorniato e adorato da uno stuolo di operai?
Marx lo attacca perché capisce che ci sono dei momenti in cui bisogna individuare delle tendenze e organizzarsi inserendosi su di esse, e non sforzarsi di rimettere insieme i cocci di una storia finita. Perché mettere insieme una marginalità qui e una marginalità là, ottieni solo una marginalità più grossa, ma poco altro. Noi dobbiamo dimostrare la capacità di uscire dal culto del marginale, dal “marginalesimo”. Puntiamo al cuore, al centro, perché solo da lì si innescano processi profondamente sovversivi.
E quindi, in queste fasi oscure, da dove ripartono i comunisti? In primo luogo, dalla produzione di discorso e di un nuovo orizzonte teorico-strategico. Niente teoria per la teoria e accademia per l’accademia. Questo lo diamo per scontato: una teoria per la pratica, che in essa si verifica. E in secondo luogo, si riparte dalla costruzione di luoghi di aggregazione di una soggettività potenzialmente antagonista. Come ce li re-immaginiamo, oggi, luoghi di aggregazione non per una soggettività già politicizzata, ma per una soggettività la cui politicità è implicita? La politicità va cercata dove ancora non si vede e non si esprime, perché se ci fermiamo a quelli che sono già politicizzati, troviamo sempre e solo dei cadaveri.
Dopotutto, la storia del movimento operaio altro non è che un continuo interrogarsi su queste domande, inventando volta per volta una risposta diversa, attendendola là dove nessun altro la ipotizzava.
[Continua…]