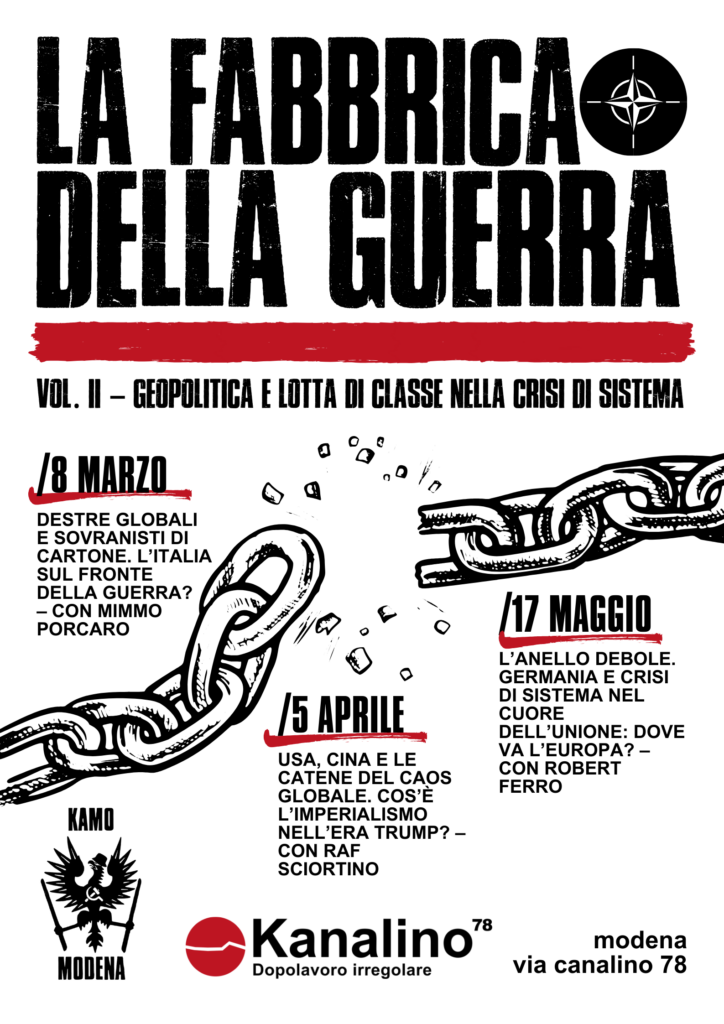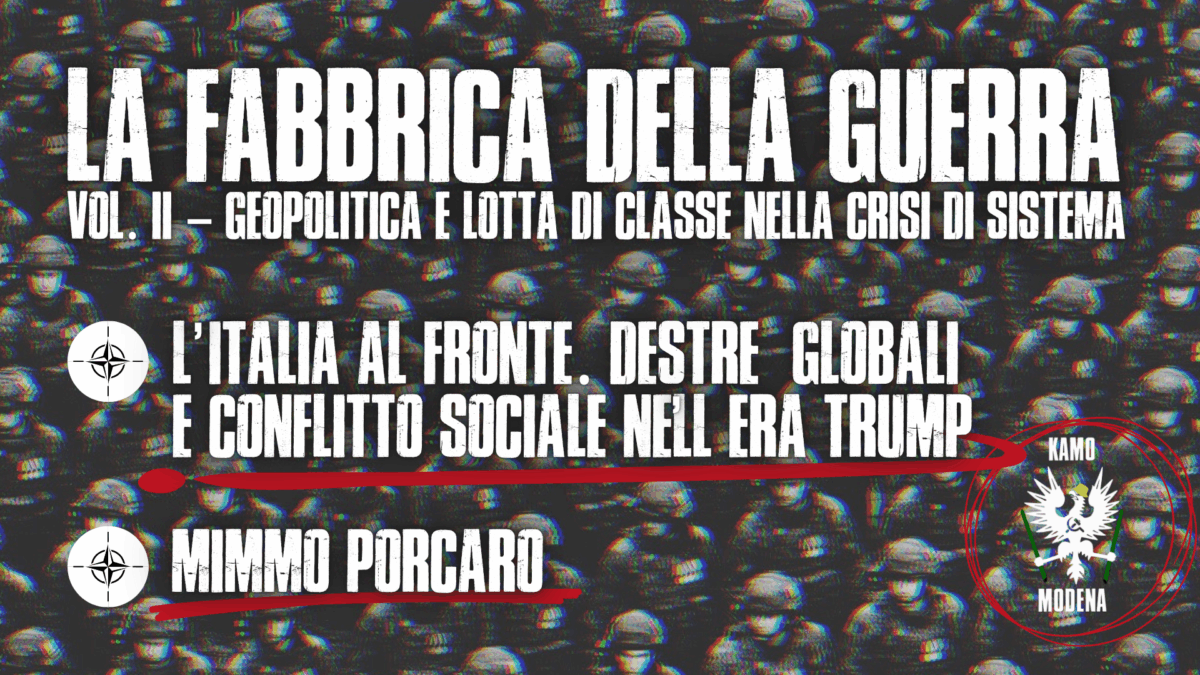Introduzione
«La fabbrica della guerra» è un ciclo di incontri organizzato a Modena, ospitato dal Dopolavoro Kanalino78, con l’obiettivo di cercare chiavi per comprendere e afferrare la complessità della fase storica in cui siamo immersi, nella quale eventi sempre più accelerati fanno sfuggire la leggibilità del presente. Come coordinata interpretativa abbiamo voluto usare la guerra perché pensiamo sia il grande fatto sociale centrale, la determinante che sta riorganizzando tutto il nostro mondo e le altre dimensioni di questo momento storico, la realtà in cui siamo collocati.
La tendenza alla guerra delle società capitalistiche è diventato un fatto innegabile, lo vediamo sempre più concretamente; ed è una dinamica che arriva a toccarci sempre più direttamente; in altri termini, un fenomeno che sta trasformando non solo il sistema internazionale in cui abbiamo vissuto finora, ma anche la nostra vita quotidiana. Attraversati da questa dinamica, cambiano in profondità i nostri territori, le nostre città, i nostri quartieri, e insieme a loro stili di vita, bisogni, aspettative, punti di vista, comportamenti sociali.
Per i militanti è diventato dunque imprescindibile comprendere queste trasformazioni per agirle, e potenzialmente per ribaltarle. Come recita un vecchio slogan: «Chi pensa deve agire». Noi crediamo che per agire bene bisogna prima pensare bene, ed è questo l’obiettivo del ciclo di incontri.
Il primo tempo di questo ciclo di incontri è stato intitolato «Modena nel conflitto globale».
Quando abbiamo iniziato a riflettere sulla guerra, infatti, non siamo partiti da grandi teorizzazioni, da grandi discorsi di geopolitica. Abbiamo voluto partire dalla visuale del nostro orizzonte, da quello che ci tocca direttamente, quotidianamente. E quindi siamo partiti dal nostro territorio, ossia dall’ambiente geografico e sociale in cui ci muoviamo. L’unico su cui possiamo cominciare ad agire direttamente con i mezzi che abbiamo. Ammettiamolo: non possiamo andare a fermare la guerra in Ucraina e non possiamo fermarla a Gaza, ma invece possiamo agire – dobbiamo agire – qui, dove siamo collocati, sul nostro territorio.
Siamo partiti a inchiestare la «fabbrica della guerra» a cominciare dall’industria della formazione («Guerra e industria della formazione. Il conflitto dentro scuola e università»), cioè scuola e università, che è parte integrante della catena di montaggio del conflitto. Abbiamo voluto interrogare quei soggetti, studenti delle superiori e universitari, che nei mesi e negli anni scorsi hanno incominciato a mobilitarsi contro la guerra, in particolar modo contro il genocidio a Gaza da parte di Israele. Abbiamo voluto fare una discussione con loro per capire cosa si muovesse a scuola e in università, anche attraverso il metodo della conricerca, presentato dal collettivo Officine della Formazione, attivo nell’università di Bologna, di cui abbiamo presentato un’inchiesta sulla soggettività studentesca. Pensiamo che l’industria della formazione sia baricentrale nella riproduzione capitalistica, andando a formare quelle capacità umane, quei saperi, quelle conoscenze e soprattutto quei soggetti che verranno messi a valore dal sistema capitalistico, e che noi invece dobbiamo provare a “controutilizzare”, “controformare” per andare a combattere la struttura sociale che produce la guerra.
Il secondo incontro è stato invece sulla fabbrica emiliana («La guerra sul territorio. Industria modenese, produzione bellica e operai: come si trasforma la fabbrica emiliana nella crisi globale?», di prossima pubblicazione), l’industria in senso stretto, osservando quelle caratteristiche che contraddistinguono il nostro territorio. Parliamo infatti di un territorio a vocazione industriale, soprattutto meccanica. Nel corso dei decenni si è consolidato un tessuto di fabbriche, soprattutto di media o piccola dimensione, molto particolare, organizzato in distretti, che dagli anni Ottanta in poi è riuscito a internazionalizzarsi ed essere volano dello sviluppo e dell’accumulazione capitalistica italiana. Ci troviamo su uno dei vertici di quel triangolo Lombardia-Emilia-Veneto a propensione per l’export, in cui si producono i macchinari e la componentistica che alimentano le catene di subfornitura a livello internazionale e globale; una parte di territorio nazionale che, ancorandosi soprattutto all’economia tedesca, è riuscito a integrarsi profondamente nelle catene del valore della globalizzazione.
Il punto prospettico su cui è stata focalizzata la nostra inchiesta sul tessuto industriale modenese è stato appunto il rapporto tra la crisi dell’automotive tedesco e la tendenza alla guerra. La nostra ipotesi era che la crisi delle grandi case automobilistiche tedesche, determinata dalla distruzione dei fattori cruciali dello sviluppo tedesco – ossia l’energia a basso costo dalla Russia e la penetrazione nel mercato interno cinese –, e la compromissione radicale dell’economia tedesca in senso lato, avrebbe provocato un effetto a catena che si riflette su quel reticolato di subforniture che coinvolge la provincia di Modena – la Motor Valley appunto. La tesi che abbiamo sviluppato è che questa crisi può essere l’occasione, il volano, per una ristrutturazione delle competenze e degli impianti impiegati nel settore automobilistico in funzione bellica. In sintesi, venute meno le commesse tedesche, queste piccole e medie fabbriche modenesi, inserite strettamente nelle catene globali del valore, si riconvertono per fornire componentistica alle industrie belliche (come, per esempio, Leonardo).
Abbiamo presentato questa inchiesta insieme a Giovanni Iozzoli, che invece ha discusso dell’aspetto interno alle fabbriche, con una ricognizione sugli operai e le rappresentanze sindacali. La nostra ipotesi ce l’ha confermata la stessa Meloni qualche qualche tempo dopo, quando è uscito un articolo sul «Corriere della Sera», ripreso poi da tutti gli altri quotidiani, dove si parlava di questo “piano segreto” di riconversione dell’automotive italiana in industria bellica.
Quindi, attraverso un metodo che abbiamo condiviso nel corso degli anni, siamo riusciti ad anticipare e a vedere sul nostro territorio questi processi in atto, che andranno a trasformare il territorio e soprattutto la condizione di chi ci vive, così come i possibili comportamenti dei soggetti sociali che si muovono in esso. Lo ripetiamo, non intendiamo indagare questa situazione per mera conoscenza sociologica, ma per indirizzare politicamente un’azione che sia pregna di contenuto e che sappia anticipare le situazioni che potranno crearsi a fronte dell’accelerazione degli eventi e soprattutto dell’approfondimento dello scenario di guerra che ci coinvolge sempre di più.
Questi i motivi per cui parliamo di «fabbrica della guerra»: è qua che si produce la guerra, sostanzialmente, nei suoi elementi materiali. Le industrie che prima producevano componentistica per auto oggi lavorano su alettoni per missili, cingoli per carri armati; l’università produce software e sviluppatori di software per l’intelligenza artificiale usata anche a scopo bellico, come i sistemi di identificazione e di puntamento, e via di questo passo. La nostra provincia si dimostra una punta avanzata di questo sviluppo tecnologico, improntato sul passaggio dal welfare al warfare.
Per non cadere vittime del localismo, attraverso il secondo tempo del ciclo («Geopolitica e lotta di classe nella crisi di sistema») abbiamo provato ad alzare lo sguardo dal nostro orizzonte quotidiano e raggiungere una contestualizzazione di più ampio respiro. Tenendo sempre ancorato lo sguardo sulle trasformazioni nella composizione di classe, abbiamo allargato via via il punto focale per vedere dove questi processi si iscrivono a livello internazionale e globale, e quale la loro dimensione politica.
Abbiamo iniziato a indagare, con Mimmo Porcaro, su quale linea del fronte si colloca l’Italia, tra ascesa di rinnovate destre globali, da Trump a Meloni, e possibile, inedita riemersione di una “questione nazionale” che, a bene vedere, non potrà essere esaurita dentro le destre, ma intercetterà i movimenti a venire della composizione di classe; con Raffaele Sciortino, abbiamo cercato di definire la strutturazione che l’imperialismo ha assunto, tra continuità e discontinuità, dal Novecento alla crisi del 2008, e di capire cos’è oggi alla luce della configurazione concreta del mercato globale e dello scontro Stati Uniti e Cina; infine, con Robert Ferro, abbiamo ragionato sulla traiettoria dell’Europa a fronte della crisi tedesca, al cuore del progetto europeo, e della chiarificazione del rapporto tra Unione Europea e Stati Uniti.
Tutte questioni che, a nostro parere, si intrecciano. Per questo, partendo da singoli anelli, ricostruire la catena dei fenomeni significa provare a comprenderla e possederla – anche per non farci “incatenare” a terra dal caos montante.
Nel primo incontro con Mimmo abbiamo discusso della posizione dell’Italia nella crisi globale. Dove stiamo andando? Che ruolo ha l’Italia in questo caos politico? Cosa rappresenta il successo delle destre in ascesa un po’ in tutto il mondo, da Trump alla Meloni fino all’Est Europa? È il ritorno del fascismo, come ci dicono le centrali democratiche progressiste, oppure qualcos’altro? Che differenze ci sono tra di loro e tra gli interessi che rappresentano? E poi, in che modo questo accartocciamento delle relazioni internazionali, questo stato di guerra sempre più approfondito può creare le condizioni, le opportunità dello sviluppo di un nuovo ciclo di lotte di classe, o quantomeno di una ripresa delle lotte di classe? E nel caso, che forme e istanze avranno queste lotte?
Dopotutto, le lotte ripartono da dove avevano trovato una sconfitta, ma sempre portando in strada nuovi istanze e nuovi soggetti. Se ci permettete un’immagine, diremmo che assistiamo in un qualche modo a un ritorno dell’antico: la marea della globalizzazione si ritira e lascia sul terreno questioni che aveva sommerso o che aveva voluto sommergere. Questioni tipiche della Modernità come la nazione, la sovranità politica, la realpolitik, l’equilibrio di potenza, le sfere di influenza… e con queste anche la lotta di classe. Tutto ciò ci porta a domandarci se siamo di fronte, o potremmo essere di fronte, a una ripoliticizzazione del sociale, o piuttosto a una ripolarizzazione dello spettro politico, e quale ruolo, dentro ai processi a venire, potranno e dovranno avere i militanti che del processo vogliono organizzare la rottura rivoluzionaria.
Buona lettura.

Mimmo Porcaro
Quando ho letto il titolo della locandina che mi ha mandato generosamente il compagno, gli ho detto “guarda, porto un amico”, perché rispondere a tutte queste domande qua è diventato un po’ difficile. Teniamo conto infatti che sono questioni complesse per chiunque. Si discuteva prima che ho scritto un articolo contro «Limes» e di loro alcune posizioni importanti; ebbene, pensate che adesso i rumors danno Caracciolo in grossa difficoltà dentro la rivista perché pare che il gruppo editoriale Gedi non accetti molto la sua valutazione sul carattere tra virgolette “razionale” del trumpismo. In effetti, ha dei caratteri di razionalità politica elementare che i democratici americani avevano completamente perduto. Sono chiacchiere, rumors, però sicuramente dietro c’è un problema reale, perché quando qualcuno si mette a fare un’analisi obiettiva (si può dire quello che si vuole di «Limes», ma mi sembra che abbia sempre portato dei contributi seri), comincia a diventare fastidioso anche se è uno dei piani alti, molto alti, come suggerisce il cognome stesso.
Per fare un altro esempio della complessità della questione, io avevo scritto un articolo per «La Fionda» e che avevo mandato ai compagni per dare un’idea di quello che avrei voluto dire. Be’, l’ho riscritto. Già solo qualche giorno dopo ho dovuto riscrivere dei pezzi perché non mi convinceva come avevo reso il rapporto tra Trump e il capitalismo finanziario, o tra Trump e il capitalismo industriale… Insomma, siamo dentro situazioni che cambiano continuamente. La nostra capacità analitica già non era eccelsa prima, perché le grandi strutture di analisi legate ai partiti di un tempo sono scomparse, e andiamo avanti tutti in maniera artigianale; ma dobbiamo comunque avere il coraggio di fare delle ipotesi, sapendo che dopodomani potrebbero essere smentite. La situazione è difficile anche per le grandi potenze internazionali, salvo tre o quattro superpotenze che controllano molte variabili e quindi possono decidere con un livello di rischio di errore diciamo basso, basso ma non zero. Salvo loro, anche le cancellerie delle medie potenze europee e internazionali non sanno che pesci prendere, anche perché non sanno che tipo di eventi verranno prodotti dai rapporti difficilissimi, nonostante l’apparenza, tra le tre superpotenze. Oggi quindi siamo qui per tentare di capire, sapendo con umiltà che potremmo sbagliare moltissimo.
Io in realtà, prima di rispondere direttamente alle domande sull’Italia e sulla lotta di classe, devo per forza dire due cose sull’imperialismo e sull’Europa, rubando quindi un po’ del tempo che poi useranno Sciortino e Ferro – con i quali, tra l’altro, da un anno e mezzo a Torino stiamo costruendo assieme ad altri compagni un seminario proprio sull’imperialismo, che attraverso l’analisi dei rudimenti minimi, anche a partire da una rilettura di Marx, sta arrivando a individuare una serie di nodi. Vi dico quello che penso io: noi non abbiamo la pretesa di arrivare a una posizione unitaria, di fare il nuovo partito o queste cose qua. È una discussione molto franca tra compagni di provenienze molto diverse (andiamo dal centrosocialismo al sovranismo di sinistra), e però con grandi capacità di dialogo perché uniti dall’intento comune di cercare di capire qualcosa in funzione di una ripresa del conflitto sociale.
Allora, Trump.
Dunque, partiamo da una cosa abbastanza significativa, un’intervista che lui diede tempo addietro, non so se al «New York Times» o a quale altro giornale americano, in cui l’intervistatore gli disse: «Ma lei, signor Trump, è filo Putin. Ma lei lo sa che Putin è un killer? È un vero son of a bitch?» E risponde lui: «Bah, sì, un killer. Ma noi abbiamo trattato con una marea di killer. Ma cosa credete, che noi siamo innocenti?» Quando uno sente queste cose, pensa subito: “Toh, che simpatica canaglia. Visto che parliamo di un bieco imperialista eccetera eccetera, meglio uno così che dice la verità piuttosto che quegli altri che ammantano l’imperialismo con le guerre umanitarie, i valori e queste cose qua”. È vero sotto certi aspetti, non per il fatto che non dica la verità – io credo che menta nell’80% dei casi, mente come chi deve negoziare e ha una concezione transazionale della vita – però nella sostanza sicuramente mostra con maggiore durezza i rapporti di forza.
Ma non è vero che faccia la stessa cosa che facevano gli altri prima, con l’unica differenza che lui lo ammetta. Lui fa una cosa molto diversa rispetto a quanto abbiamo visto finora. È un’altra modalità, un’altra declinazione dell’imperialismo, ma è diversa da quella precedente e questa differenza conta. Quella precedente è quella che si ammantava dal termine “globalizzazione”, una macrostruttura capitalistica che pensava di riuscire a conquistare il mondo intero attraverso l’allargamento del sistema americano. Allargamento che, guarda caso, ogni tanto aveva bisogno di qualche colpo militare (e quindi Serbia, e quindi l’Iraq, e quindi Libia e così via), ma che però sostanzialmente si basava sull’apertura del libero mercato con il quale, secondo Clinton, si sarebbe riusciti a comprare la Russia e che, secondo tutto il pensiero neocon americano, avrebbe imposto una prospettiva liberale per la Cina facendo crollare il partito comunista. La cosa non ha funzionato.
È una modalità dell’imperialismo, e non va inteso come un mero slogan ma per capire a fondo cosa stiamo vedendo. Si tratta di una modalità dell’imperialismo perché in realtà anche la semplice transazione economica dal punto di vista capitalistico è già una costruzione di gerarchie ed è per questo che ha bisogno di essere continuamente accompagnata dalla forza armata. Non si dà espansione del libero mercato senza l’esistenza di uno o più eserciti che presidino le zone nevralgiche e che consentano di indebolire tutti gli Stati che possano avere quel minimo di forza tale da porre dei limiti al libero movimento del capitale. Se ci pensate, la colpa maggiore di tutti i famosi “dittatori” che sono stati estromessi dalla politica estera americana non era quella di essere dei dittatori (cosa della quale, agli Stati Uniti, non è mai fregato nulla), ma il fatto di avere costruito degli Stati sufficientemente forti da poter dare fastidio. Questo era, diciamo, il primo tempo di quella che era la globalizzazione, una fase storica che troppi della sinistra, soprattutto della sinistra paracomunista, hanno preso come “la fine degli Stati”, lo sviluppo di un “mondo piatto”, senza conflitti statuali (“Finalmente!”, diceva qualcuno, come nei famosi testi di Negri e compagnia briscola).
Era, si noti bene, una modalità dell’imperialismo che ha prodotto degli squilibri tali da non essere più sostenibile. Paradossalmente rispetto agli scopi iniziali, ha prodotto un indebolimento di quella potenza che si pensava come potenza unipolare – gli Stati Uniti – perché sia l’espansione economica che l’espansione militare si sono rilevate alla fine troppo pesanti. L’espansione economica, per come si è sviluppata realmente, ha prodotto uno scompenso fortissimo dei conti con l’estero degli Stati Uniti, sia nella bilancia commerciale che nella bilancia dei pagamenti (in altri termini, questi signori vivono a debito e il giorno che qualcuno richiedesse il pagamento dei debiti in teoria dovrebbero saltare, cosa che chiaramente non succederà nei nostri tempi); e in più la sola estensione militare, a fronte anche delle sconfitte che sono state patite nei progetti militari americani (prima l’Afghanistan, adesso l’Ucraina, e se anche ci fossero Biden o la Harris dovrebbero comunque trattare la pace) è diventata obiettivamente un peso eccessivo per gli Stati Uniti.
La risposta di Trump sotto questo punto di vista si riallaccia a tutta l’elaborazione del cosiddetto realismo politico americano. Per intenderci, quando Clinton, il venerato Clinton, aveva iniziato a dire che bisognava espandere la Nato all’estero verso Est, una cinquantina di osservatori formatisi in questa scuola di realismo politico (gente che aveva gestito la Guerra fredda, quindi non proprio delle colombelle) scrissero una lettera in cui grossomodo dicevano: “Signor Presidente, quello che lei sta commettendo è un gravissimo errore che avrà delle conseguenze incalcolabili”. E Trump non fa che riprendere questo filo di ragionamento dicendo, in sostanza: “Noi dobbiamo dominare, noi dobbiamo essere i primi, ma non possiamo far sì che il mondo sia tutto simile a noi; quindi dobbiamo imporre la nostra volontà all’interno di un rapporto di forze internazionale che, purtroppo, di fatto è multipolare”.
I due punti significativi e interrelati sono questi. Trump riconosce realisticamente che non può far diventare liberale la Cina (e neanche gli interessa), né può far diventare liberaldemocratico Putin. Deve tener conto dei rapporti di forza, ma non per tenerli come sono. Piuttosto, ne tiene conto e accetta il mondo multipolare non come un equilibrio già costruito, ma come un campo di battaglia in cui lui deve in qualche modo primeggiare. Trump rappresenta, diciamo così, una fase di parziale ritirata tattica. Dopo che si era espanso troppo, l’imperialismo americano ha bisogno di rientrare un attimo nei ranghi, di ritornare nel suo mondo (che non è solo costituito dagli Stati Uniti, ma da tutto il blocco occidentale), rafforzare le posizioni all’interno di quel blocco. Per poi? Puntini puntini. Questo lo vedremo perché, come dirò dopo, ci sono anche degli elementi oggettivi che comunque spingono verso una ripresa di una politica aggressiva. Che cosa succede quindi?
Mi riallaccio a un importante studio, poco noto in Italia, svolto da studiosi dell’Università di Amsterdam e raccolto in Trump and the Remaking of American Grand Strategy, che ha il merito di esporre con grande chiarezza e dovizia di elementi la differenza di fondo della situazione odierna. Il precedente corso, iniziato con Clinton e protrattosi fino a Obama, vedeva nell’espansione all’esterno degli Stati Uniti la condizione per la crescita interna e per il benessere interno. Trump, almeno a parole, fa l’operazione contraria: prima rafforzare la base produttiva e finanziaria statunitense, e solo dopo e in funzione di ciò pensare all’espansione all’esterno. È una differenza importante, ma non è una differenza tra la guerra e la pace. Perché?
Spesso si sente dire che Trump sostituisce la logica della guerra con la logica dell’economia, e che un attrito economico è pur sempre preferibile alla guerra aperta. Il problema è che da questo punto di vista la traiettoria di Trump rientra in un quadro che la polemologia ha già individuato da molto tempo, e che in America viene sintetizzata nella formula di Daniel Bell, uno dei più grandi sociologi americani, che sostiene che «l’economia è la continuazione della guerra con altri mezzi». Infatti, come ho detto prima, anche quando l’economia si svolge lungo una dinamica win-win, nascono comunque dei rapporti gerarchici; ma l’economia diventa un elemento bellico e potenzialmente creatore di conflitti bellici soprattutto quando è concepita espressamente come un gioco a somma zero, del tipo io vinco-tu perdi, in cui cioè scompare l’illusione dello scambio che fa contenti tutti. Lo scambio economico è un momento di scontri durissimi, e quindi, in modo o nell’altro, prelude sempre alla possibilità di scontri militari. Ma non finisce qui. C’è sempre da tenere presente che nessuna presidente degli Stati Uniti d’America può ignorare quello che hanno fatto i presidenti precedenti.
Se voi guardate bene c’è una serie di continuità impressionanti su alcuni elementi. Intanto, nel fregarsene dell’Europa tutti sono uguali (solo che lì veramente Trump lo dice a chiare lettere). Però, per esempio, il primo a parlare di dazi è stato Obama, poi è arrivato Trump, poi è arrivato Biden che ha fatto dazi ancora più duri di quanto non avesse fatto Trump, e così via. Perché? Perché da un lato, le scelte dei presidenti precedenti rispondevano comunque a problemi oggettivi, pesanti, reali; dall’altra, quando si muovono gli Stati Uniti non è che si muove il comune sperduto o il paesello, ma creano delle realtà oggettive e dei rapporti sociali che poi non è facile modificare. Si determina così un crescendo tale per cui nessun presidente può far finta che “quello di prima” non abbia fatto niente di buono, e deve in qualche modo proseguire da lì.
Nella fattispecie Trump si troverà di fronte a un nodo fondamentale, ossia la centralità della difesa del dollaro per far sì che gli Stati Uniti si indebitino nella moneta che stampano, rimanendo così a galla. Ma la centralità e la fiducia nel dollaro si può ottenere soprattutto attraverso la costante presenza militare e politica nelle zone centrali del mondo; quindi Trump non potrà – ammesso che lo voglia – tornare completamente indietro rispetto a questa situazione e dovrà farci in qualche modo i conti. Detto ciò, qual è l’ulteriore differenza tra Trump e le presidenze passate che ci interessa più da vicino?
La novità rispetto alle precedenti amministrazioni è l’aperta e decisa rottura con l’Europa e il fatto che quelle forme di scontro che prima venivano indirizzate nei confronti dei paesi fuori dal blocco occidentale, adesso si rivolgono al suo interno per rafforzare dentro l’Occidente la forza degli Stati Uniti d’America e per concentrare tutte le forze possibili e immaginabili ai fini della fase successiva dello scontro. È evidente a tutti che l’Europa sia sotto attacco e che questo sia un problema cruciale per le classi dirigenti. Però, se uno cercasse di guardare con un occhio più storico, si potrebbe chiedere: ma non stanno forse nascendo le condizioni per l’esaurimento degli esiti della Seconda guerra mondiale?
Infatti, per molti studiosi di storia e di geopolitica, la Seconda guerra mondiale non è stata soltanto la sconfitta del nazifascismo, ma soprattutto la sconfitta dell’Europa, perché è stata a) la sconfitta delle pretese coloniali dei grandi imperi, inglese e francese, cosa resa evidentissima nella crisi di Suez del 1956, e b) è stata anche il tentativo ben riuscito di isolare e di combattere quello che poteva essere (e in effetti era) l’avversario economico numero uno degli Stati Uniti in Europa, cioè la Germania. Vi faccio un esempio a mio parere emblematico: il termine “Guerra fredda” non nasce per indicare l’ostilità nei confronti dell’Urss, ma si presenta per la prima volta nel lessico politico americano in ambito giornalistico nel 1943-1944, quando l’esito della guerra in corso era comunque scontato, per indicare l’impellenza vitale di proseguire, anche dopo la pace, un assalto velato nei confronti della Germania, che le avrebbe impedito di avere un ruolo economico in futuro.
Detto ciò, rimangono alcune domande aperte. Infatti, considerando a) che gli americani si disinteressano dell’Europa, b) che dal 1989 lo scontro tra Unione Sovietica e Stati Uniti è finito e c) che oggi non v’è più neanche uno scontro diretto con Putin, perché non si riesce a prendere atto di questo distacco e iniziare una “risovranizzazione” dell’Europa, ossia un percorso che la faccia diventare un vero e proprio soggetto politico? Questo è un bel problema. Riuscire a capire perché gli europei si stiano comportando in questo modo, vale a dire perché continuino una guerra che apparentemente loro non hanno voluto, che hanno solo subito e che oggi gli attori principali vogliono interrompere, è indubbiamente un busillis.
Insomma, come dicono al mio paese d’origine, ccà nisciuno è fess, ma guardarle così certe cose sembrano veramente autolesionistiche. Sarà che abbiamo un ceto politico incapace di fare delle scelte di importanza storica perché è composto di gente cresciuta in un’epoca in cui sembrava che la politica fosse finita (dopo l’‘89 non c’è stato nessuno che avesse la statura dei vecchi leader europei); sarà che finora hanno sostenuto che la guerra in Ucraina è santa e giusta, che ci dovevamo svenare per farla, quindi non è che dall’oggi al domani possano dire «no basta, abbiamo scherzato, non si fa più». Ma questi elementi (pure innegabili) non sono sufficienti a spiegare una situazione che eccede le logiche di comune propaganda politica.
È qualcosa di molto più profondo, perché scegliere la strada del riarmo nei termini in cui l’ha presentata la Von der Leyen significa un cambiamento di paradigma economico, politico e sociale. Ma allora perché siamo a questo punto?
Alcuni elementi mi sento di anticiparli sin da ora. Ovviamente, se tu sai che il tuo alleato principale e protettore ha deciso di diminuire il tasso di protezione, è logico che tu ti ponga un problema di gestione del tuo apparato militare; il che però è diverso da quello che è stato proposto. Il piano presentato a Bruxelles probabilmente dipende da due fattori, tra loro convergenti.
Il primo è il fatto che il cosiddetto capitalismo europeo non è solo europeo, ma è un capitalismo ibrido, misto europeo-americano. Come aveva già brillantemente intuito un grande filosofo marxista negli anni Settanta, Nicos Poulantzas, la presenza dei fondi di investimento americani nel capitalismo europeo è a livelli altissimi. Gli investimenti diretti all’estero (Ide) da parte degli Stati Uniti d’America – Ide che, tra l’altro, secondo Lenin, sono il primo motore dell’imperialismo – negli ultimi decenni sono declinati in tutte le zone del mondo, ma sono invece decisamente aumentati per quanto riguarda il capitale europeo e in particolare per le aziende capitalistiche più centralizzate e a più alto livello tecnologico. Quindi il core del capitalismo europeo è misto, e ha tendenze che sono simili a quelle del capitalismo americano, soprattutto del capitalismo estrovertito che, si noti bene, ha ancora interesse a mantenere comunque un fucile puntato contro la Russia – interesse che peraltro ha lo stesso Trump perché il leitmotiv delle sue ultime dichiarazioni si riassume in “andremo verso la pace e rispetteremo le zone di influenza, però questa è zona mia e deve essere armata, preferibilmente armata con i soldi degli altri”.
Il problema è che poi, lo vedrete, si chiederà all’Unione Europea anche di acquistare il debito pubblico americano in sostituzione di quella fetta di debito che i cinesi non acquisteranno più (e che già stanno già diminuendo vorticosamente). Per ora si tratta ancora di ipotesi e previsioni, ma nell’ultima riunione del seminario che stiamo tenendo, dati alla mano, siamo arrivati a vedere che c’è questa possibilità.
Detta fuori dai denti: se vogliamo capire quello che dobbiamo fare noi, dobbiamo partire da quello che succede in Europa. E in Europa ci troviamo in una situazione per cui quello che i geopolitici chiamano “l’incubo di Mackinder” non si realizza.
Halford Mackinder sosteneva una cosa sacrosanta, che forse con il tempo ha mutato di peso però rimane cruciale prestarle attenzione. Non vi ripeto tutta la formula perché poi ci perdiamo (e perché la geopolitica comincia anche a stufarmi… io sono un filosofo, malriuscito, vedi te se mi devo mettere a studiare ‘ste cose. Ma vabbè, dobbiamo farlo). Ve la faccio breve. Lui parlava dal punto di vista inglese, ma vale a maggior ragione anche per gli Stati Uniti: bisogna evitare che si formi la cosiddetta Eurasia, chiamiamola così. Ovviamente non nel senso dell’euroasiatismo di Dugin, quei blateramenti sulla cultura reazionaria russa che si sposa con la cultura reazionaria europea, no. Il problema è molto più prosaico. Se le risorse tecnologiche e finanziarie dell’Europa e dell’Unione Europea intrecciano le risorse energetiche e politico-strategiche più in generale della Russia, gli Stati Uniti cominciano a declinare veramente, perché oltre a un competitore come la Cina, avremo un competitore euroasiatico fortissimo. E quindi devono fare di tutto per impedire che questa cosa si realizzi.
Come si può impedire l’incubo di Mackinder? Come si può impedire l’unione di europei e di russi? In due modi. O fai la guerra insieme agli europei contro i russi, o ti agganci con i russi con il retropensiero di mantenere divisa l’Europa (così come secondo molti studiosi è stato fatto durante la Guerra fredda, perché quello che teneva in piedi l’equilibrio tra i blocchi era la divisione dell’Europa). Trump sta riuscendo a fare entrambe le cose, perché fa in modo che l’Europa di fatto continui a combattere la sua guerra contro la Russia, e nello stesso tempo lui costruisce un patto con la Russia in barba all’Unione Europea. Quindi, insomma, siamo fregati da tutti i lati.
Tra l’altro, non dimentichiamolo, un ulteriore motivo di giustificazione del bellicismo dell’Unione Europea è il modello di sviluppo che si prospetta. Considerate le difficoltà (tecniche, economiche e politiche) di costruire un modello di accumulazione nuovo attraverso la cosiddetta svolta green: cosa c’è di meglio di un bel riarmo per far ripartire tutto? È quello che mi diceva anche la vecchia saggezza degli avversari: io ho lavorato molto con i commercialisti perché come funzionario del tribunale di Torino facevo anche i giri per i fallimenti, e ne ricordo uno che mi diceva: «Caro dottore mio, ma lo sa cosa ci vuole qui? Una bella guerra come quelle che si facevano una volta!» Ed era uno che i conti li sapeva fare; diceva una castroneria, ma non era del tutto una castroneria. A mio modo di vedere, le vostre analisi e le vostre indagini lo stanno dimostrando in maniera chiara. Come si risponde alla crisi dell’automobile? Non con l’auto elettrica; magari si sarebbe potuta fare se fossimo partiti in maniera diversa, “ma adesso non si può”.
Quindi, per vari motivi, direi che la paura della Russia è la spinta del capitalismo americano – ma comunque questo lasciamo aperto come interrogativo, Robert saprà rispondere molto meglio di me. Di certo il problema è che alla fine, comunque la giri, andiamo verso una prospettiva bellica. E che fa l’Italia della prospettiva bellica? Niente! Rispetto a quello che dovrebbe e potrebbe fare, niente. Allora qui si cominciano a vedere le caratteristiche fondamentali di quello che alcuni giustamente chiamano il “sovranismo di cartone” (posto che si riferiscano solo a questo).
Adesso, non mi interessa saggiare quanto la Meloni sia fascista o meno, ma si trova comunque una costante, una caratteristica fondamentale del nostro nazionalismo. Essendo il nostro, come diceva ancora Lenin, un “imperialismo straccione”, mancando cioè le basi economiche e il patto sociale (sia esso consensuale o autoritario) che ci consentano di avere veramente un ruolo protagonistico in situazioni belliche, cosa fa l’Italia? Il nazionalismo italiano è costretto a scegliersi sempre una potenza a cui appoggiarsi; una potenza che alla fine si rivela più feroce, più determinata, più forte di noi, e quindi condiziona la nostra vita ben oltre le nostre intenzioni. Così ha fatto Mussolini con Hitler; così sta facendo la Meloni con Trump. Addirittura “il capitano” Salvini sta cercando di giocare insieme sia con Trump che con Putin in questa partita (con la differenza che la Meloni fa questo sia per vocazione e per calcolo, però al momento sta giocando un ruolo relativamente centrista, perché la destra estrema continua a stare con Salvini; ma ne parliamo dopo).
Cosa sta facendo il governo in questo caso, con questa scelta di Trump come interlocutore fondamentale? Fa quello che l’Italia ha quasi sempre fatto nelle relazioni internazionali, cioè giocare la carta degli Stati Uniti contro la Francia e la Germania, insieme o a turno. Questo è una invariante della politica italiana. Un’invariante che trovavamo anche nei tempi “eroici”, cioè anche di quando, per capirci, Fanfani faceva il neoatlantista e andava in giro per il Mediterraneo a produrre una politica che effettivamente, se poi messe in parallelo con le scelte di Mattei (anche se i due non lavoravano affatto insieme), significava sicuramente un ruolo progressivo per l’Italia. Ma questo ruolo progressivo è stato giocato perché gli americani in quel momento avevano in odio i francesi e gli inglesi in una sorta di prosecuzione della Seconda guerra mondiale e, data la necessità di tenere gli ex imperi con la testa sotto la sabbia, noi italiani gli servivamo per riuscire a controbilanciare nel Mediterraneo la presenza e la potenza degli altri due attori. Dopodiché, come dicono gli avvocati, male captum bene retentum. Però quello è stato l’unico esempio, l’unico momento virtuoso di questo giochino che noi facciamo con gli americani contro gli altri.
Detto ciò, quali sono le strade che sembrano aprirsi all’Italia in questa competizione?
Poca roba. Al momento le alternative sembrano due – a parte l’adesione integrale alla strategia dei padroni americani del passato, che è una situazione veramente imbarazzante. O vedremo una pseudo-mediazione, che è ciò che sta cercando di portare avanti la Meloni – dico “pseudo” perché non è che Trump aspetti la Meloni per imporre qualcosa all’Europa: noi facciamo solo finta di giocare un ruolo diplomatico da cui lucrare qualche titolo di beneficio per tenere insieme la baracca occidentale facendo, diciamo, il trait d’union tra Trump e la Von der Leyen; secondo me è un ruolo che non porta proprio a nulla se non rimanere sia nel solco del bellicismo europeo, sia nel bellicismo trumpiano – o l’altra scelta, per adesso minoritaria, ma non è detto che lo debba essere sempre, è quella di Salvini, cioè la scelta dell’isolamento relativo dall’Unione Europea e dell’utilizzo dell’accordo potenziale tra Stati Uniti e Russia (o meglio tra Trump e Putin) per riuscire a commerciare con entrambi e a mantenere un duplice rapporto, una duplice investitura internazionale che consentirebbe a questo punto al partito che interpretasse questo ruolo di fare un salto avanti all’interno della situazione politica italiana, in particolare se riuscisse a intercettare i malcontenti.
Se vogliamo descrivere la posizione nostra, così come l’ho sommariamente definita, siamo di nuovo ad alcuni vecchi luoghi comuni dell’analisi geopolitica italiana, in particolare ben studiati da Carlo Maria Santoro, a mio modo di vedere uno dei migliori studiosi del nostro paese. Santoro sostiene che storicamente l’Italia oscilla tra il considerarsi del tutto impotente e il sovrastimare le proprie capacità – quindi ondeggiare tra un liberalismo che se ne sta nascosto alla Giolitti, e un Mussolini; tra un Fanfani tronfio, e le altre soluzioni invece molto più timide; tra un Berlusconi e un Letta. Un’altra fluttuazione tipica della geopolitica italiana è quella, figurativamente parlando, tra l’essere isola o penisola – vale a dire tra comportarsi come un soggetto completamente autonomo che trova la propria legittimità geopolitica ed economica nel Mediterraneo, e solo successivamente media con l’Europa, oppure come soggetto che punta essenzialmente sull’Europa continentale e successivamente porta questa sua forza acquisita dalla mediazione europea nel Mediterraneo.
Allora, io per molto tempo ho pensato alla prospettiva mediterranea come quella “che avrebbe potuto”. Ma non siamo più all’epoca dei Moro, dei Fanfani, dei Mattei, e neanche dei Craxi; quell’epoca in cui il Mediterraneo era in qualche modo, tra molte virgolette, un mare nostrum, un mare in cui comunque non c’erano così tanti conflitti di potenza come oggi. Sì, c’erano gli inglesi che comunque hanno sempre lavorato contro di noi, ma questa era una vecchia storia che ormai sembrava superata. Adesso il Mediterraneo non è un territorio dove tu puoi fare affari, dove puoi portare l’economia estera italiana come un modello non colonialistico… Ora il Mediterraneo è un inferno. Il Mediterraneo è un luogo di guerra latente, e di potenziali conflitti enormi. Nel Mediterraneo si scontrano la Francia e la Russia (e lo scontro Francia-Russia è uno dei motivi del bellicismo europeo, perché la Russia sta scalzando posizioni francesi in Africa), c’è la Turchia… In un contesto simile, con le economie dei paesi costieri in grossa difficoltà, crediamo forse di poter costruire una prospettiva italiana autonoma per poi giocarcela all’interno dell’Unione Europea? Io credo che non sia possibile. Oltretutto, se ci si presenta come isola, saremmo, da soli, sulla linea di confine tra Occidente e Russia: in una relazione che oggi è una relazione di, tra virgolette, “avvicinamento”; ma domani, data la turbolenza mondiale, può essere di nuovo una relazione di scontro. A starci nel mezzo, da solo, finisci male.
[Kamo: Facciamo un inciso. Ricordiamo che dopo la sconfitta della Siria assadista, il grosso della forza navale della Russia nel Mediterraneo è confluita dalle basi siriane di Tartus alla Cirenaica libica. Quindi abbiamo la flotta russa davanti alla Sicilia].
Esatto. Tra l’altro, concedetemi una battuta. Io non capisco (o meglio, lo capisco) perché in Italia non ci sia nessun politico che abbia il coraggio di farlo perché tutti hanno paura di fare i nazionalisti “come si deve”. Il punto è questo: ma è possibile che nessuno si alzi a dire alla Meloni: «Ma che coraggio lei parla di nazione quando un suo governo, con lei ministra degli Affari giovanili e l’attuale presidente del Senato come ministro della Difesa, ha provocato all’Italia la più grande sconfitta strategica dopo la Seconda guerra mondiale e cioè la guerra in Libia? Si vede che ci siete abituati!» Il nazionalismo di cartone si misura da lì. La Libia, sotto certi aspetti, è stato un modello per quanto possibile di relazione tra un paese altamente sviluppato e un paese non sviluppato, perché era sostanzialmente imposto da Gheddafi il massimo regime di parità possibile. Era una relazione utile per entrambi, e per noi decisiva. E poi invece siamo arrivati alla situazione di oggi. La soluzione dell’isola oggi non è praticabile.
Ci sarebbe un’altra soluzione – ma non è praticabile oggi per motivi di classe – ed è l’ipotesi di un diverso rapporto all’interno, non dico dell’Unione Europea, ma dell’Europa. Mi riferisco alla costruzione di rapporti intergovernativi fondati sull’idea di neutralità dell’Europa, o comunque dei paesi che facciano parte di questo accordo; un patto che sia anche un accordo di mutuo aiuto economico, perché uno dei problemi fondamentali per costruire una politica progressiva è quello di riuscire ad essere il più possibile indipendenti dai movimenti internazionali di capitale. Per esserlo tu devi costruire un’area economica relativamente chiusa. Il buon Fassina (che è sempre ottimo nelle diagnosi, non così ottimo nelle terapie) ha sempre detto che l’Europa sarebbe una zona economica chiusa perfetta. Chiaro che quando si dice “zona economica chiusa” se ne parla in senso relativo, cioè a un livello di autosufficienza notevole, soprattutto se nel mentre vengono costruiti rapporti paritetici con la Russia e con il Nord Africa. Con questo interscambio energetico, chi ci ammazza? Ebbene, questa cosa non si può fare perché tutti i governi europei attuali invece puntano ad essere il più aperti possibili al mercato internazionale dei capitali, che è il nemico numero uno di qualunque politica non dico comunista ma anche moderatamente riformista.
Io penso, però, che se ci dobbiamo dare una prospettiva, anche per iniziare a muoverci in termini di lotta di classe, è una delle prospettive da discutere. Con “patto intergovernativo” intendo proprio qualcosa che si realizza sostanzialmente al di fuori dell’Unione Europea. Il che non vuol dire necessariamente una rottura: l’Unione Europea è fatta molto più a buchi di quanto si creda. Quando alcuni governi vogliono, le procedure e i meccanismi fondamentali dell’Unione saltano. Quindi c’è un ventaglio di possibilità enorme. Ovvio, non dobbiamo cadere in semplificazioni secche no euro/si euro, dentro l’Unione/fuori dall’Unione, oppure come diceva Luciano Gallino “usciamo dall’euro ma non dall’Ue”… lasciamo stare. Dobbiamo sapere qual è il nostro obiettivo: costruire una zona finanziariamente autonoma e geopoliticamente neutrale. Dopodiché giochiamocela in concreto per vedere come si può realizzare.
Però, chiaramente, una cosa come quella che ho detto io, implicherebbe l’esistenza di “governi popolari”, diciamo così, non solo in Italia ma quantomeno anche in Francia e Germania. Richiederebbe quindi una svolta nei rapporti di classe: il che non c’è, anche perché credo che la destra di oggi sia talmente forte e radicata da potersi intestare, almeno agli inizi, gli eventuali disagi sociali del bellicismo prodotto dall’Unione Europe. Proprio questa sua doppia faccia, che le consente in questo momento di essere addirittura pacifista, potrebbe giocare (e quasi sicuramente giocherà) per coprire ed egemonizzare una parte del disagio sociale che dovesse manifestarsi. Qui sicuramente abbiamo un problema grosso, particolarmente grosso.
Ora, io posso riportarvi soltanto alcune intuizioni e alcune riflessioni che nascono da una ripresa di considerazione su cosa sono stati gli anni Trenta, cioè gli anni che hanno condotto al nazifascismo. C’è una cosa della situazione attuale che colpisce rispetto all’esperienza del nazifascismo: questa è una reazione senza rivoluzione. I nazifascismi sono stati una risposta a una rivoluzione che si era attuata o comunque si era tentata (in Italia con la settimana rossa; in Germania con la Repubblica di Weimar e l’ingresso del partito socialdemocratico e dei sindacati dentro procedure di concertazione, nonostante si rivelerà una strategia fallimentare), quindi si potevano comprendere le ragioni della reazione avversa delle burocrazie militari e dei centri politici. Ma il punto è che allora c’era effettivamente stata un’ondata rivoluzionaria in tutta l’Europa centrale e meridionale. Oggi invece abbiamo una reazione senza che ci sia stata una precedente minaccia rivoluzionaria, e quindi senza l’esistenza di partiti comunisti che da una parte “giustifichino” la reazione, ma che dall’altra possano costituire comunque una base per un’organizzazione a livello nazionale; per non parlare poi dell’assenza di un intermediario geopolitico con una funzione equivalente all’Unione Sovietica dell’epoca.
Allora, oggi cosa ci si presenta? Si dimostra vera una cosa che diceva Otto Bauer, un grande dirigente della socialdemocrazia austriaca che cercò una via “intermedia” tra bolscevismo e riformismo con esiti forse discutibili, ma con riflessioni molto, molto acute. Bauer sosteneva che la reazione nazifascista non si esercitava veramente contro la minaccia della rivoluzione, perché la rivoluzione all’epoca era già sconfitta: la repressione si esercitava piuttosto contro i risultati del riformismo. Il nazifascismo non sopportava i risultati del riformismo; non sopportava il fatto che fossero state fatte in quegli anni concessioni ai lavoratori (anche perché l’alternativa era davvero la rivoluzione); di pari passo, i ceti intermedi che si rivolgevano al nazismo non sopportavano il fatto che mentre gli operai, organizzati e riconosciuti come interlocutori socioeconomici dal governo e dallo Stato, potevano difendersi dall’inflazione grazie ai sindacati, loro non potevano farlo… Insomma, una reazione contro il riformismo o comunque i suoi residui.
Ciò che secondo me osserviamo oggi, soprattutto negli Stati Uniti (in Italia in maniera forse più sfumata, ma la linea rimane la medesima) è una lotta di classe contro il welfare e contro le mediazioni istituzionali; una lotta operata da alcuni ceti che non possono sopravvivere se non riescono a liberarsi delle regole, degli orpelli e della fiscalità che impedisce loro di fare profitto o di sopravvivere in una situazione sempre più difficile dal punto di vista economico. Per esempio, quando Trump se la piglia contro “la cultura woke”, in realtà se la piglia con i programmi di inclusione nei confronti delle minoranze che questi ambienti hanno sempre sposato, oltre che contro il linguaggio con cui vengono formulati. Il punto è l’ostilità contro i residui del welfare, contro le mediazioni istituzionali che controllano in qualche modo l’impresa, contro la fiscalizzazione, contro le tasse, eccetera.
Vi è poi un’altra differenza abbastanza evidente. La lotta contro l’immigrato non è più semplicemente l’individuazione di un capo espiatorio, come un tempo era l’antisemitismo. Le minacce di deportazione di massa – così come i blocchi o le deportazioni dei vari Salvini – non si realizzeranno perché non devono realizzarsi, e non devono realizzarsi perché quella gente lì serve. Le minacce hanno dunque l’obiettivo di terrorizzare questo strato di proletariato e, su tutto, rendergli più difficile richiedere condizioni di lavoro migliori. Di modo che nella divisione tra proletariato, tra mille virgolette, “garantito” e proletariato non garantito il razzismo trumpiano trova un elemento costitutivo.
Per quanto riguarda invece la destra in Germania, le cose sono diverse ancora, perché l’idea di remigrazione investirebbe una marea di lavoratori che in realtà fa già parte del circuito formale e regolare di lavoro. Non si tratta di sottigliezze, ma di differenze cruciali nei processi di soggettivazione che bisogna sapere se giocare e che avranno un grosso peso per la nostra parte.
Un’altra rilevante novità rispetto al nazifascismo dello scorso secolo è che tanto il fascismo italiano quanto il nazismo tedesco, in maniere diverse, consistettero nell’occupazione dello Stato o quantomeno in una sua trasformazione da parte di un movimento politico che comandava sulle strutture statuali tradizionali o si sostituiva ad esse, a seconda delle situazioni. Ciò in gradazioni molto diverse. Interi settori del nazismo furono apertamente nemici dello Stato, troviamo persino dichiarazioni espresse dai nazisti contro l’idea stessa di sovranità (perché la sovranità dello Stato non è accettabile, l’unica sovranità possibile è quella del Führer come espressione del popolo). Il fascismo fu molto più abile: abilissimo fu Mussolini, per esempio, a non consegnare l’Iri ai suoi uomini e lasciarlo a Beneduce, per dare un’idea. Quindi, mentre il fascismo e il nazismo furono quella roba lì, oggi si assiste invece alla occupazione dello Stato non da parte di movimenti politici ma da parte diretta delle imprese e in particolare delle grandi imprese tecnologiche. Negli Stati Uniti la tendenza impressa da questo nuovo corso trumpista è un chiaro tentativo di sostituzione diretta dell’apparato statale con pezzi dell’apparato industriale, il che fa saltare il ruolo di mediazione dello Stato e può essere prodromo di ulteriori conflitti sociali.
Passiamo quindi a un ultimo aspetto, ma non meno determinante nella destra di questi anni, in particolare di quella americana, poiché dimostra ancora una volta di come Trump non possa fare a meno di operare una scelta conflittuale. I vertici statunitensi hanno un chiaro dilemma davanti: come pagare i progetti di reindustrializzazione negli Stati Uniti e quel po’ di welfare che devono comunque concedere alla parte che li vota? Chi caccia i soldi? Ebbene, i soldi li cacciano “gli altri”. I dazi servono a rimpiazzare quelle tasse che il ceto che porta avanti Trump – un ceto di riccastri, che nemmeno ci sogniamo: stando a quanto rilevano i ricercatori olandesi che nominavo prima, l’amministrazione Trump è stata la più ricca amministrazione di tutta la storia degli Stati Uniti – non vuole pagare. Come nelle migliori tradizioni della destra, i conflitti e le tensioni interne vengono scaricati contro il nemico esterno (ora un nemico interno-esterno come l’immigrato, “l’ebreo” del giorno d’oggi, ora contro il nemico esterno tout court come le altre nazioni, alleate o avversarie).
Arriviamo alla conclusione. In questa situazione, noi cosa diavolo possiamo mai fare?
Io penso che abbiamo veramente tantissime cose da fare. Ipotizzando, come dicevo prima, che in condizioni simili almeno la prima ondata di proteste popolari (ammesso che ce ne saranno) nei confronti della guerra verrà intercettata quasi sicuramente dalla destra, ciò non ci esime da abbozzare un elenco di obiettivi.
Per prima cosa, dobbiamo cercare di ridefinire e di riunire quello che dovrebbe essere il nostro fronte, domandandoci cosa sia oggi quello che un tempo chiamavamo proletariato. È l’interrogativo al quale voi di Kamo state tentando di rispondere con l’analisi e con la pratica quotidiana: come si fa a ricostruire un filo conduttore in una classe che al proprio interno dimostra regimi contrattuali, regimi salariali, nonché idee completamente diverse? La classe operaia è una classe fatta oggi di lavoratori dipendenti garantiti, di lavoratori dipendenti precari, di finte partite Iva… Prendiamo un modello di nucleo familiare sempre più diffuso, per provare a capire come vive la gente e come prova a resistere alla crisi: il maschio, il capo, il padre, che si presenta come il breadwinner ed è lavoratore dipendente; la moglie magari ha un negozietto; un figlio è precario; l’altro figlio studia e cerca di fare del lavoretti anche lui. Bene, una famiglia così è interessata all’aumento salariale? È interessata al taglio del cuneo fiscale? È interessata all’evasione? Risposte che non possiamo generalizzare e che testimoniano quanto sia difficile formare una coalizione come quelle che noi avevamo in mente un tempo.
Ma se anche raggiungessimo l’unità del proletariato, resta il problema di come diavolo si riesca a creare un fronte tra questo proletariato e la marea delle piccole e medie imprese. Perché c’è poco da fare, in Italia non si può fare politica “odiando” la piccola media impresa.
Poi, inutile a dirsi, abbiamo il bisogno di costruire un programma. Ma vogliamo un programma per “l’isola” o un programma per “la penisola”? Un programma ottimale o un programma di risulta?
Domande sempre da rinnovare, perché man mano che costruiamo le nostre idee, ci troveremo in una situazione esterna completamente stravolta. C’è un problema fortissimo di organizzazione, qui ci sarebbe da parlare per una vita sul modello del partito e via discorrendo: io mi limito solo a dire che dovremo cercare di uscire dalla forma-social. La modalità social è un disastro, perché ti dà l’illusione della connessione mentre in realtà la impedisce.
Però, e finisco con questo, in realtà la cosa più importante che dobbiamo costruire per cercare sia di riaggregare un soggetto, sia di motivare noi stessi, è un’idea. E ve lo dico da materialista. Una delle più grandi cose che diceva Lucrezio nel De rerum naturae era che i pesci non nascono sugli alberi di mele. Le idee non derivano solo dal disagio socialista o solo dal conflitto: le idee derivano anche dalle idee, derivano dalla battaglia ideale fatta con i materiali ideali presenti contro determinate idee presenti. Allora, rimanendo fermo il fatto che se non costruiamo una prospettiva socialista, secondo me non andiamo avanti, anche perché il capitalismo non è che stia entrando “nella sua fase finale”. Se noi non riprendiamo un discorso sul socialismo non faremo un solo passo avanti.
Ma c’è un altro discorso che possiamo proporre come idea unificante: il rapporto tra la lotta di classe e l’idea di nazione, intendendo con essa una nazione democratica. C’è un dato di fatto obiettivo: ipotizziamo che stiamo facendo il migliore ciclo di lotta di classe mai visto in Italia; si costruisce un governo popolare; può questo fare una qualunque politica senza avere un’idea di quello che è l’interesse nazionale definito, sia chiaro, dal punto di vista dei lavoratori e la posizione geopolitica del paese? Può farlo? No. Si può raggiungere un’idea di interesse nazionale senza partire da se stessi, cioè rivendicando la propria sovranità non come arma contro le altre nazioni, ma come punto di partenza per una libera rinegoziazione dei rapporti internazionali?
È un punto delicato e scivoloso, ma con cui prima o poi toccherà fare i conti. D’altro canto, secondo me, senza una dinamica di lotta popolare che aumenti la base sociale interessata a un processo trasformativo, nessuna delle forze sociale presenti in Italia è in grado di proporre da sola una dignitosa alternativa politica che non sia regressiva. Non lo possono fare le classi rappresentate dalla Meloni, non lo possono fare i nuclei più forti del capitalismo italiano (che guarda caso sono nuclei bancari, quindi interessati al capitalismo transnazionale). Io penso che oggi uno dei pochi elementi capaci di rinfocolare gli individui a riorganizzare un’identità collettiva contro i rapporti di sfruttamento possa essere quello di farli sentire come membri, cittadini di una repubblica democratica, dentro la quale possono trovare gli elementi di potere che gli consentono di contrastare gli avversari di classe.
Uno stretto (anche se mi rendo conto quanto delicato) circolo virtuoso tra lotta di classe e nazione potrebbe essere una delle idee unificanti di un proletariato, il quale altrimenti, secondo me, rischia di essere preda di altre forze.
Alcune domande della discussione
– Come interpreti la piazza che è stata chiamata il 15 marzo da Michele Serra, alla quale hanno aderito tutte le organizzazioni della sinistra liberalprogressista, dalle vecchie catene di trasmissione della Cgil e dei sindacati, al Partito Democratico e all’Arcigay? Una piazza oggettivamente interventista, ma che a differenza degli interventisti del ‘15-‘18 non crediamo sia composta da una composizione che sbava per combattere. Almeno i guerrafondai del 1915 erano coerenti: si sono tutti arruolati – e poi gran parte morti. Questi invece chiamano la guerra, partono da ideali e da slogan di per sé abbastanza vuoti per muovere l’Italia verso un impegno sempre più diretto, ma hanno dietro un blocco sociale? Cioè quali sono i ceti interessati a queste iniziative? Hanno dietro di sé porzioni sociali di peso, o invece si risolve tutto in utile idiotismo? Te lo chiediamo perché oggettivamente la svolta estera di Trump e l’accelerazione che ha impresso alle dinamiche internazionali hanno in qualche modo ribaltato un quadro politico, quantomeno in Europa. Vediamo infatti i liberalprogressisti da sempre culo e camicia con l’America che guardano Trump come il nemico numero uno; vediamo pezzi della Lega, specialmente quelli che compongono la base produttiva delle regioni in cui la Lega è stata per tanto tempo egemone, invece riscoprirsi estremamente europeisti. Giorgetti un po’ rappresenta a livello governativo l’espressione politica delle piccole e medie imprese, come dicevamo prima, estremamente legate alle catene del valore globale e soprattutto tedesche. In Emilia gli interessi di questo ceto li cura il PD, che ha mandato anche Bonaccini in Europ,a e lui lì a curare interessi appunto della Pmi emiliana. Trump insomma ha innescato tutta una serie di contraddizioni, che possono sembrare ribaltamenti ma sono invece sostanzialmente chiarificazioni.
– Andando un po’ più al profondo dei processi, questo passaggio al warfare può passare solo attraverso la distruzione del welfare, oppure può tirarsi dietro in qualche modo anche uno scambio con la classi popolari? Perché se passiamo al warfare, quindi a un’economia di guerra, ci deve essere qualcuno però a combatterla questa guerra, e per prima cosa appunto servono gli uomini e donne a combatterla, serve una popolazione soprattutto giovane che l’Italia e l’Europa non ha assolutamente, una popolazione quantomeno in salute, quindi il welfare è sempre stato storicamente alla guerra, attraverso il peso politico che hanno potuto avanzare le classi popolari, la classe operaia in guerra si è tirata dietro il welfare. Pensiamo al piano Beveridge, per garantirsi l’appoggio e i sacrifici delle classi popolari, del fronte interno, ha dovuto garantire in qualche modo un tornaconto a livello sociale, di protezione. Pensiamo anche all’Unione Sovietica. Il popolo sovietico non crediamo abbia patito quasi 30 milioni di caduti per salvare i piani quinquennali. C’è stata sicuramente una riscoperta anche di un’idea patriottica, ma soprattutto, secondo noi, c’era un patto sociale interno all’Unione Sovietica – le conquiste della rivoluzione, il potere degli operai e dei contadini che garantivano un certo grado di autonomia nei luoghi di lavoro, un certo grado di potere sociale e quindi con tutte le allocazioni del caso in un fatto di politiche abitative, politiche sanitarie, politiche di welfare, di costituzione sociale – che ha garantito la tenuta di fronte alla peggiore guerra di sterminio mai lanciata in Europa. Questo passaggio al warfare può portarsi dietro un nuovo patto sociale con qualche grado di condizioni positive per segmenti di classe operaia, o oggettivamente può solo abbassare, affossare invece la loro condizione? Ci sono contraddizioni legate alla riconversione industriale, alla possibilità di un nuovo ciclo di sviluppo, alle commesse, che servono per capire dove potrà andare anche la lotta di classe.